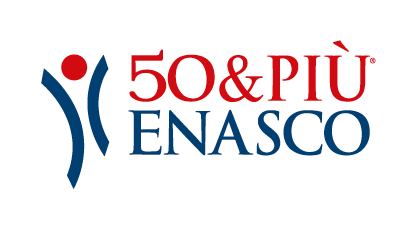Il testo integrale del Libro bianco sul lavoro
Il testo integrale del Libro bianco sul lavoro
Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità
Presentazione
Questo Libro Bianco è finalizzato a rendere partecipi tutti gli attori istituzionali e sociali delle riflessioni che il Governo ha svolto in vista di un confronto finalizzato a ricercare soluzioni confortate dal più ampio consenso.
Questi diversi interlocutori sono ora invitati a valutare il Libro Bianco, sia nella sua dimensione analitica sia nella prospettiva propositiva e progettuale. Il Governo procederà all’organizzazione di sedi di confronto per l’approfondimento delle singole tematiche, al fine di conseguire una migliore comprensione dei reciproci punti di vista e di pervenire, auspicabilmente, a specifiche intese.
Al termine del confronto il Governo si riserva di valutare i punti di intesa realizzati e quelli per i quali eventualmente non si sia registrata una significativa convergenza di analisi e di proposte. In entrambi i casi si terrà ampio conto dei risultati di questo esercizio nella fase successiva di predisposizione di iniziative legislative da presentare al Parlamento.
Il Governo si propone così di innovare nella metodologia del confronto prima ancora che nella stessa portata dei contenuti. Ciò appare necessario alla luce delle esperienze più recenti di dialogo sociale in Italia. Dopo i grandi accordi del 1984, del 1992 e del 1993, il confronto tra istituzioni e parti sociali è parso declinare verso forme rituali e inefficaci.
Il Consiglio Europeo di Lisbona e il successivo Consiglio Europeo di Stoccolma hanno stabilito che l’Unione Europea deve conseguire nel corso del prossimo decennio una crescita economica sostenibile capace di garantire un aumento sostanziale del tasso di occupazione, di migliorare la qualità del lavoro e di ottenere una più solida coesione sociale. L’Italia in particolare ha molte ragioni per raccogliere questa sfida.
L’Italia è infatti il paese europeo con il più basso tasso di occupazione generale e femminile in particolare, il più alto livello di disoccupazione di lungo periodo, il più marcato divario territoriale. Le Raccomandazioni rivolte all’Italia dall’Unione Europea nell’ambito del processo di Lussemburgo hanno sottolineato, ormai dal 1998, l’insufficienza delle politiche fin qui attuate e la mancanza di interventi in grado di migliorare sostanzialmente le caratteristiche del suo mercato del lavoro. Per questo motivo, partendo proprio dagli orientamenti europei, il Governo intende procedere, con la presentazione di questo Libro Bianco, ad un programma di legislatura, orientato alla promozione di una società attiva, ove maggiori siano le possibilità di occupazione per tutti, migliore sia la qualità complessiva dei lavori, più moderne le regole che presiedono all’organizzazione dei rapporti e dei mercati del lavoro.
La strada per avvicinare l’obiettivo europeo di un tasso di occupazione attorno al 70% nel 2010, con il quale si realizza una condizione di largo impiego del capitale umano, è lunga e tortuosa. A questo obiettivo devono concorrere vari fattori: dalla più intensa partecipazione dei giovani, delle donne e degli anziani al mercato del lavoro, ad una migliore integrazione dei disabili, all’ulteriore diffusione del lavoro autonomo e di ogni forma di autoimpiego, all’emersione di tutte le forme di lavoro irregolare, con particolare attenzione alla situazione del Mezzogiorno
Peraltro, le azioni che si vogliono promuovere attraverso le proposte contenute nel Libro Bianco non sostituiscono gli strumenti di politica economica, di politica fiscale e di politica industriale volti a garantire un percorso di crescita sostenuta. In particolare, il documento qui presentato è definito in coerenza con l’obiettivo di una progressiva riduzione degli oneri fiscali e contributivi che gravano sul lavoro, leva non secondaria per l’incremento dell’occupazione e per migliorare le condizioni dei lavoratori meno retribuiti. Analoga coerenza è stabilita con le linee di riforma del sistema previdenziale. L’innalzamento del tasso di occupazione determina un ampliamento della base dei contribuenti, concorrendo così a ridurre l’impatto negativo derivante dalle tendenze demografiche in atto. Le politiche del lavoro, qui identificate, hanno quindi lo specifico compito di rimuovere quegli ostacoli economici o normativi che riducono l’intensità occupazionale della crescita economica, soprattutto nel Mezzogiorno.
Nella definizione di nuove ipotesi di regolazione abbiamo assunto congiuntamente i criteri della flessibilità e della sicurezza superando quella sterile contrapposizione tra approcci ideologici che ha determinato la paralisi o il fallimento di molte riforme.
Le politiche del lavoro non possono poi prescindere dalle caratteristiche e dalle differenze dei relativi mercati del lavoro locali in un Paese dai grandi contrasti. Occorre costruire un quadro di riferimento generale all’interno del quale possano essere adottate misure differenti per realtà diverse, riconoscendo e valorizzando le diversità e specificità delle dimensioni regionali, proprio allo scopo di ricomporre ogni dualismo. Appare quindi importante, ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati, realizzare il federalismo anche in materia di mercati e rapporti di lavoro.
Le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori sono attori essenziali del dialogo sociale, la cui autonomia responsabile il Governo vuole valorizzare con il frequente rinvio al loro diretto negoziato in un disegno di sussidiarietà orizzontale. Esse sono anche il veicolo per una crescente responsabilità delle imprese - attraverso strumenti di autodisciplina - e dei lavoratori, attraverso istituti referendari e partecipativi.
Queste politiche sono orientate dai valori dell’economia sociale di mercato, dai principi fondamentali del lavoro che ormai compongono l’acquis communaitaire, nonché ovviamente dalle indicazioni fondamentali provenienti dalle convenzioni e raccomandazioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro per uno sviluppo globale socialmente sostenibile. Ciò nel pieno rispetto dei precetti fondamentali rinvenibili nella stessa Costituzione italiana e nell’elaborazione pluridecennale della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
– Roberto Maroni
***
Executive Summary
Le difficoltà del mercato del lavoro italiano
La maggiore correlazione tra crescita del prodotto e crescita dell’occupazione nonché la maggiore diffusione del lavoro atipico, dovute alle misure di flessibilità introdotte a partire dal 1997, dimostrano come vi siano le condizioni affinché anche in Italia possa crearsi un mercato del lavoro dinamico, efficiente ed equo.
Tuttavia, l’Italia, con un tasso di occupazione che nel 2000 è ancora al 53,5%, sconta un ritardo pesante rispetto a tutti gli altri paesi europei. La causa principale del gap italiano è ascrivibile al Mezzogiorno, che dista dagli attuali livelli medi UE di oltre venti punti percentuali sia per il totale sia per la componente femminile. Nondimeno, anche nelle regioni del Centro-Nord i livelli occupazionali rimangono inferiori rispetto ai livelli medi dell’UE (59,9% contro 63,3% per il totale e 48% contro 53,4% per la componente femminile).
Il divario territoriale deve essere sommato ai problemi di carattere generazionale. Le prospettive dei giovani per un rapido accesso al mercato del lavoro, pure se migliorate negli ultimi anni grazie alle maggiori flessibilità disponibili appaiono ancora contraddistinte da difficili processi di transizione dalla scuola al lavoro, dal lavoro alla formazione e dalla formazione al lavoro. I lavoratori anziani, penalizzati dagli scarsi incentivi alla prosecuzione dell’attività lavorativa e che non appaiono beneficiare delle tipologie contrattuali flessibili adottate, continuano a ridurre la loro quota ufficiale nella popolazione lavorativa. Le donne, per le quali la crescita occupazionale nell’ultimo quinquennio è stata più consistente, specie nel Centro-Nord, continuano a soffrire di una difficile condizione di accesso e di permanenza sul mercato del lavoro.
Il tasso di disoccupazione in Italia si è progressivamente ridotto e si presume che continui a ridursi anche nei prossimi anni. Tuttavia, esiste un grave problema di disoccupazione di lunga durata: il tasso di disoccupazione di questo segmento è, infatti, pari all’8,3%, mentre la media europea si posiziona al 4,9%. Ciò testimonia l’inefficacia delle azioni preventive e il rischio di esclusione sociale da parte di coloro che perdono il posto di lavoro.
Per questo motivo la combinazione tra azioni di contesto atte ad innescare processi di allargamento della base produttiva e di innalzamento della produttività, introduzione di flessibilità nel mercato del lavoro, fuoriuscita dal sommerso, appare come una strategia interconnessa, capace di innescare sviluppo economico e crescita dell’occupazione regolare. Esistono, dunque, grandi opportunità che devono essere sfruttate e situazioni che possono essere migliorate, attuando politiche del lavoro e politiche macroeconomiche che spingano dal lato dell’offerta come dal lato della domanda, anche in un contesto macroeconomico congiunturalmente difficile.
Se creare più posti ed occasioni di lavoro rappresenta l’ambizioso traguardo dei prossimi anni, occorre, tuttavia, anche migliorare la qualità del lavoro. In Italia, la qualità “non buona” del lavoro è insita nei differenziali occupazionali ma, soprattutto, nell’ampia fascia di lavoro sommerso, irregolare e clandestino che contribuisce a creare condizioni di esclusione sociale e di sottoutilizzo di capitale umano. Un mercato del lavoro flessibile deve migliorare la qualità, oltre che la quantità dei posti di lavoro, rendere più fluido l’incontro tra obiettivi e desideri delle imprese e dei lavoratori e consentire ai singoli individui di cogliere le opportunità lavorative più proficue, evitando che essi rimangano intrappolati in situazioni a rischio di forte esclusione sociale.
La criticità delle politiche praticate
La struttura della spesa sociale italiana denota un’accentuata caratterizzazione pensionistica ed una bassa incidenza dei trattamenti di disoccupazione e di quelli assistenziali a favore di soggetti in età lavorativa (invalidità, famiglia, abitazione e assistenza sociale in senso proprio). Ciò è il risultato di rigidità nella regolamentazione dei rapporti di lavoro ed in particolare del prevalere della tutela dei rapporti in essere. Inoltre, permane l’assenza di interventi strutturali che favoriscano la domanda e l’offerta di lavoro dei soggetti a più basso reddito e di schemi di incentivazione che possano attenuare possibili effetti di povertà nelle fasce cosiddette a rischio della popolazione.
Le esperienze dei paesi europei che hanno con più successo riformato il mercato del lavoro, mostrano quanto sia importante disporre anche in Italia di un nuovo assetto della regolazione e del sistema di incentivi e ammortizzatori, che concorra a realizzare un bilanciamento tra flessibilità e sicurezza. Tale sistema deve avere come obiettivo ultimo quello di accrescere l’occupazione e di diminuire le forme di precarizzazione, evitando il sorgere di pericolose fratture sociali tra generazioni, caratterizzate da segmenti più giovani che trovano accesso al mercato del lavoro con contratti flessibili e popolazione meno giovane e dinamica che rimane con contratti tradizionali da lavoro dipendente.
Istituzioni, centrali e locali, e parti sociali sono chiamate a disegnare un sistema di politiche del lavoro basato non più sul singolo posto di lavoro bensì sull’occupabilità e sul mercato del lavoro. In Italia, un efficace funzionamento del mercato del lavoro è anche impedito dall’inefficiente incontro tra domanda e offerta. Solo il 4% di chi trova lavoro passa attraverso il servizio pubblico all’impiego, mentre gli operatori privati non decollano a causa degli ostacoli normativi oggi esistenti ed è ancora assente un adeguato sistema informativo basato su standard accettativi che favoriscono un rapido incontro tra i fabbisogni, i servizi, le soluzioni contrattuali.
Gli strumenti per una società attiva
Le azioni per accrescere il tasso di occupazione si devono sviluppare coerentemente con la Strategia Europea per l’Occupazione prevista dal processo di Lussemburgo. Si tratta di adattare il metodo del “coordinamento aperto” al nuovo quadro istituzionale che si sta delineando in Italia e che affida alle Regioni e agli enti locali una più forte responsabilità politica. Definizione degli obiettivi generali, monitoraggio dello stato di attuazione delle politiche, valutazione dei risultati raggiunti, scambio di buone pratiche rappresentano gli elementi portanti di un nuovo metodo che il Governo, d’intesa con tutti gli attori interessati, intende varare.
Peraltro, il nuovo assetto federale, che interessa anche la regolazione del mercato e dei rapporti di lavoro, può valorizzare questo metodo di intervento. La potestà legislativa concorrente delle Regioni riguarda non soltanto il mercato del lavoro bensì anche la regolazione dei rapporti di lavoro. Il legislatore nazionale, nel dialogo con Regioni e parti sociali, dovrà intervenire con una normativa-cornice, ma poi spetterà alle singole realtà territoriali costruire un impianto regolatorio che valorizzi le diversità dei mercati del lavoro locali e superi l’attuale stratificazione dell’ordinamento giuridico.
Accanto ad una rafforzata sussidiarietà verticale, occorre riqualificare la responsabilità decisionale delle parti sociali e garantire un’efficace sussidiarietà orizzontale. Il modello del dialogo sociale, così come regolamentato e sperimentato a livello comunitario, costituisce il punto di riferimento più convincente per una rinnovata metodologia nei rapporti fra istituzioni e parti sociali anche a livello interno. Il confronto tra istituzioni e parti sociali deve essere configurato come uno strumento volto a conseguire accordi progressivi tali da essere tradotti rapidamente in politiche orientate ad obiettivi quantificati e perciò monitorabili. Trattative globali si concludono talora con accordi globali generici e di difficile implementazione, così come accaduto nel corso della seconda metà degli anni novanta.
Al dialogo sociale, come dispone il Trattato dell’Unione Europea, spetta il compito primario di trasposizione delle direttive comunitarie, soprattutto quando esse derivino dal dialogo sociale comunitario. Tuttavia, la necessità di modernizzare il mercato del lavoro esige che la qualità del processo traspositivo sia alta ed eviti di introdurre surrettiziamente elementi distorsivi della concorrenza – anche a danno del Paese che recepisce - che la direttiva europea intende rimuovere. Inoltre, non deve essere trascurato il fatto che il processo traspositivo deve tenere conto delle caratteristiche dei mercati del lavoro locali, nel quadro del nuovo ordinamento federalista.
I mutamenti che intervengono nell’organizzazione del lavoro e la crescente spinta verso una valorizzazione delle capacità dell’individuo stanno trasformando il rapporto di lavoro. Ciò induce a sperimentate nuove forme di regolazione, rendendo possibili assetti regolatori effettivamente conformi agli interessi del singolo lavoratore ed alle specifiche aspettative in lui riposte dal datore di lavoro, nel contesto d’un adeguato controllo sociale. Dal punto di vista della contrattazione collettiva questo può significare un rafforzamento del suo ruolo premiale, come nel caso della direttiva CAE; dal punto di vista della normativa, l’introduzione di “norme leggere”, che mirino ad orientare l’attività dei soggetti destinatari in relazione agli obiettivi piuttosto che ai comportamenti. L’ordinamento giuridico deve essere sempre più basato sul management by objectives piuttosto che sul management by regulation.
La maggiore “leggerezza” delle norme comporta anche una migliore organizzazione del sistema normativo che passi, da un lato, attraverso la redazione di un Testo unico sul lavoro volto a semplificare e chiarire il complessivo assetto regolatorio; dall’altro, con la predisposizione di uno “Statuto dei lavori”, che operi un’opportuna rimodulazione delle tutele in ragione delle materie considerate, fermo restando un corpus di regole fondamentali applicabili a tutti i rapporti di lavoro.
La riforma degli strumenti non può prescindere da un solido intervento sulla giustizia del lavoro. I tempi di celebrazione dei processi, risolvendosi in sostanza nel diniego della giustizia stessa, sottolineano il grave stato in cui versa la giustizia del lavoro in Italia. Un efficiente mercato del lavoro necessita di tempi di risoluzione delle controversie sufficientemente rapidi. Occorre trovare nuove forme di amministrazione della giustizia, guardando alle esperienze europee, quale l’istituzione di collegi arbitrali che siano in grado di dirimere la controversia in tempi sufficientemente rapidi.
Dotarsi di nuove regole non significa necessariamente approvare nuove leggi. Significa, dunque, sperimentare anche codici volontari di comportamento nella logica di una “responsabilità sociale” delle imprese, come indicato dal recente Libro Verde della Commissione Europea.
Le politiche per una maggiore e migliore occupazione
La società attiva è il contesto necessario per lo sviluppo delle risorse umane. La qualità del lavoro è la nuova dimensione su cui riflettere. Il Governo ritiene che sia necessario attivare misure finalizzate ad elevare la qualità del nostro mercato del lavoro, tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità della situazione italiana. In Italia, la prima politica volta a garantire un lavoro di qualità è quella rivolta all’emersione e al contrasto dell’economia sommersa, cui il Governo ha dedicato immediatamente una “terapia d’urto”, che questo Libro Bianco intende ulteriormente sostenere.
Il conseguimento di una maggiore occupazione non dipende esclusivamente dalle politiche del lavoro qui delineate. Esse, tuttavia, devono assicurare che la crescita economica possa essere pienamente sfruttata, accrescendo le possibilità occupazionali degli individui ed aumentando l’intensità occupazionale dello sviluppo economico. A questo fine deve essere rafforzata la capacità di funzionamento efficiente del mercato, liberandolo dalle inefficienze economiche e normative che hanno nel corso degli anni ostacolato il pieno dispiegarsi delle sue potenzialità. Ciò, ovviamente, non dovrà avvenire restringendo le tutele e le protezioni, bensì spostandole dalla garanzia del posto di lavoro all’assicurazione di una piena occupabilità durante tutta la vita lavorativa, riducendo, quindi, i periodi di disoccupazione o di spreco di capitale umano.
In questo quadro, diverse sono le azioni che vengono proposte. Anzitutto, appare necessario imprimere una decisa accelerazione alle misure che possano favorire un efficiente ed equo incontro tra domanda e offerta. Da un lato, raccogliendo le indicazioni dell’Unione Europea, si deve proseguire con determinazione nella modernizzazione dei servizi pubblici per l’impiego, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province. Dall’altro, si deve agire affinché si fondi stabilmente un sistema maggiormente concorrenziale fra pubblico e privato, rivedendo pienamente la normativa introdotta per regolare il ruolo degli operatori privati che si occupano a vario titolo della mediazione tra domanda e offerta di lavoro e favorendo la diffusione di operatori privati polifunzionali.
In secondo luogo, appare urgente intervenire sulle transizioni scuola-lavoro-formazione. Ciò può essere assicurato innalzando la qualità dell’offerta formativa con azioni dal lato della domanda, ma anche con un rinnovato intervento pubblico, perché lasciato a se stesso il mercato non riesce a dare i risultati migliori. Peraltro, così come si finanzia con risorse pubbliche il processo di innovazione, altrettanto si deve fare con la formazione continua, sostenendone la domanda. Nel contempo, Governo e parti sociali devono intraprendere una sostanziale riforma dei contratti a causa mista, soprattutto in riferimento allo strumento dell’apprendistato, approfondendo gli aspetti della quantità e della qualità della formazione esterna ai luoghi di lavoro. In tale quadro, l’apprendistato può essere valorizzato come strumento formativo per il mercato, mentre il contratto di formazione-lavoro può essere concepito come strumento per realizzare un inserimento mirato del lavoratore in azienda.
In terzo luogo, si deve procedere alla costituzione di un sistema di politiche che intervenga in maniera attiva e preventiva, riformando profondamente ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione. Tale riforma, poiché appare in stretto collegamento con il riequilibrio complessivo della spesa per protezione sociale, dovrà procedere in maniera graduale man mano che le risorse finanziarie necessarie si renderanno effettivamente disponibili. Inoltre occorre tenere presente che essa si inserisce nell’azione di riduzione progressiva del carico fiscale e contributivo gravante sul lavoro. Un importante elemento qualitativo risiederà nel coinvolgimento del beneficiario, che dovrà ricercare attivamente un’occupazione secondo un percorso che può avere anche natura formativa, da concordare preventivamente con i servizi pubblici per l’impiego. Peraltro, anche se si preferiranno strumenti automatici, tanto nel caso delle misure passive quanto in quello delle misure attive, i servizi per l’impiego, pubblici e privati, dovranno operare nel senso della prevenzione di abusi e di aumento della selettività effettiva di determinati strumenti, promuovendone il ricorso effettivo tra i soggetti più deboli.
La scarsa partecipazione delle donne nel mercato del lavoro italiano rappresenta, come già ricordato, una situazione di fortissimo ritardo del nostro paese rispetto agli standard europei. Le politiche del lavoro che saranno adottate dovranno tenere conto di questa peculiarità e dovranno anzitutto rimuovere tutti quei fattori esterni al lavoro che influenzano negativamente la decisione delle donne di iniziare un’attività lavorativa. Inoltre, occorre effettuare uno sforzo di ripensamento complessivo di tutte le politiche nella prospettiva di rafforzare le opportunità di lavoro e di carriera delle donne. Si tratta di agire non solo dunque per ragioni di equità sociale ma anche per un miglioramento dell’efficacia del mercato del lavoro e della sua qualità.
Avvicinare la domanda e l’offerta di lavoro è una delle scelte di fondo a cui si ispira il Libro Bianco. Tale principio va applicato anche ai fenomeni di immigrazione che l’Italia ha finora subito, senza essere in grado di programmare in maniera adeguata. Come recenti indagini hanno confermato, un’immigrazione non controllata rischia di abbassare la qualità del mercato del lavoro, poiché concorre ad alimentare l’economia sommersa. Inoltre, essa genera pericolose frizioni sul piano sociale e dell’accesso ai diritti di cittadinanza principali. Il disegno di legge predisposto e le successive misure, coniugando strettamente contratto di lavoro e permesso di soggiorno possono concorrere alla definizione di un mercato del lavoro più trasparente ed efficiente, che inserisca pienamente i lavoratori extracomunitari nel lavoro regolare, assicurando una prioritaria attenzione ai lavoratori extracomunitari già iscritti nelle liste dei servizi pubblici per l’impiego ed ancora in cerca di un’occupazione garantendo così le condizioni per una pacifica convivenza sociale. La diffusione del lavoro autonomo tra gli immigrati può concorrere a perpetuare mestieri altrimenti destinati a scomparire nonché a favorire i processi di integrazione sociale.
Flessibilità e sicurezza
Mercato e organizzazione del lavoro si stanno evolvendo con crescente velocità. Non altrettanto avviene per i rapporti di lavoro: il sistema regolativo ancor oggi utilizzato in Italia non è più in grado di cogliere e governare la trasformazione in atto. Assai più che semplice titolare di un “rapporto di lavoro”, il prestatore di oggi e, soprattutto, di domani, è un collaboratore che opera all’interno di un “ciclo”. Si tratti di un progetto, di una missione, di un incarico, di una fase dell’attività produttiva o della sua vita. Il percorso lavorativo è segnato da cicli in cui si possono alternare fasi di lavoro dipendente ed autonomo, in ipotesi intervallati da forme intermedie e/o da periodi di formazione e riqualificazione professionale. Il quadro giuridico-istituzionale ed i rapporti costruiti dalle parti sociali, quindi il diritto del lavoro e le relazioni industriali, devono cogliere queste trasformazioni in divenire, agevolandone il governo.
Il mercato del lavoro italiano necessita, quindi, di importanti modifiche al suo apparato regolatorio, procedendo organicamente ad una modernizzazione dell’organizzazione e dei rapporti di lavoro, auspicabilmente d’intesa con le parti sociali. L’introduzione della nuova normativa sul contratto a termine rappresenta un primo esempio di queste azioni.
Il miglioramento qualitativo del rapporto di lavoro deve avvenire mediante un uso corretto del contratto di lavoro a tempo indeterminato, evitando che si diffondano flessibilità in entrata per aggirare i vincoli o le tutele predisposte per la flessibilità in uscita. Pertanto, appare importante incentivarne l’utilizzo, con particolare riguardo alla trasformazione del contratto a termine, nonché superare gli eventuali ostacoli normativi che frenano il ricorso a questa tipologia contrattuale, senz’altro fondamentale per garantire una società attiva basata sulla qualità del lavoro.
Interventi correttivi appaiono urgenti per eliminare quegli ostacoli normativi che ancora rendono complicato l’utilizzo delle tipologie contrattuali flessibili, che sono state utilizzate in larga misura in tutti i paesi europei senza che questo abbia comportato situazioni di esclusione sociale o di bassa qualità del lavoro. In questo ambito, il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere reso più usufruibile, intervenendo sulle cosiddette “clausole elastiche” e sull’istituto della “denuncia”. Il contratto interinale, la cui disciplina deve essere coordinata con quella del lavoro temporaneo, deve migliorare la sua funzione di strumento che favorisce l’incontro tra domanda e offerta. Più in generale, appare opportuno avviare una riforma complessiva della disciplina in materia di intermediazione di manodopera, anche alla luce dei processi di esternalizzazione del lavoro e nel rispetto delle condizioni di tutela del lavoro.
D’altro lato, occorre prevedere nuove tipologie contrattuali che abbiano la funzione di “ripulire” il mercato del lavoro dall’improprio utilizzo di alcuni strumenti oggi esistenti, in funzione elusiva o frodatoria della legislazione posta a tutela del lavoro subordinato, e che, nel contempo, tengano conto delle mutate esigenze produttive ed organizzative. In questa ottica, si segnala la proposta di introdurre il “lavoro intermittente”, consentendo a numerosi soggetti di percepire un compenso minimo per la propria disponibilità, aumentando poi l’ effettiva retribuzione in ragione dell’ orario effettivamente richiesto, nonché della prospettazione del lavoro a progetto, come forma di lavoro autonomo parasubordinato in cui rileva fortemente il fattore della realizzazione appunto di un progetto avente precisi requisiti in termini di quantificazione temporale ma anche di qualità della prestazione. Questi interventi sono finalizzati a bonificare il mercato del lavoro dalle collaborazioni coordinate e continuative, spesso fonte di abusi frodatori.
Un moderno sistema di relazioni industriali
In Italia, più che in tutti i maggiori paesi europei esiste una fortissima dispersione territoriale dei tassi di disoccupazione associata ad una quasi omogeneità territoriale dei livelli salariali. Siamo un paese molto “egualitario” in politica salariale, ma molto disuguale dal punto di vista delle condizioni del mercato del lavoro.
Questa situazione appare il risultato anche di un sistema di contrattazione collettiva che mantiene caratteristiche di centralizzazione inadatte ad assicurare una flessibilità della struttura salariale, che sia capace di adeguarsi ai differenziali di produttività e di rispondere ai diversi disequilibri del mercato. Lo scarso legame esistente tra produttività aziendale e condizioni del mercato locale del lavoro, da un lato, e retribuzioni, dall’altro, si traduce in più bassi livelli occupazionali. A questo si aggiunga che la scarsa crescita, l’alta disoccupazione, l’elevato carico fiscale e lo stesso modello contrattuale definito dagli Accordi del 1992-1993 - sopravvissuto alle condizioni per le quali fu concepito - hanno portato ad un’evoluzione poco lusinghiera dei salari reali al netto delle imposte, anche grazie alla crescita della pressione fiscale sul lavoro.
La crescita del tasso di occupazione e la riduzione del divario occupazionale tra Nord e Sud possono essere determinati anche dalla mobilità delle persone e delle imprese, stimolata da una più accentuata differenziazione dei rispettivi salari reali.
Appare opportuno, dunque, che le parti sociali anzitutto, e le istituzioni nazionali e locali, in quanto datori di lavoro, considerino l’opportunità di rivisitare l’attuale assetto contrattuale, al fine di dotarlo di una maggiore flessibilità. Ciò può avvenire rafforzando la contrattazione decentrata, e legandola in maniera più stretta ai luoghi in cui si determinano i guadagni di produttività, anche considerando le condizioni specifiche del mercato del lavoro.
In tutta Europa si è avuta un’evoluzione partecipativa delle relazioni industriali, nella convinzione che questo potesse contribuire ad accrescere le potenzialità competitive dell’azienda e dell’intero sistema economico del paese. In questo quadro, anche in Italia, di fronte alle sfide che si prospettano, di modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, di competitività, di valorizzazione del capitale umano, i rapporti tra le parti sociali si devono sviluppare in senso sempre più partecipativo, in particolare, ma non solo, nel processo di trasposizione delle direttive comunitarie. Un primo importante obiettivo riguarda la direttiva sulla Società Europea, che dovrà individuare le sedi e le altre modalità per regolare convenientemente i diritti di informazione e consultazione, ispirando l’esercizio delle prerogative manageriali ad una logica di trasparenza e di fiducia tra le parti. Tuttavia, un maggiore sviluppo della dimensione partecipativa potrà riguardare il tema della partecipazione finanziaria dei lavoratori, ed in particolare del cosiddetto azionariato dei dipendenti.
Nel corso del decennio appena trascorso il ricorso allo sciopero quale forma di regolazione del conflitto tra le parti ha subito una progressiva perdita di importanza. Tuttavia, ciò è avvenuto soprattutto nel settore industriale, mentre comportamenti irrispettosi delle esigenze degli utenti e dei consumatori si sono determinati nei servizi essenziali, con particolare riferimento al settore dei trasporti. La riforma della legge avvenuta nell’ultima legislatura può indurre decisioni più coraggiose da parte della Commissione di Garanzia, con particolare attenzione al criterio della “rarefazione oggettiva” - che garantisce adeguati intervalli agli utenti tra uno sciopero e l’altro - e alle procedure di raffreddamento dei conflitti, a partire dal referendum consultivo obbligatorio.
Occorrerà verificare, inoltre, la possibilità di rafforzare, con sedi nuove e più efficienti la prevenzione e composizione delle controversie collettive di lavoro, con particolare ma non esclusiva competenza nella gestione del conflitto nei servizi essenziali.
Parte Prima. L’analisi / Il mercato del lavoro in Italia: inefficienze ed iniquità
1. Raccomandazioni dell’Unione Europea
Le ‘Raccomandazioni’ rivolte all’Italia dall’Unione Europea nell’ambito della cosiddetta Strategia Europea sull’Occupazione hanno sottolineato, più volte, la difficile situazione in cui versa il mercato del lavoro e l’insufficienza delle politiche fin qui attuate. Peraltro, più anni sono trascorsi senza che venissero introdotti quegli interventi in grado di modificarne in maniera sostanziale la situazione.
Dal punto di vista delle condizioni del mercato del lavoro, la Commissione Europea nella proposta di Rapporto Congiunto 2001 che deve essere ancora discusso dal Consiglio Europeo, rileva che, nonostante nel gennaio 2001 il tasso di disoccupazione in Italia sia sceso sotto il 10%, il tasso di occupazione rimane sempre al 53,5%, 10 punti percentuali al di sotto della media europea e il più basso fra tutti i paesi dell’Unione Europea. Inoltre, continuano ad essere presenti persistenti difficoltà strutturali quali il basso livello di occupazione giovanile e di attività delle generazioni più anziane, profonde differenze di genere, squilibri regionali molto marcati.
Dal punto di vista delle politiche, la Commissione ritiene che nel complesso la Strategia Europea sull’Occupazione non sia stata attuata da parte del nostro Paese. Si rileva, infatti, che l’Italia ha proceduto all’implementazione di politiche già previste, piuttosto che introdurre misure innovative al fine di realizzare il policy mix raccomandato (coordinando cioè i quattro pilastri del processo di Lussemburgo). Sono inoltre segnalati ritardi nella verifica del sistema pensionistico, nelle azioni preventive della disoccupazione giovanile di lungo periodo e più in generale nelle misure correttive in senso preventivo della disoccupazione, nel sistema di servizi pubblici all’impiego. L’utilizzazione in Italia di forme di lavoro non standard è ancora molto bassa (16,1%), tenuto conto che il 60% dei nuovi posti di lavoro sono stati creati ricorrendo a tipologie flessibili sul lavoro. Infine, per quanto riguarda le azioni sulle pari opportunità, la Commissione rileva che le azioni intraprese hanno sortito solo miglioramenti marginali ed è quindi necessario passare da misure erratiche ad una strategia più globale, finalizzata, con priorità assoluta alla riduzione del gender gap.
Più in particolare, anche quest’anno, come negli anni precedenti, l’Italia è stata invitata a:
- perseguire una riforma delle politiche del lavoro volte ad aumentare il tasso di occupazione, in particolare delle donne. Queste riforme dovrebbero indirizzarsi a ridurre gli squilibri regionali rafforzando le politiche per l’occupabilità e promuovendo la creazione di posti di lavoro e la riduzione del lavoro irregolare, con un attivo coinvolgimento delle parti sociali;
- continuare ad accrescere la flessibilità del mercato del lavoro con un approccio che possa meglio combinare la sicurezza con una maggiore adattabilità al fine di facilitare l’accesso al lavoro; proseguire l’implementazione della riforma del regime pensionistico attraverso la revisione prevista per il 2001 ed avviare la prevista riorganizzazione degli altri regimi previdenziali, onde ridurre le uscite dal mercato del lavoro, e così elevare il grado di partecipazione degli anziani; proseguire inoltre gli sforzi per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro, in particolare per i lavoratori scarsamente retribuiti e per quelli con bassa qualifica;
- nel contesto delle politiche per l’occupabilità, intraprendere ulteriori azioni al fine di prevenire l’entrata nella disoccupazione di lunga durata dei lavoratori giovani e adulti. Tali azioni dovrebbero includere: la piena e completa attuazione della riforma dei servizi pubblici all’impiego in tutto il paese; l’accelerazione dell’introduzione del sistema informativo del lavoro; e la prosecuzione dell’impegno attuale volto a migliorare il sistema di monitoraggio statistico;
- migliorare l’efficacia delle politiche attive per il lavoro e attuare specifiche misure per ridurre l’ampio divario di genere in termini di occupazione e di disoccupazione, nell’ambito di un approccio orizzontale di genere, e in particolare fissando obiettivi per l’offerta di asili nido ed altri servizi di sostegno;
- rafforzare le azioni per adottare ed attuare una strategia coerente per la formazione continua, stabilendo obiettivi nazionali; le parti sociali dovrebbero essere più attive nell’ offerta di maggiori opportunità di formazione alla forza lavoro.
A tutte queste sollecitazioni occorrerà che l’Italia risponda con efficacia e tempestività, trattandosi di obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unione Europea.
Il Governo ritiene che queste siano indicazioni molto puntuali e rigorose, che non possono non essere condivise, e da cui occorre partire nel delineare la politica sull’occupazione dei prossimi anni. Per questo motivo richiama tutte le istituzioni coinvolte e tutte le parti sociali affinché siano predisposte iniziative ed interventi per affrontare i nodi critici del mercato del lavoro italiano. Come primo contributo in tal senso, il Governo, con questo Libro Bianco, intende proporre a tutti i suoi interlocutori un’agenda di discussione da cui possa derivare, in tempi rapidi, un programma di politiche adeguate.
2. Andamenti e caratteristiche del mercato del lavoro italiano
2.1. Crescita economica ed intensità occupazionale
Il mercato del lavoro italiano è stato, per anni, caratterizzato da condizioni di strutturale difficoltà, soprattutto dopo la grave crisi subita nei primi anni del decennio appena trascorso. Pur continuando a sperimentare un ritardo rispetto a tutti gli altri paesi industrializzati, di cui il tasso di occupazione è un fedele indicatore, negli ultimi anni si è assistito allo svilupparsi di una moderata dinamica favorevole delle grandezze occupazionali. In particolare, è emersa una maggiore correlazione tra crescita del prodotto e crescita dell’occupazione, nonché una forte diffusione delle cosiddette forme di lavoro atipico.
Le flessibilità introdotte a partire dal 1997 (pacchetto Treu) hanno consentito una prima inversione di tendenza. Nel quinquennio 1995-2000 l’elasticità dell’occupazione al PIL (misurata come rapporto tra dinamica della prima e del secondo) si è ragguagliata al 54%, a fronte di un valore del 12% nella fase di crescita registratasi nella seconda metà degli anni ottanta (Tav. 1; Fig.1).
Tav. 1 – Elasticità dell’occupazione al PIL: evoluzione nell’ultimo quindicennio
| 1985-1990 | 1990-1995 | 1995-2000 | |
|---|---|---|---|
| Variazione % cumulata del PIL | 15,1 | 6,5 | 9,8 |
| Variazione % cumulata delle unità standard di lavoro nei conti nazionali | 3,7 | -3,8 | 4,1 |
| Variazione % cumulata delle persone occupate nell’indagine forze di lavoro | 1,8 | -4,7 | 5,3 |
| Contenuto occupazionale della crescita (unità standard) | 0,24 | -0,59 | 0,42 |
| Contenuto occupazionale della crescita (persone occupate) | 0,12 | -0,72 | 0,54 |
A denotare il legame tra aumentati margini di flessibilità e crescita occupazionale è sia l’esame della composizione interna di quest’ultima –in cui prevalgono il lavoro c.d. atipico[1] e taluni gruppi demografici tradizionalmente più ai margini del mercato del lavoro– sia il più forte ed immediato legame tra crescita del PIL ed andamenti dell’occupazione. A tale risultato ha contribuito la crescita del part time che ha elevato il numero di persone fisiche occupate a parità di input di lavoro in termini di unità standard (come misurate nei conti nazionali)[2]. Queste sono così cresciute meno del numero di persone fisiche occupate (del 4,1% cumulato a fronte del +5,3% cumulato degli occupati conteggiati nell’indagine sulle forze di lavoro nel quinquennio 1995-2000).
A denotare la crescita dell’occupazione si segnala come tra il 1995 e il 2000 il tasso di occupazione nella classe d’età 15-64 anni sia passato dal 50,6 al 53,5%, con una significativa accelerazione nel biennio 1998-2000 (a cui vanno attribuiti due dei tre punti della crescita totale prima ricordata) in concomitanza con una crescita del PIL che, pur se ancora stentata, è stata più sostenuta che nel triennio precedente (Fig. 1). Il miglioramento è stato particolarmente marcato nella componente femminile (+4,1 punti in termini di tasso di occupazione). Anche per i più giovani, la disoccupazione esplicita, come quota della popolazione totale tra 15 e 24 anni, è calata nello stesso quinquennio dal 12,6 all’11,8%, a beneficio di un aumento sia dell’occupazione che della partecipazione alla scuola.
Fig.1 - Tassi di variazione del PIL e dell'occupazione (dati trimestrali destagionalizzati)

Dal punto di vista settoriale, la crescita dell’occupazione nel quinquennio 1995-2000 è stata caratterizzata dall’espansione di settori ed attività a minore intensità effettiva di capitale, uno sviluppo in parte connesso con lo spostamento progressivo dell’occupazione dall’industria ai servizi –settori caratterizzati da un più contenuto trend nella produttività del lavoro– ma favorito anche proprio dalla maggiore flessibilità del lavoro.
2.2. Flessibilità e precarietà
Nonostante le preoccupazioni e i rilievi avanzati su un eccesso di flessibilità nel mercato del lavoro italiano, alquanto contenuti sono rimasti sinora i rischi che dalla maggiore flessibilità scaturisse un’accentuazione dei fenomeni di precarietà.
Il lavoro atipico è certamente stata la componente principale della maggiore occupazione, ma le vicende del biennio 1998-2000 testimoniano come, in concomitanza di tassi significativi di sviluppo del PIL (cresciuto del 2,3% all’anno nel biennio, a fronte di una crescita dell’1,6% nel triennio precedente), anche il lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato cresca senza ostacoli (Tav. 2). Peraltro, ancora basso appare il ricorso al lavoro a termine, anche nel confronto internazionale (i rapporti a tempo determinato erano nel 2000 il 7,5% dell’occupazione totale, in crescita rispetto al 5,4% del 1995, ma ancora ben al di sotto dell’11,4% medio della UE).
Tav. 2 – Contributi alla variazione percentuale dell’occupazione delle diverse tipologie di lavoro
| 93-95 (a) | 95-98 (a) | 98-00 (a) | 00-01 (a) | 95-01 (a) | Livello 2001 (b) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variazione totale dell’occupazione | -2,8 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 7,3 | 100,0 |
| Contributi alla variazione | ||||||
| Autonomi | -0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 27,9 |
| A tempo pieno | -0,4 | 0,3 | -0,1 | 0,5 | 0,7 | 25,8 |
| A tempo parziale | 0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 2,1 |
| Dipendenti | -2,5 | 1,7 | 2,4 | 2,1 | 6,4 | 72,1 |
| Permanenti a tempo pieno | -3,4 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 1,9 | 60,8 |
| “atipici” | 0,9 | 1,6 | 2,3 | 0,5 | 4,5 | 11,3 |
| Di cui: | ||||||
| permanenti a tempo parziale | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 2,0 | 4,5 |
| temporanei a tempo parziale | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 1,6 | 4,6 |
| temporanei a tempo pieno | -0,0 | 0,5 | 0,4 | -0,0 | 0,9 | 2,2 |
Il lavoro atipico non sempre è sinonimo di precarietà. E’ sufficiente osservare alcune prime evidenze empiriche. Nell’impiego a tempo ridotto, cresciuto dal 6,3 all’8,4% dell’occupazione complessiva tra 1995 e 2000, la componente volontaria prevale largamente, specie tra le donne e nel Centro-Nord. Il dato meno favorevole del Mezzogiorno evidenzia come la più diffusa precarietà dell’occupazione nell’area, che interessa anche il part time, sia da correlare al contesto economico generale meno favorevole e non tanto a specifici problemi di tutela e regolamentazione di questo particolare rapporto di lavoro.
Gli sviluppi di questi ultimi anni testimoniano, dunque, che il marcato sviluppo delle tipologie atipiche di lavoro non rappresenta un evento transitorio né appare destinato ad esaurirsi poiché copre solamente un segmento del mercato del lavoro. Anche per il lavoro a termine, pur denotandosi una probabilità di occupazione nei successivi dodici mesi significativamente inferiore rispetto a quella degli occupati a tempo indeterminato, il trend nel tempo è positivo, con una riduzione delle differenze esistenti.
E’ peraltro possibile che, ove alla maggiore flessibilità in entrata non dovesse corrispondere un complessivo riequilibrio della regolamentazione del mercato del lavoro, con il passaggio da una tutela centrata sul rapporto di lavoro in essere ad un regime di tutele garantite soprattutto nel mercato, i pericoli di segmentazione nel mercato del lavoro finirebbero con l’aggravarsi.
Per questo motivo, il Governo sollecita tutte le parti sociali a segnalare le tendenze percepite in questo senso e a valutare l’impatto delle asimmetrie tra flessibilità in entrata e rigidità in uscita. Tali asimmetrie possono nascondere anche una pericolosa frattura sociale tra generazioni, ove è chiaro che i segmenti più giovani trovano accesso al mercato del lavoro con contratti flessibili mentre la popolazione meno giovane e dinamica rimane caratterizzata da contratti tradizionali da lavoro dipendente.
2.3. Criticità…
Il Governo ritiene che, nonostante i segnali di crescita occupazionale descritti, l’eredità del passato rimane alquanto pesante e che molti sono i nodi critici ancora irrisolti.
Il tasso di occupazione (53,5% nella classe 15-64anni d’età) è ancora ben lontano dall’obiettivo che l’Unione Europea nel suo insieme si è posta per il 2010 (70%). Ancor più ampia è la distanza dei livelli attuali dell’occupazione rispetto alle soglie UE al 2010 per la componente femminile (39,6% contro 60%) e per i 55-64enni (27,8% contro 50%). Per questi ultimi, le tendenze realizzatesi nel periodo 1995-2000 sono addirittura nel senso di una riduzione dei livelli occupazionali, ormai tra i più bassi nel panorama europeo[3]. Tenuto conto del peso crescente che i lavoratori più anziani avranno nella popolazione complessiva, è tra l’altro da rilevare come, ove non si arrestasse quella tendenza declinante, da qui al 2005 ne risulterebbe, coeteris paribus, compresso di sei decimi di punto lo stesso tasso di occupazione complessivo (Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Rapporto di Monitoraggio, 1-2001, scheda 1).
La causa principale della distanza tra i livelli occupazionali medi dell’Italia rispetto ai target europei è ascrivibile al Mezzogiorno, che dista dagli attuali livelli medi UE di oltre venti punti percentuali sia per il totale che per la componente femminile (Tav. 3). Tuttavia, anche nel Centro-Nord i livelli occupazionali rimangono inferiori rispetto ai target europei ed agli stessi odierni livelli medi dell’UE (59,9% contro 63,3% per il totale e 48% contro 53,4% per la componente femminile). Il divario è concentrato tra i giovani e, soprattutto, nel caso dei maschi, tra i più anziani; più diffuso nel caso della componente femminile. Fatto salvo il caso degli anziani, il Centro-Nord ha però evidenziato una certa tendenza al recupero dei gap esistenti. Nel quinquennio 1995-2000 la crescita del tasso d’occupazione è stata significativamente superiore a quella media UE per la componente femminile (+5,7 punti percentuali nel Centro-Nord contro il +3,7 medio della UE); è invece risultata leggermente meno accentuata per i maschi (+1,8 punti percentuali contro il +2,3 medio della UE), nel cui caso ha influito soprattutto la negativa performance dei 55-64enni. In termini di scenario, immaginando di replicare le tendenze del biennio 1998-2000[4]) e realizzando una qualche inversione di tendenze per i soggetti più anziani, queste regioni sarebbero in grado di superare al 2010 le soglie UE del 70% e del 60% rispettivamente per l’occupazione totale e femminile (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Rapporto di Monitoraggio no. 1-2001, scheda 1).
Nell’ottica di una strategia che miri all’innalzamento dei livelli occupazionali verso i traguardi posti in sede europea quattro appaiono le aree maggiormente problematiche: il Mezzogiorno, l’ingresso nel mondo del lavoro dei più giovani, la fuoriuscita ancora troppo precoce dal mondo del lavoro dei più anziani e la scarsa, pur se crescente, partecipazione al mondo del lavoro della componente femminile.
il Mezzogiorno…
Il dualismo territoriale rappresenta il nodo fondamentale del mercato del lavoro italiano, quello in cui si esplicita la segmentazione più evidente. Tutti i dati esistenti testimoniano di un’area che presenta un marcato squilibrio tra domanda e offerta, con conseguente sottoutilizzo di risorse umane. I bassi livelli occupazionali del Mezzogiorno si riconnettono con la più generale questione delle prospettive di sviluppo economico di quelle regioni.
Il Mezzogiorno si caratterizza per un livello del PIL per abitante pari al 56% circa di quello del Centro-Nord (SVIMEZ, 2000). Il divario, ampliatosi nell’ultimo quindicennio[5], è ascrivibile tanto ad una minore produttività per occupato che ai più bassi livelli dell’occupazione nella popolazione. La bassa produttività, conseguenza anche di diversi fattori ambientali, deprime la domanda di lavoro e la capacità d’impiego, per dati salari, delle imprese meridionali. Lo scarso legame esistente tra produttività aziendale e condizioni del mercato locale del lavoro, da un lato, e retribuzioni, dall’altro, si traduce quindi in più bassi livelli occupazionali.
In questo quadro, la “valvola di sfogo” rappresentata dall’economia sommersa risulta essere inefficace, oltre che fonte di iniquità. Secondo le ultime stime ISTAT disponibili (1999), le unità di lavoro classificabili come non regolari erano quasi tre milioni e mezzo (come stimate nell’ambito dei conti nazionali), pari al 15,1% del volume di lavoro complessivamente impiegato nell’economia. L’incidenza del lavoro non regolare appare massima nei servizi domestici e nell’agricoltura (rispettivamente 80% e 30% circa del volume complessivo di lavoro). Valori significativamente più elevati della media si registrano però anche nel commercio e nelle costruzioni. A livello territoriale, il fenomeno è poi concentrato nel Mezzogiorno, dove l’irregolarità di solito travalica il mancato assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali, per comportare anche il ricorso a condizioni lavorative, salariali e non, inferiori rispetto agli standard contrattuali. Peraltro, molte attività svolte nel sommerso riescono a sopravvivere proprio grazie al più basso costo del lavoro che le contraddistingue.
D’altro canto, la precarietà dei rapporti di lavoro propri dell’economia sommersa, l’impossibilità di crescere delle imprese che al suo interno operano e sopravvivono proprio grazie all’evasione delle diverse norme salariali, fiscali e regolamentative, certo non facilita lo sviluppo della produttività e l’innesco di un circolo virtuoso di sviluppo economico che dovrebbe consentire l’innalzamento progressivo dei salari effettivi. In particolare nel Mezzogiorno, flessibilità nel mercato del lavoro, fuoriuscita dal sommerso ed azioni di contesto atte ad innescare processi di crescita della produttività globale dell’area appaiono perciò come strategie interconnesse e non alternative al fine di innescare nell’area un processo di sviluppo economico e di crescita dell’occupazione regolare.
i giovani…
Il tasso di disoccupazione delle fasce di età più giovani continua ad essere uno dei più elevati dei paesi europei a confermare come questo sia una delle caratteristiche più negative del mercato del lavoro italiano. Ugualmente, le prospettive dei giovani nel mercato del lavoro, pur se migliorate negli ultimi anni proprio grazie alla maggiore flessibilità in ingresso introdotta (specie nel Centro-Nord), ancora appaiono contraddistinte da una difficoltosa transizione dalla scuola al lavoro. Si tratta di due ambiti piuttosto separati, con il risultato di un prolungamento dei tempi di accesso nel mondo del lavoro e del rischio di una progressiva disincentivazione degli investimenti in capitale umano.
L’Italia, va ricordato, continua ad avere un significativo gap nei livelli educativi, rispetto alla media dei paesi OCSE, anche considerando le classi d’età più giovani: nel 1999, solo l’11,3% dei 35-44enni era in possesso d’un titolo di studio universitario a fronte d’una media OCSE del 14,9[6]. Gli anni novanta hanno tra l’altro evidenziato un certo rallentamento nei ritmi di crescita degli anni di scolarità media nella popolazione adulta[7], anche se segnali favorevoli risultano per quanto riguarda sia la frequenza scolare nel post-obbligo e sia le immatricolazioni universitarie.
Significativi miglioramenti nel facilitare l’accesso dei più giovani al mercato del lavoro sono derivati dagli strumenti di flessibilità introdotti a partire dal 1997. Un canale come quello dell’interinale, ad esempio, consente a chi sia studente di fare brevi esperienze lavorative che poi potranno essere utili nel momento in cui dovrà cercarsi una collocazione lavorativa a tempo pieno. Poco diffuse sono però ancora le figure miste, di studenti che ad esempio svolgano lavori part time di breve durata, a differenza di una situazione come quella olandese, dove il forte sviluppo del part time è spiegato, oltre che dalla componente femminile, dalla crescita sostenuta del cosiddetto part time breve (inferiore alle dodici ore settimanali) tra gli studenti[8].
gli anziani…
L’invecchiamento della popolazione, in Italia più rapido che in altri paesi industrializzati, è stato un fenomeno che solo recentemente ha trovato un’adeguata attenzione presso istituzioni e attori sociali. Il continuo aumento della disoccupazione dei gruppi più anziani e la loro scarsa partecipazione al mercato del lavoro sono segnali che sono stati a lungo sottovalutati.
Occorre rilevare come, nel caso della componente maschile, il forte calo registratosi nei rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, connesso con i processi di pensionamento, non è stato compensato dalla crescita del lavoro atipico (a tempo parziale e/o determinato). Particolarmente scarso risulta essere il ricorso al part time proprio per quanto riguarda i lavoratori più anziani. L’aumento del part time realizzatosi nel complesso della popolazione è nel caso dei 55-64enni piuttosto contenuto, addirittura irrilevante nel caso dei maschi.
Sull’evoluzione di queste dinamiche hanno giocato un ruolo gli scarsi incentivi alla prosecuzione dell’attività lavorativa. Paradossalmente per i lavoratori anziani è rimasto accessibile il canale delle pensioni d’anzianità, non applicandosi neppure le norme relative al nuovo sistema pensionistico contributivo, che avrebbe invece già insiti meccanismi d’incentivazione del proseguimento dell’attività lavorativa e, basando il calcolo dei trattamenti pensionistici sull’intera vita lavorativa e non solo sugli ultimi anni di contribuzione, non disincentiverebbero il passaggio eventuale a rapporti di lavoro a tempo parziale. Più in generale va rilevato come, stante l’elevato livello degli oneri contributivi ancora vigenti, i meccanismi di flessibilità all’ingresso sinora introdotti, non operanti nel caso dei soggetti più anziani e basati spesso su rapporti contrattuali caratterizzati da un minore peso contributivo, hanno contribuito a favorire uno spostamento della domanda di lavoro verso le nuove generazioni.
le donne…
La componente femminile è quella per la quale la crescita occupazionale nell’ultimo quinquennio è stata più consistente, specie nel Centro-Nord, ove si è ridotto il gap che comunque permane rispetto alla media UE (gap che è invece massimo ed è cresciuto ancora nel caso del Mezzogiorno; cfr. Tav. 3).
La crescita della presenza femminile nel mercato del lavoro ha interessato pressoché tutte le classi d’età e, particolarmente nel Centro-Nord, sembra comportare una modifica strutturale nel modello della presenza femminile nel mercato del lavoro lungo il ciclo di vita. Opportunità importanti, atte a conciliare vita familiare e presenza nel mercato del lavoro, sono discese anche dallo sviluppo del part time, sostenuto proprio per le donne con figli minori a carico. L’Italia da questo punto di vista rimane, però, un paese in cui scarsa è la presenza di sostegni alle famiglie con figli minori, soprattutto in termini di disponibilità di servizi, pubblici e privati, per cui spesso tra scelte lavorative e scelte relative alla fecondità si genera un accentuato trade-off.
La maggiore presenza femminile, favorita dagli strumenti di flessibilità all’ingresso oltre che da mutamenti tecnologici e culturali, non appare aver portato a fenomeni di accentuata precarizzazione della componente femminile nel mercato. Come detto, nel part time è particolarmente bassa l’incidenza della componente involontaria proprio nel caso delle donne. L’aumento dell’occupazione femminile non è, inoltre, andato a discapito della retribuzione relativa delle donne, anche se rimane un divario di circa venti punti percentuali nei salari maschili e femminili.
la disoccupazione di lunga durata
Un ulteriore squilibrio che caratterizza il mercato del lavoro in Italia è costituito dalla quota estremamente elevata dei disoccupati con un lungo periodo di ricerca di lavoro. Il tasso di disoccupazione di questo segmento specifico è pari all’8,3% mentre la media europea si posiziona al 4,9%. Anche l’incidenza risulta tra le più elevate in Europa, con differenziali molto sensibili.
La crescita dello stock di disoccupati è da attribuirsi al progressivo aumento delle persone con una durata di ricerca particolarmente lunga. In particolare, appaiono colpiti da questa condizione coloro che non possiedono precedenti esperienze lavorative, vale a dire i segmenti più giovani della popolazione, piuttosto che quelli che hanno perso un precedente posto di lavoro. Questo fenomeno indica la presenza di ancora rilevanti barriere all’entrata o la difficoltà di accesso al mercato del lavoro e quindi appare da imputare ad ostacoli di carattere regolatorio.
Occorre sottolineare, tuttavia, come una lunga permanenza nella disoccupazione di individui con precedenti esperienze lavorative, pure avendo minore rilevanza in termini di funzionamento del mercato del lavoro, possa comportare effetti sociali più pesanti, con seri rischi di marginalizzazione ed esclusione sociale per questi soggetti.
Tav. 3 – Occupazione e disoccupazione: il gap con l’Europa (valori %)
| Tasso di occupazione | 55-64enni | Tasso di disoccupazione. | 15-24enni in cerca di lavoro: % sulla popolazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi(a) | Femmine(a) | Totale(a) | Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1995 | |||||||||
| Centro - Nord | 70,0 | 42,3 | 56,2 | 27,3 | 5,2 | 11,4 | 7,6 | 9,9 | |
| Mezzogiorno | 58,4 | 23,1 | 40,6 | 30,9 | 16,3 | 28,9 | 20,4 | 17,0 | |
| Italia | 65,9 | 35,4 | 50,6 | 28,5 | 9,0 | 16,2 | 11,6 | 12,8 | |
| Unione Europea | 70,2 | 49,7 | 60 | 35,9 | 9,4 | 12,5 | 10,7 | 10,2 | |
| 2000 | |||||||||
| Centro - Nord | 71,9 | 48,0 | 59,9 | 26,2 | 3,9 | 8,4 | 5,7 | 7,1 | |
| Mezzogiorno | 59,5 | 24,6 | 42,0 | 30,8 | 16,3 | 30,4 | 21,0 | 17,7 | |
| Italia | 67,5 | 39,6 | 53,5 | 27,7 | 8,1 | 14,5 | 10,6 | 11,7 | |
| Unione Europea | *72,5 | *54,0 | 63,3 | *37,7 | 7 | 9,7 | 8,2 | 7,8 | |
2.4. Qualità del lavoro
La criticità del mercato del lavoro in Italia non è determinata solo dagli indicatori quantitativi finora sottolineati. Esiste anche, ed è crescente, un problema di qualità del lavoro. Diverse sono le evidenze empiriche che fanno propendere per un giudizio non positivo sulla qualità del nostro mercato del lavoro, come recentemente sottolineato anche dalla Commissione Europea. La qualità non buona è anzitutto insita nei differenziali occupazionali già richiamati, nel concentrarsi della disoccupazione a livello geografico, nel gender gap e nei particolarmente bassi livelli occupazionali dei giovani e dei più anziani. Aspetti altrettanto importanti della qualità del lavoro attengono peraltro la presenza di investimenti formativi che facilitino lo sviluppo professionale e di carriera, all’interno e all’esterno dell’azienda, dei lavoratori, la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché il bilanciamento tra esigenze e desideri di questi e flessibilità operative delle aziende.
Un mercato del lavoro flessibile, al contrario di quanto spesso temuto, può migliorare la qualità oltre che la quantità dei posti di lavoro, rendendo più fluido l’incontro tra obiettivi e desideri delle imprese e dei lavoratori in tema di caratteristiche della prestazione lavorativa, consentendo ai singoli individui di cogliere le opportunità lavorative più proficue ed evitando che gli stessi rimangano intrappolati in ambiti ristretti e segmentati. I lavoratori necessitano, in tale contesto, di adeguate forme di tutela, ma queste devono agire innanzitutto nel mercato, non operare contro il mercato o comunque esclusivamente nell’ambito del rapporto di lavoro in essere.
Da questo punto di vista, il nostro mercato del lavoro appare ancora alquanto immobilizzato, scontando anche l’insoddisfacente funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego e dei processi di incontro tra domanda ed offerta. Se si valutano i dati relativi alla mobilità occupazionale, risulta che in media in Europa il 10% dei lavoratori di professionalità alta ha cambiato lavoro nell’ultimo anno, cercando opportunità occupazionali più convenienti. Questo dato sale al 12% per il Regno Unito, la Danimarca, la Francia e la Svezia. In Italia siamo al 5%, cioè all’ultimo posto nel contesto comunitario. Si tratta di un profilo poco analizzato (ci si concentra più spesso sul ben noto deficit di mobilità geografica), che invece ben rivela la staticità del nostro mercato del lavoro e l’inadeguatezza dei meccanismi di incrocio fra domanda e offerta.
In questo quadro il Governo condivide le preoccupazioni della Commissione europea quanto al nesso fra bassa qualità del mercato del lavoro e rischio di esclusione sociale. Come sottolineato a più riprese la segmentazione del mercato del lavoro si basa su di una divisione fra soggetti titolari di retribuzioni accettabili, con relativa sicurezza dell’impiego e prospettive di carriera, da un lato, e, dall’altro, non soltanto disoccupati e lavoratori “scoraggiati” ma anche quanti sono occupati in lavori di bassa qualità, basati sul precariato, senza prospettive di formazione o sviluppi di carriera.
2.5. Salari e produttività
La politica dei redditi e l’assetto contrattuale derivati dagli Accordi del 1992 e del 1993, da un lato hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi macroeconomici allora prefissati (entrata nell’Unione Economica e Monetaria e risanamento della finanza pubblica), dall’altro hanno garantito la coerenza e la compatibilità delle diverse variabili economiche, in particolare dei salari.
In questi anni, tuttavia, maggiore flessibilità e moderazione salariale non sembrano aver portato ad uno spostamento a favore dei profitti lordi nella distribuzione funzionale dei redditi. La quota del lavoro nel valore aggiunto manifatturiero, specie se valutata al netto dello scalino connesso col passaggio dai contributi sanitari all’IRAP (contabilmente inseriti i primi nei redditi lordi da lavoro e la seconda nei profitti lordi nell’ambito dei conti nazionali), pur tra fluttuazioni cicliche, non mostra tendenze al declino in confronto con gli anni ottanta. Nei servizi privati emerge un trend negativo, peraltro arrestatosi negli ultimissimi anni, che sembra però attribuibile principalmente agli effetti una tantum della liberalizzazione di molti servizi e utilities–con le connesse ristrutturazioni straordinarie che ne sono seguite, specie nei primi anni novanta– ed all’ancora graduale e incompleto passaggio ad un regime di piena concorrenza. Il permanere di strutture di mercato non pienamente competitive rischia, infatti, di mantenere alti prezzi di vendita e profitti a discapito dei volumi produttivi e della stessa occupazione.
Durante il medesimo arco temporale, peraltro, scarsa crescita, alta disoccupazione ed elevato carico fiscale e lo stesso modello contrattuale scaturito dagli Accordi del 1992-1993 hanno portato ad un’evoluzione poco lusinghiera dei salari reali al netto delle imposte. Quest’ultima è da ascrivere, in particolare, alla crescita della pressione fiscale sul lavoro, che, nonostante la riduzione avviata negli ultimi anni, nel 2000 era ancora superiore a quella media UE.
La struttura della contrattazione collettiva in Italia è rimasta fortemente centralizzata, imperniata sul contratto nazionale di categoria. Un certo grado di coordinamento è stato garantito, quanto meno potenzialmente, dal predominio del livello confederale. Infatti, l’Accordo del 1993 ha trasformato il Ccnl in contratto biennale per la parte economica e quadriennale per la parte normativa, introducendo importanti principi generali di governo dei salari nominali. Il riferimento all’inflazione programmata svolge, infatti, un’importante funzione di coordinamento tra i diversi settori. Il principio di non automatico recupero dell’inflazione passata -dovendosi tenere conto delle eventuali origini esterne al sistema produttivo (variazioni delle ragioni di scambio), nonché delle condizioni economiche generali- contrasta il rischio di spirali inflazionistiche.
Il contratto di secondo livello, che avrebbe dovuto consentire possibili differenziazioni salariali, stabilendo uno stretto legame tra retribuzione e performance dell’impresa non ha trovato quella maggiore diffusione che si intendeva ottenere. Esso essendo non sistematico e non universale, e rimanendo circoscritto alle imprese più grandi, è rimasto più instabile nel tempo. Il contratto aziendale prevedeva una specializzazione tematica ed un orientamento verso meccanismi di profit sharing. In azienda, l’enfasi posta sul profit sharing ha contribuito ad un ulteriore passo in avanti verso relazioni industriali non conflittuali e si è registrato un effettivo incremento della quota di salario variabile.
Tuttavia, l’obiettivo di una maggiore decentralizzazione della contrattazione, tale da permettere un’effettiva redistribuzione dei guadagni di produttività, è stato solo parzialmente raggiunto. La distinzione dei ruoli dei due livelli di contrattazione, nazionale ed aziendale, è stata importante per potenziare la componente variabile del salario, ma non ha, di fatto, introdotto modifiche sostanziali nei meccanismi di formazione dei differenziali salariali “esterni”, cioè quelli fra imprese, fra settori, fra aree territoriali. Il sistema di contrattazione collettiva ha mantenuto, dunque, caratteristiche di centralizzazione che si sono rivelate eccessive e inadatte ad assicurare quella flessibilità della struttura salariale capace di adeguarsi ai differenziali di produttività e di rispondere ai diversi disequilibri del mercato.
Il sistema di determinazione del salario in Italia favorisce il permanere di una struttura delle retribuzioni relativamente poco articolata. Inoltre, è da ricordare l’assenza di un regime di salario minimo legale. Tale funzione, infatti, è esercitata dai contratti collettivi nazionali di settore. Rispetto ad altri paesi, questa funzione è però svolta con minore efficacia, in termini di prevenzione di abusi, visto che i Ccnl hanno livelli salariali, in termini relativi rispetto alla retribuzione media effettiva, piuttosto elevati. Il livello dei minimi sanciti dai Ccnl corrisponde tra i due terzi e i tre quarti del salario medio effettivo, ben al di sopra del 50% circa garantito dai salari minimi legali nella maggior parte degli altri paesi europei che hanno questo strumento.
Al fine di determinare valori di equilibrio dei vari tipi di differenziali, il mercato ha continuato ad operare attraverso varie forme di slittamento salariale, trovando un limite, tuttavia, nei livelli minimi salariali fissati dai contratti nazionali, i quali hanno determinato una struttura delle retribuzioni più “compressa” di quella che sarebbe altrimenti risultata sulla base dell’azione dei fattori di carattere economico. In sostanza, invece di “liberare” i salari, essi sono stati ricondotti in un sistema di “gabbie”. Queste osservazioni valgono anche (e soprattutto) per i differenziali salariali territoriali. I dati disponibili indicano che le retribuzioni sono più elevate al Nord rispetto al Sud, ma molto probabilmente, il differenziale è minore di quello che sarebbe necessario per avere un mercato del lavoro più equilibrato e per correggere i differenziali territoriali nei tassi di disoccupazione che contraddistinguono il nostro paese.
In confronto con altri grandi paesi europei, il nostro deteneva (1995, ultimi dati disponibili) il primato della dispersione territoriale dei tassi di disoccupazione, mentre è all’ultimo posto della graduatoria della dispersione territoriale dei livelli salariali (Tav. 4). Siamo un paese molto “egualitario” in politica salariale, ma molto disuguale dal punto di vista delle condizioni di lavoro.
Tav. 4 - Dispersione territoriale di disoccupazione, produttività e salari in alcuni paesi europei
| Tasso di disoccupazione (1996) | Valore aggiunto pro-capite (1994) | Retribuzioni mensili (1995) | N. aree per paese | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ITALIA | 62,8 | 24,6 | 8,4 | 10 | |
| Francia | 18,4 | 25,1 | 16,0 | 8 | |
| Regno Unito | 14,4 | 13,1 | 12,8 | 11 | |
| Spagna | 21,1 | 18,4 | 11,7 | 7 | |
La situazione non è molto cambiata in questi ultimi 5 anni, anzi, si può affermare che, per certi versi, è anche peggiorata. I differenziali territoriali delle retribuzioni e della produttività del lavoro non sono significativamente cambiati in questo periodo, mentre si è prodotta la progressiva de-fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno. Questo insieme di fattori, costanza dei differenziali e de-fiscalizzazione, ha determinato un effetto perverso sui differenziali territoriali sia del costo del lavoro che del costo del lavoro per unità di prodotto. Il costo del lavoro medio nel Mezzogiorno si è avvicinato, in termini relativi, a quello medio del Nord, mentre il Clup (costo del lavoro per unità di prodotto) medio nel Mezzogiorno è aumentato ulteriormente, sempre in termini relativi, rispetto a quello del Nord. Entrambi gli effetti hanno comportato una perdita di competitività per le imprese del Mezzogiorno e, coeteris paribus, un minor incentivo per le iniziative imprenditoriali a localizzarsi nel Mezzogiorno.
In questo quadro, nelle regioni settentrionali l’aumento del tasso di occupazione appare conseguibile attraverso un aumento di offerta di lavoro. Un aumento dell’offerta di lavoro al Nord ed una significativa riduzione della disoccupazione al Sud possono richiedere, fra le altre cose, una più accentuata differenziazione dei rispettivi salari reali.
3. Politiche attive e politiche passive
Alla luce del complesso di obiettivi diversi da quelli strettamente quantitativi in tema di occupazione, oltre agli appena ricordati divari nei livelli e nelle chances occupazionali, che sono una causa prima di iniquità, p.es. tra occupati e disoccupati o tra maschi e femmine, occorre certamente valutare quanto le misure di flessibilità sinora introdotte abbiano risolto vecchie iniquità o ne abbiano introdotte di nuove.
L’impressione è che, nel facilitare l’accesso al lavoro di soggetti prima esclusi (donne, giovani), gli strumenti di flessibilità all’ingresso abbiano contribuito a ridurre le iniquità e le inefficienze discendenti da un mercato del lavoro rigido. Al tempo stesso, però, l’incompletezza del processo di introduzione di nuove flessibilità, lo scarso sviluppo di importanti strumenti di tutela nel mercato –un tratto tradizionale dell’Italia, in cui scarsamente efficaci sono stati i meccanismi di mediazione di manodopera e gli ammortizzatori sociali– il ridotto sviluppo di strumenti di sostegno al reddito dei meno abbienti, possono avere conseguenze negative nel nuovo contesto più flessibile. In altri termini, vi è il rischio che all’attenuazione delle rigide tutele relative al singolo rapporto di lavoro posto in essere non faccia da contraltare lo sviluppo di efficaci forme di tutele nel mercato, tutele tanto più necessarie nel contesto attuale di maggiore flessibilità, con un turn over occupazionale più intenso.
Da questo punto di vista i nodi maggiormente problematici riguardano tanto le c.d. politiche attive (incentivi e servizi a favore del primo impiego dei giovani e del reimpiego dei disoccupati) quanto quelle passive (ammortizzatori sociali) e, più in generale, le politiche sociali e fiscali di sostegno ai meno abbienti.
La spesa per politiche attive nel 2000 è stimabile allo 0,6% del PIL, un importo inferiore a quello medio dei paesi OCSE[9]. Tenuto conto dell’importo speso per politiche passive, l’Italia emerge peraltro come un paese che già oggi spende relativamente di più in politiche attive che in politiche passive. Al di là della dimensione della spesa complessiva, i problemi principali sembrano però riguardare la composizione interna e l’efficacia delle politiche attive.
Anzitutto va rilevato che, in ossequio agli standard contabili Eurostat, la spesa per politiche attive ricomprende anche i Lavori Socialmente Utili, in quanto schemi di creazione diretta di posti di lavoro (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Rapporto di monitoraggio no. 1-2001). Quanto al resto, la voce prevalente è rappresentata dai cd contratti a causa mista (apprendistato e cfl) e da altri schemi di incentivazione finanziaria dell’impiego. Meno rilevanti, quanto a spesa e soprattutto quanto ad efficacia, sono gli interventi formativi propriamente detti e l’ausilio alla ricerca del lavoro da parte dei disoccupati. Le politiche attive del lavoro si sono identificate sostanzialmente con i sostegni al reddito.
Scarse sono le esperienze di politiche attive, soprattutto quelle che combinano azioni integrate finalizzate al reinserimento (orientamento, formazione, inserimento). Si è, infatti, eseguito un decentramento di competenze ma non di politiche. Esempi evidenti sono le carenze sulle politiche per l’immigrazione, quelle per la mobilità territoriale, quelle per la rete informatica ed in generale l’offerta di servizi per la disoccupazione di lunga durata. Al contrario, tra le poche azioni di sistema che si muovono in questa direzione, cercando di attuare azioni integrate, sono da ricordare quelle finalizzate alla riconversione dei Lavori Socialmente Utili e per l’alfabetizzazione informatica.
3.1. Ammortizzatori sociali
Come è noto, con riguardo all’ammontare della spesa sociale complessiva, l’Italia è il paese Europeo che destina la quota più piccola ai trattamenti di disoccupazione (Fig. 2). La struttura della spesa sociale italiana denota, infatti, un’accentuata caratterizzazione pensionistica ed una bassa incidenza tanto dei trattamenti di disoccupazione quanto di quelli assistenziali a favore di soggetti in età lavorativa (invalidità, famiglia, abitazione e assistenza sociale in senso proprio)[10]. Rispetto al PIL, i dati disponibili (ESSPROS, 1998) denotano un’incidenza dei trattamenti di disoccupazione pari in Italia allo 0,7% a fronte di una media UE dell’1,9%[11].
Fig. 2 – Benefici sociali per funzione – anno 1998

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat, European Social Statistic – Social Protection Expenditure and Receipts – 1980-1998
Il divario rispetto agli altri paesi europei nella spesa contrasta con quello nei livelli della disoccupazione. Su tale tradizionale caratterizzazione del caso italiano ha inciso il fatto che tra le persone in cerca di lavoro vi sia una quota elevata di persone in cerca del primo impiego, non coperte dagli schemi assicurativi contro la disoccupazione. Le rigidità nella regolamentazione dei rapporti di lavoro - il prevalere della tutela dei rapporti in essere – ha reso meno pressante l’esigenza di fornire un sostegno a fronte del rischio di disoccupazione e, al tempo stesso, producendo una frattura tra occupati e inoccupati, ha contenuto la platea di potenziali beneficiari dei trattamenti di disoccupazione comunque esistenti. Sul volume complessivo di spesa, ha poi inciso il fatto che i trattamenti previsti nello schema di carattere più generale (il trattamento ordinario che copre tutti i lavoratori dipendenti) fossero alquanto ridotti tanto nei livelli quanto nelle durate previste.
Un altro connotato degli ammortizzatori sociali è la sua estrema eterogeneità interna. La tutela limitata fornita dallo schema ordinario (anche dopo l’innalzamento introdotto dal gennaio del corrente anno)– contrasta con quella propria dell’indennità di mobilità propria del settore industriale. Ancora più ampio sarebbe poi il differenziale di trattamento ove si considerasse che, nella pratica attuazione, i trattamenti di mobilità spesso intervengono successivamente a quelli di CIG straordinaria, trattamento di importo pari a quello della mobilità e che interviene in costanza del rapporto di lavoro in essere, il che tende a prolungare ulteriormente la durata effettiva dei trattamenti .
Nonostante i più generosi trattamenti forniti da CIG e mobilità, il complesso dei due strumenti evidenzia un sostanziale equilibrio finanziario tra contributi e prestazioni (Fig. 3). L’avanzo della CIG, anzi, grazie anche al buon momento congiunturale, nel 2000 più che compensava il deficit proprio della mobilità, che intervenendo, come detto, nelle stesse fattispecie aziendali e spesso in successione temporale rispetto alla CIG è stata perciò consolidata assieme a quest’ultima nella figura qui riportata[12]. Le contribuzioni pagate nel settore industriale, pur se ovviamente a prezzo di elevare il costo del lavoro complessivo, sono infatti sufficienti a finanziare quei trattamenti. Ciò avviene anche, pur se su livelli più contenuti tanto delle contribuzioni quanto delle prestazioni, anche per quanto attiene il trattamento ordinario nei settori extra agricoli[13]. Uno squilibrio strutturale tra contribuzioni e prestazioni caratterizza invece i trattamenti (ordinari e speciali) riservati al settore agricolo.
Nel complesso (e tenendo conto anche delle indennità relative al settore edile), gli strumenti ora citati appaiono in sostanziale equilibrio finanziario nel 2000, anno in cui, l’avanzo dei settori industriali, in ciò favoriti dal quadro congiunturale positivo, compensa il disavanzo strutturale dei trattamenti relativi all’agricoltura. Includendo nella spesa per ammortizzatori sociali anche gli oneri relativi a quegli schemi a totale carico della fiscalità generale - prepensionamenti e LSU, che come più volte detto sono per convenzione classificati tra le politiche attive ma hanno acquisito una natura sostanziale di ammortizzatore sociale di ultima istanza – emerge, anche nel 2000, un sia pur contenuto deficit tra prestazioni e contributi. Rispetto alla metà degli anni novanta, netto appare, peraltro, il miglioramento causato dal miglior clima congiunturale (Fig. 4).
Fig. 3 – Saldo fra prestazioni e contributi nei principali comparti settoriali degli ammortizzatori sociali

Fonte: elaborazioni su dati INPS
Fig. 4 – Spesa per ammortizzatori sociali e contributi a finanziamento degli stessi – anni 1990-2000

Fonte: elaborazioni su dati INPS
Tornando alle peculiarità dei diversi schemi, è da evidenziare come caratteristica delle indennità destinate al settore agricolo, è il loro uso come strumento di integrazione dei redditi da lavoro, più che di copertura del rischio di disoccupazione in senso proprio. La platea dei beneficiari (580mila nel 1999; Tav. 5) pressoché coincide con quella dei soggetti assicurati, che di fatto quasi tutti ricevono nell’anno una qualche integrazione al reddito da lavoro corrente.
Qualcosa di simile sta peraltro progressivamente avvenendo anche nei settori extra-agricoli tramite l’uso dei cd trattamenti con requisiti ridotti. Questi intervengono per quei lavoratori che non raggiungano i requisiti contributivi minimi richiesti per l’accesso ai trattamenti ordinari (almeno 52 settimane di contribuzione nei precedenti due anni) e che però, avendo lavorato nel precedente anno solare per almeno 78 giornate, hanno diritto ad un trattamento pari al 30% della retribuzione per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente. Più che d’un sussidio di disoccupazione, si tratta pertanto d’un bonus a favore di chi abbia lavorato ma non oltre certi limiti, per cui ne vengono ad usufruire, spesso su base stabile nel tempo, soprattutto lavoratori precari e stagionali[14]. Questa modalità di utilizzo, assieme alla crescita di peso del lavoro a termine in generale, spiega tra l’altro il trend nettamente crescente dei trattamenti della specie, che sono giunti a superare, nel numero dei beneficiari e nella spesa connessa, quelli con requisiti pieni[15].
Tav. 5 – Beneficiari di interventi di sostegno al reddito per area geografica e composizione per età e sesso – anno 1999
| Indennità ordinaria non agricola | Indennità agricola (ordinaria e speciale) | Indennità nel settore edile (ordinaria e speciale) | Indennità di mobilità | Cassa Integrazione Guadagni (a) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| req. pieni. | req. ridotti | straord. | ordinaria | di cui edilizia | ||||
| NordOvest | 45.816 | 48.012 | 9.956 | 3.763 | 23.342 | 3.237 | 34.624 | 3.500 |
| NordEst | 60.107 | 76.840 | 45.258 | 2.037 | 8.473 | 1.389 | 12.503 | 4.814 |
| Centro | 42.647 | 65.008 | 30.763 | 4.083 | 16.461 | 3.154 | 15.518 | 2.885 |
| CentroNord | 148.570 | 189.860 | 85.977 | 9.883 | 48.276 | 7.780 | 62.645 | 11.199 |
| Mezzogiorno | 75.506 | 146.679 | 496.336 | 36.901 | 40.847 | 12.345 | 33.509 | 5.671 |
| Italia | 224.076 | 336.539 | 582.313 | 46.784 | 89.123 | 20.125 | 96.155 | 16.870 |
| %maschi | 42,8 | 38,0 | 47,9 | 98,0 | 63,1 | 72,1 | n.d. | n.d. |
| %<25anni | 6,5 | 8,0 | 7,1 | 2,8 | 1,4 | 2,5 | n.d. | n.d. |
| %>45anni | 21,7 | 17,4 | 36,1 | 36,2 | 72,1 | 43,0 | n.d. | n.d. |
3.2. Incentivi all’occupazione
Gli schemi di incentivazione dell’occupazione, ai quali per vicinanza dei caratteri sostanziali è possibile assimilare anche i cd. contratti a causa mista (apprendistato e contratti di formazione e lavoro), coprono circa i due terzi della spesa totale per politiche attive del lavoro. Complessivamente si è trattato, nel 1999, l’ultimo anno per cui è disponibile un consuntivo dettagliato, di 9.763 mld. di lire, pari allo 0,5% del PIL. Considerando gli stanziamenti di bilancio previsti per il 2001 la spesa totale sarebbe di 10.452 mld. (Tav. 5)[16].
Tra i soggetti interessati da incentivi vi è una netta predominanza dei più giovani, in particolar modo nel Centro-Nord, in cui è maggiormente diffuso l’apprendistato; nel Mezzogiorno ad essere più coperta è invece la classe di età mediana (25-44), per la maggiore diffusione di strumenti diretti ai disoccupati di lunga durata. Le donne sono rappresentate in proporzione alla percentuale di occupati, anche se nel Centro-Nord tendono ad essere i beneficiari privilegiati degli incentivi propriamente detti.
Per quanto attiene all’area territoriale, gli strumenti che non siano specificamente diretti al Mezzogiorno, sono fortemente concentrati nel Centro-Nord (per oltre il 70%). Ciò è dovuto alla netta prevalenza, sotto il profilo numerico, dei contratti a causa mista sugli incentivi per il reimpiego dei disoccupati.
La modalità prevalente con cui vengono posti in essere gli incentivi è di carattere automatico. Il prevalere degli incentivi automatici non è privo di vantaggi: infatti, si riducono i costi amministrativi, i rischi di decisioni arbitrarie e le conseguenti distorsioni. Entro certi limiti, non necessariamente implica una perdita di selettività delle politiche. Nella quasi totalità dei casi vi è, in effetti, l’identificazione di gruppi target (giovani, disoccupati di lunga durata, residenti nelle aree depresse). A seguito dell’opposizione comunitaria ad incentivi differenziati su base geografica, il focus territoriale degli interventi si è peraltro progressivamente ridotto. All’interno di ciascuna categoria mancano i riferimenti alle situazioni specifiche dei potenziali beneficiari, ivi inclusa la loro situazione reddituale (con la sola eccezione dello sgravio capitario per il Mezzogiorno, destinato a venir meno alla fine dell’anno in corso). Infine, le politiche di incentivazione all’occupazione sono, nella quasi totalità, costruite senza differenziare tra i sessi (se si esclude la legge per l’imprenditorialità femminile e le azioni positive ex lege 125/91).
Tuttavia, l’intersecarsi di vari strumenti porta ad un grado di copertura di taluni gruppi di popolazione quasi totalitario, il che può determinare una riduzione della selettività effettiva degli interventi: è questo il caso dei giovani, la cui inclusione universale nella popolazione target non sempre è giustificata dalla situazione del mercato del lavoro, in particolare in molte regioni del Centro-Nord. La stessa riduzione dei costi amministrativi non sempre si realizza, essendo le norme d’incentivazione comunque spesso complicate, difficili da interpretare e richiedenti un certo ammontare di paper-work.
Gli incentivi all’occupazione sono attuati in larga parte con lo strumento dello sgravio contributivo in misura proporzionale alla retribuzione del lavoratore assunto. Peraltro, un trend recente è il crescente ricorso, a partire dal 1998, al credito di imposta in cifra fissa a favore dell’impresa che operi nuove assunzioni (questa è la modalità prevista dall’art. 7 della legge finanziaria per l’anno in corso (L.388/2000) e già prima dalla L. 449/97 e 448/98).
Un esame dell’andamento dei singoli interventi sottolinea come, relativamente ai contratti a causa mista si delineano due opposte tendenze: la crescita dell’apprendistato e il decremento dei contratti di formazione-lavoro (cfl)[17]. Appare opportuno ricordare che, in quanto strumento di socializzazione al lavoro dei più giovani, i contratti a causa mista hanno avuto un importante ruolo nel ridurre le difficoltà nella transizione dalla scuola al lavoro. Da questo punto di vista, peraltro, un elemento particolarmente apprezzato dalle imprese è stato fornito dalla natura a termine del rapporto di lavoro che si veniva ad instaurare. Gli aspetti di socializzazione al lavoro, più che quelli di formazione “in aula” – ben poco diffusi sia perché meno rientranti nelle convenienze immediate delle imprese e dei lavoratori, sia per via della struttura dell’offerta formativa, in genere poco orientata a rispondere alle esigenze della domanda[18] – sono stati rilevanti. Il rischio insito nell’incentivazione indiscriminata dei contratti a causa mista è peraltro nel possibile spiazzamento dell’occupazione a tempo indeterminato dei soggetti meno giovani e, tenuto conto dello scarso contenuto formativo in senso proprio di tali contratti, degli investimenti in capitale umano da parte dei più giovani.
Quanto agli incentivi all’occupazione in senso proprio, gli strumenti oggi in vigore sono costituiti in massima parte da incentivi all’assunzione a tempo indeterminato di soggetti beneficiari di trattamenti passivi o disoccupati di lunga durata, e alla stabilizzazione di posti di lavoro a termine. Gli incentivi alla stabilizzazione di posti di lavoro a termine riguardano tanto il caso della trasformazione a tempo indeterminato di soggetti provenienti dalle liste di mobilità, ed in precedenza assunti a tempo determinato, quanto quello di soggetti in precedenza operanti con contratti a causa mista. Peraltro, nonostante molti contratti a tempo determinato di per sé conducano a rapporti più stabili, le trasformazioni incentivate dei contratti a causa mista sono però rimaste quantitativamente contenute. Specie nelle regioni in cui il mercato è più vivace, molti contratti a causa mista vengono interrotti dallo stesso lavoratore, che trova di meglio o che inframmezza esperienze lavorative e frequenza scolastica, prima della durata massima teorica, momento in cui le agevolazioni collegate alla trasformazione apportano all’impresa il massimo vantaggio.
Un maggiore ricorso agli incentivi alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro è plausibile possa discendere dal credito d’imposta di cui alla legge finanziaria per l’anno in corso (la legge 388/2000), che ha natura per certi versi complementare rispetto al ricorso al lavoro a termine (ivi inclusi i contratti a causa mista) dei più giovani: lo strumento è infatti rivolto ai soggetti di età non inferiore ai 25 anni non occupati a tempo indeterminato nei 24 mesi precedenti, ivi inclusi quindi quelli che in precedenza abbiano lavorato con contratti a causa mista o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Tale misura si differenzia in effetti dal credito d’imposta di cui alla L. 449/97 tanto per la minore selettività della platea di potenziali beneficiari e per l’esclusivo riferimento all’instaurazione di rapporti a tempo indeterminato (lo strumento precedente consentiva anche l’instaurazione di rapporti a termine, pur se di durata oltre i 36 mesi ma era rivolto solo a iscritti al collocamento e soggetti in CIGs o mobilità) quanto per la copertura dell’intero territorio nazionale (pur se con una maggiorazione, nei limiti del cd. de minimis, per le aree depresse; cfr. Rapporto di monitoraggio no.1-2001, scheda 8)[19].
Fuoriesce dallo schema d’incentivazione al margine, per le nuove assunzioni, unicamente lo sgravio capitario previsto nel Mezzogiorno in relazione allo stock di lavoratori a basso reddito occupati alla data del 1 dicembre 1997[20], la cui vigenza è tuttavia destinata a cessare al termine dell’anno in corso.
In questo quadro, permane l’assenza di interventi strutturali che favoriscano la domanda e l’offerta di lavoro dei soggetti a più basso reddito, quali quelli introdotti in diversi altri paesi industriali (si veda ad esempio l’Earned Income Tax Credit degli Stati Uniti).
3.3. Incontro domanda- offerta
L’efficace funzionamento del mercato del lavoro risulta ostacolato da un inefficiente incontro tra domanda e offerta. Tale inefficienza è chiaramente evidenziata anche dal forte divario territoriale che caratterizza il mercato del lavoro in Italia. Le difficoltà, che continuano ad incontrare le aree settentrionali del Paese nel reclutamento di manodopera (qualificata e non), sono segnalate quotidianamente dai più diversi indicatori qualitativi e quantitativi. Peraltro, esse possono anche originare pericolose tensioni salariali e favorire il diffondersi di fenomeni devianti quali il sommerso e l’immigrazione clandestina. Nonostante alcuni forti segnali di ripresa della mobilità territoriale, ancora limitati appaiono i movimenti di coloro che sono in cerca di lavoro, ostacolati da una struttura eccessivamente rigida delle retribuzioni e da elevati costi indiretti (abitazione, trasporti).
Pertanto, il Governo, chiede alle istituzioni locali e alle parti sociali se non si convenga che l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in Italia sia oggi ostacolato da una serie di impedimenti normativi e dall’assenza di un adeguato sistema informativo basato su standard accettativi che favoriscono un rapido incontro tra i fabbisogni, i servizi, le soluzioni contrattuali. Allo stato permane nei fatti il monopolio pubblico, per le alte barriere all’accesso imposte ai soggetti privati, in un contesto –non a caso- di abusivismo diffuso
Anzitutto va osservato che la diffusione delle informazioni deve avvenire in un vero e proprio mercato, con una domanda e un’offerta che si confrontano e che determinano un prezzo di scambio. Questo mercato però è del tutto particolare e richiede una certa dose di regolazione e di presenza pubblica. Si pone la necessità di avere regole di accreditamento delle strutture autorizzate a svolgere questa attività, ma le regole non devono essere tali da precludere che anche in questo particolare mercato valgano i principi generali della concorrenza. Questo è quanto insegna anche l’esperienza degli altri paesi più sviluppati.
Non vi è parimenti dubbio che vada potenziata la presenza pubblica. Purtroppo, nel decentramento delle competenze dallo Stato alle Regioni, molti dei vecchi uffici di collocamento si trovano in condizioni di funzionamento anche peggiori di quelle in cui si trovavano prima della riforma. E questo succede proprio in quelle regioni, quelle meridionali, in cui ci sarebbe maggior bisogno di politiche del lavoro dirette ad aiutare e a potenziare l’offerta di lavoro al fine di renderla più “appetibile” nei confronti della domanda. Questa situazione di grave arretramento, documentata nelle periodiche analisi di monitoraggio condotte dall’ISFOL, richiede una precisa azione di recupero e di sostegno. Non è un caso che la stessa Unione Europea sia convinta che questo rappresenta uno dei principali problemi della nostra situazione occupazionale e ci stimoli a condurre una azione di sostegno nei confronti delle amministrazioni delle Regioni in cui le carenze sono più gravi.
Peraltro, anche prima della recente riforma, i nostri uffici di collocamento incidevano ben poco sull’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Spesso a causa di tutti i passaggi burocratici necessari per procedere ad assunzioni di nuovi lavoratori, il servizio pubblico ha consolidato presso le imprese una cattiva immagine di se stesso, tale per cui ben pochi disoccupati hanno effettivamente trovato lavoro con l’aiuto del servizio. Le indagini disponibili indicano che solo il 4% di chi trova lavoro, lo deve a questo servizio. Con questa bassissima percentuale non si può certo pretendere di incidere molto sui segmenti più deboli dell’offerta. Una presenza efficace nel settore dell’intermediazione, nonostante gli impedimenti e le difficoltà frapposti, è stata, di fatto, fornita solo dalle agenzie interinali.
Grave è la mancanza di un adeguato sistema informativo che operi come una borsa continua del lavoro. La legge di riforma ha previsto la costituzione del SIL (Sistema Informativo Lavoro), con caratteristiche di unitarietà ed omogeneità, con il prevalente compito di definire gli standard e realizzare una rete unificata tra i vari livelli operativi (nazionale, regionale, provinciale e circoscrizionale). Tuttavia, allo stato attuale gli obiettivi non sono stati conseguiti sia per le difficoltà incontrate nella fase di avvio dei sottosistemi locali, sia per la mancata affermazione di un chiaro modello organizzativo e funzionale dei nuovi servizi, che sia di riferimento per disegnare l’architettura del sistema informativo nel suo complesso. Ad una impostazione centralista, le Regioni hanno spesso contrapposto un modello autonomista che, nei casi estremi, nega l’esigenza di avere standard comuni (tecnologie compatibili, base dati d’interesse comune, dizionari terminologici, protocolli di comunicazione).
Rilevanti sono inoltre gli impedimenti di carattere normativo. Anzitutto, possono pesare i requisiti di capitalizzazione e le barriere tra le attività di intermediazione. Infatti, la normativa sulle agenzie di lavoro interinale, di collocamento, di selezione prevede il regime di esclusiva nei diversi ambiti di attività. E’ una normativa barocca che paralizza non solo l’attività economica delle agenzie di intermediazione ma, soprattutto, i lavoratori e le imprese che vedono ridimensionato il livello di potenziale offerta del servizio. In secondo luogo, il trattamento dei dati relativi all’incontro tra domanda e offerta è sottoposto a sistemi autorizzativi e vincoli che vanno ben oltre la necessità di validare economicamente le Agenzie di intermediazione, di organizzare le necessarie statistiche e di rispettare la privacy. Quest’ultimo aspetto, peraltro, è insito nell’autorizzazione all’utilizzo dei dati prestata dai lavoratori per finalità commerciali. L’obbligo di inserire in banca dati entro 5 giorni i curricula dei lavoratori che cercano lavoro tramite agenzia appare eccessivo e disincentivante. Non è, poi, certamente giustificato impedire alle imprese ed ai lavoratori di interagire direttamente nella rete delle informazioni. Questa è una delle ragioni principali che impediscono l’adozione di un sistema Internet, aperto e accessibile a tutti, con un sistema autorizzativo limitato a rendere affidabile l’attività degli intermediari, a garantire moralità e gratuità per i lavoratori, nonché l’assolvimento delle funzioni statistiche.
Tav. 6 - Individui che hanno ricevuto offerte di lavoro e consulenza dal servizio pubblico per l'impiego e da soggetti privati nel 2000 (soggetti tra 15 e 64 anni di età, in migliaia)
| Tipologie di offerta | Centro-Nord | Mezzogiorno | Italia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iscritti SPI | Non iscritti SPI | Iscritti SPI | Non iscritti SPI | Iscritti SPI | Non iscritti SPI | |||||||
| 1° sem. | 2° sem. | 1° sem. | 2° sem. | 1° sem. | 2° sem. | 1° sem. | 2° sem. | 1° sem. | 2° sem. | 1° sem. | 2° sem. | |
| Partecipazione a corsi di formazione professionale regionali | 20 | 10 | 53 | 24 | 17 | 11 | 7 | 5 | 37 | 21 | 60 | 29 |
| Progetti finanziati dallo Stato | 13 | 9 | 18 | 15 | 30 | 17 | 7 | 4 | 43 | 25 | 25 | 19 |
| Offerte di lavoro dai SPI | 44 | 36 | - | - | 21 | 18 | - | - | 65 | 53 | - | - |
| Consulenza nella ricerca di lavoro + fornita dai SPI | 10 | 10 | - | - | 21 | 10 | - | - | 31 | 20 | - | - |
| Offerte da privati o agenzie private | 105 | 90 | 354 | 313 | 38 | 34 | 27 | 18 | 143 | 124 | 381 | 330 |
| Totale individui con almeno un'offerta | 181 | 148 | 417 | 348 | 125 | 86 | 40 | 28 | 306 | 234 | 457 | 376 |
3.4. Formazione
Occorre prendere atto che il sistema formativo esistente è inadeguato rispetto alle esigenze delle imprese e del mercato del lavoro, come è riconosciuto dalla stessa Unione Europea, la quale riserva in genere un giudizio alquanto negativo delle nostre politiche attive del lavoro, in occasione dei Piani Nazionali per l’Occupazione, soprattutto per quanto concerne la formazione permanente. Non si tratta certo di un problema di scarsità di risorse ma di governo, finalità e allocazione delle stesse. Nonostante un processo di trasformazione in atto, soprattutto nelle Regioni del Centro-Nord, centrato sulla definizione di obiettivi di policy e sulla conseguente allocazione delle risorse finanziarie su base d’asta, è ancora presente un contesto in cui l’offerta formativa, pubblica e convenzionata, tende a condizionare la domanda e la qualità del servizio erogato.
In quest’ambito occorre rendere effettivo l’impegno, richiestoci ancora una volta dalle autorità comunitarie, di costruire una società della conoscenza che si fondi su un sistema formativo che accompagni il lavoratore durante tutto l’arco della vita.
Il passaggio fra scuola e lavoro penalizza i nostri giovani. I lunghi tempi di attesa dimostrano come quello della scuola e quello del lavoro siano due mondi distanti, che quasi si ignorano. I tirocini, su cui i precedenti governi facevano molto affidamento, riguardano meno del 5% dei giovani. Lo stesso istituto dell’apprendistato, sia pure oggetto di una importante riforma, è ben lontano dallo svolgere il ruolo che in altri Paesi svolge invece con grande successo.
Ma è tutto il sistema della formazione e dell’addestramento professionale a soffrire di carenze di vario tipo. L’obiettivo di integrare le varie fasi in cui si sviluppa il processo di apprendimento, quella della formazione scolastica, quella della qualificazione professionale e quella dell’attività lavorativa, è stato proclamato come un obiettivo fondamentale da tutta la nuova legislazione; di fatto questa integrazione è ancora ben lontana dall’essere realizzata.
Il problema di una maggior integrazione tra formazione e lavoro non riguarda solo i giovani, ma tutti i lavoratori occupati. In un’economia che richiede continui adattamenti delle conoscenze, la formazione continua riveste un ruolo di primo piano. Non si tratta solo di aumentare la produttività dei lavoratori sui posti di lavoro occupati, bensì di potenziare il loro capitale umano in generale, al fine di renderli più “forti” nel mercato del lavoro e di aumentare la mobilità, di cui il nostro paese ha assolutamente bisogno. Proprio perché ogni forma di formazione professionale contiene elementi di capitale umano di tipo generale e quindi trasferibile da parte del lavoratore, da un’impresa ad un’altra, non sempre le imprese sono disposte ad effettuare gli investimenti che sarebbe invece utile fare, proprio per il timore di fare un investimento che sarebbe sfruttato da altri.
Il mercato della formazione continua è imperfetto, produce esternalità e non sempre i lavoratori e le imprese sono sufficientemente lungimiranti (o hanno le risorse necessarie) per investire nella loro formazione. Per questo il mercato deve essere aiutato, attraverso l’utilizzo di risorse pubbliche che alzino il livello di investimento; la formazione è importante quanto l’innovazione come fattore di crescita economica.
Parte Seconda. Le Proposte / Promuovere una società attiva ed un lavoro di qualità
I. Regole e strumenti
I.1. Europa e Federalismo
I.1.1. “Coordinamento aperto” per l’occupazione
Primario obiettivo del Governo è la promozione di azioni funzionali al rapido innalzamento del tasso di occupazione, in modo tale da conseguire gli obiettivi - quantitativi ma anche qualitativi – indicati dal Consiglio Europeo di Lisbona del 2000 e da quello di Stoccolma di quest’anno.
Il Governo italiano intende far proprio l’obiettivo dell’Unione Europea di realizzare una condizione di piena occupazione (e di piena occupabilità, quindi mettendo tutti in condizione di trovare un lavoro) con una particolare attenzione alla qualità del lavoro. Per questo motivo nel documento integrativo del Piano nazionale per l’occupazione 2001 inviato alle autorità comunitarie dopo l’insediamento di questo Governo sono stati esplicitamente indicati target quantitativi, coerenti con le azioni di politica economia finora previste.
Occorre, infatti, ricordare che le politiche del lavoro devono essere condotte coerentemente con la Strategia Europea sull’Occupazione, prevista dal Trattato di Amsterdam e varata dal Consiglio Europeo straordinario sull’occupazione di Lussemburgo (novembre 1997). In considerazione dell’eccezionale rilevanza del tema occupazione, il Consiglio deliberò un’applicazione anticipata di questa parte del Trattato, ancor prima della ratifica dei Parlamenti (ovvero in sede referendaria) degli Stati membri. Dopo alcuni anni di sperimentazione il “processo di Lussemburgo” si è affermato come il primo convincente esempio di applicazione della metodologia del “coordinamento aperto”, esteso successivamente dalla politica per l’occupazione a quella per la protezione sociale e, ancor più recentemente, al tema dell’immigrazione extracomunitaria. L’attendibilità di questo processo si è consolidata nel corso di questi anni ed occorre pertanto assumere con grande attenzione le ‘Raccomandazioni’ che nell’annuale Rapporto congiunto del Consiglio e della Commissione vengono indirizzate dall’Unione Europea.
Occorre prestare maggiore attenzione a questo processo di “coordinamento aperto”, poiché esso non riguarda soltanto i Governi, pur responsabili in rappresentanza degli Stati membri. I diversi soggetti istituzionali territoriali (Regioni ed enti locali) e le stesse parti sociali devono contribuire in modo più efficace alla realizzazione delle “linee guida” sull’occupazione che ogni anno vengono concordate in sede comunitaria e quindi diventano vincolanti. Il Governo italiano condivide pienamente a tale proposito le proposte della Commissione europea inserite nel Libro Bianco European Governance: A White Paper (25 luglio 2001, COM(2001) 428) favorevole ad un ulteriore estensione di questa innovativa metodologia regolatoria.
Il Governo richiama le Regioni e gli enti locali a dare seguito alle indicazioni comunitarie che a loro volta prevedono - oltre al Piano Nazionale di Azione per l’ Occupazione (National Action Plan for Employment, NAP) che coinvolge la responsabilità del Governo - la predisposizione di Piani regionali di Azione per l’ Occupazione (Regional Action Plan for Employment, RAP), davvero essenziali anche per la programmazione dell’ uso dei fondi strutturali, ed anche di Piani locali (Local Action Plan for Employment, LAP), sempre in attuazione delle “linee guida” comunitarie. Se ed in quanto Regioni ed enti locali matureranno tale orientamento, sarà possibile il loro concorso non episodico ma organico alla predisposizione del NAP.
Anche le parti sociali sono invitate a concorrere all’attuazione di questo esercizio di coordinamento comunitario, tenuto conto del fatto che sono numerose le “linee guida” (ad esempio in tema di adattabilità) che assegnano loro precise responsabilità nel predisporre un assetto regolatorio su base negoziale. Ed in ogni caso ad esse si chiede di operare in funzione maggiormente propositiva, unitariamente o singolarmente, ben oltre la semplice informazione con richiesta di osservazioni che ha caratterizzato la preparazione dei Piani Nazionali per l’occupazione negli anni passati. E’ opportuno invece che questo esercizio annuale – di progettazione di misure future ma anche di verifica e monitoraggio dell’attuazione di quelle già in essere – divenga un momento di confronto fra parti sociali ed il Governo (e, al rispettivo livello, le Regioni e gli enti locali) per realizzare un più maturo sistema di partenariato istituzionale e sociale.
I.1.2. Buone pratiche in Europa
Non sembra possibile mantenere inalterato un assetto regolatorio dei rapporti e dei mercati del lavoro che, sotto più profili, non appare in linea con le indicazioni comunitarie e le migliori prassi derivanti dall’esperienza comparata. Gli interventi comunitari regolano il nuovo mercato domestico ed il sistema italiano deve adeguarsi, dotandosi di un assetto istituzionale in qualche modo comparabile con quelli esistenti in altri Stati membri, in quanto altrimenti si registrerebbero effetti distorsivi sul piano della concorrenza. L’equivalenza degli assetti regolatori in materia di rapporti e mercati del lavoro assume una funzione strategica per governare la tendenza alla delocalizzazione, effetto certo non trascurabile della globalizzazione dell’economia.
Non si tratta di realizzare un’uniformità regolatoria su scala trasnazionale che, soprattutto dopo il Trattato di Nizza, non è più negli obiettivi dell’ordinamento comunitario che esclude ormai interventi di armonizzazione nell’area della politica sociale. Occorre piuttosto ragionare in una logica di benchmarking, cioè valutando di volta in volta il contesto di altri Stati membri dell’Unione Europea, ma anche esperienze extracomunitarie di Paesi che con noi competono su scala globale come gli Stati Uniti e il Giappone. Si tratta di individuare le buone pratiche affermatesi nei diversi contesti nazionali od anche regionali, approfondendone le potenzialità ed i fattori di successo, per riflettere in termini di possibile trasposizione in altri contesti. E’ questa una metodologia che costituisce parte integrante del ‘metodo aperto di coordinamento’, utilizzato in sede comunitaria nell’ambito del ‘processo di Lussemburgo’.
L’ordinamento italiano del lavoro si è sviluppato per regolare un mercato nazionale, un sistema economico non globalizzato. E’ quindi evidentemente inadeguato a svolgere una funzione in un contesto in cui il mercato è ormai divenuto trasnazionale, comunitario ed internazionale. L’adeguamento del quadro normativo nazionale rispetto alle indicazioni comunitarie e all’esperienza comparata diventa, dunque, un fattore essenziale nel gioco competitivo dei soggetti economici che al rispetto di questo sistema di regole sono tenuti.
I.1.3. Lavoro e federalismo
Il dialogo fra diritto comunitario ed ordinamento interno può agire da catalizzatore nel senso di una riforma dell’assetto istituzionale interno preposto alla regolazione del mercato e dei rapporti di lavoro, con particolare attenzione ad una re-distribuzione delle competenze attraverso i vari livelli istituzionali. Una conseguenza che del resto potrà derivare anche dall’applicazione del nuovo art. 117 della Costituzione, così come emendato dalla recente riforma costituzionale, che assegna alle Regioni potestà legislativa concorrente in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”, “professioni”, nonché “previdenza complementare e integrativa”.
L’intera disciplina del lavoro dipendente ed autonomo, unitamente ai profili previdenziali che non ricadono nell’ambito del sistema pubblicistico, in questa ipotesi verrebbe dunque attribuita alle Regioni alle quali, come ancora recita lo stesso art. 117, spetta “la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”. Si tratta di un progetto assai innovativo che impegna lo Stato a definire tali “principi fondamentali”, tenendo conto, sempre a mente del medesimo disposto costituzionale, che “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
Non sembrano del resto esservi dubbi di sorta circa la portata di queste disposizioni. La potestà legislativa concorrente delle Regioni riguarda non soltanto il mercato del lavoro, in una logica di ulteriore rafforzamento del decentramento amministrativo in atto, bensì anche la regolazione dei rapporti di lavoro, quindi l’ intero ordinamento del lavoro.
Il nuovo art. 120 della Costituzione, chiarisce ancora che non solo “la Regione non può … limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale” ma aggiunge anche che “il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni … nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria … ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”. Spetterà quindi alla legislazione ordinaria precisare “le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”.
Dunque il nuovo assetto costituzionale attribuisce nuove funzioni alle Regioni, senza tuttavia delineare compiutamente un modello federalista, ciò che anzitutto presupporrebbe una rappresentanza a livello nazionale delle stesse Regioni. Resta il fatto che il riconoscimento della potestà legislativa concorrente alle Regioni in materia di mercato e rapporti di lavoro costituisce un elemento che occorre pienamente valorizzare, respingendo interpretazioni riduttive che la limiterebbero ad una funzione meramente implementativa delle politiche nazionali. Sarà il principio di sussidiarietà (nel superamento del criterio di competenza, transitando dalla logica di garanzia a quella di funzionalità) a guidare un processo di riassetto istituzionale dell’impianto regolatorio, così come è avvenuto e sta tuttora avvenendo nel dialogo fra diritto comunitario e diritto nazionale.
Sarà così possibile realizzare differenziazioni regionali che colgano le diversità dei mercati del lavoro locali, superando una stratificazione dell’ordinamento giuridico inadeguata rispetto ai mutamenti intervenuti nell’organizzazione del lavoro. Un’occasione di modernizzazione che non può essere persa, pure perseguendo, nel contempo, la realizzazione di un più compiuto disegno federalista di carattere generale.
I.1.4. Coesione sociale
La valorizzazione della potestà legislativa regionale non deve essere compromessa drammatizzando il rischio di un’autonomia intesa come disgregazione sociale. E’, infatti, l’ordinamento comunitario che in materia economica e sociale provvede a fissare i principi fondamentali che devono ispirare il legislatore regionale. Pur essendo auspicabile una larga intesa con riferimento alla normativa cornice di carattere nazionale, così da salvaguardare il principio di uguaglianza senza peraltro cedere alla logica centralistica di una uniformità assoluta di trattamento, conviene indicare nella “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”, proclamata solennemente in occasione del Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, il punto di riferimento, certo non esclusivo ma altamente significativo, per esercitare la potestà legislativa interna. E’ utile richiamare in proposito alcuni disposti che più direttamente si riferiscono alla tutela e sicurezza del lavoro:
- proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (art. 5);
- protezione dei dati di carattere personale (art. 8);
- libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 10);
- libertà di espressione e di informazione (art. 11);
- libertà di riunione e di associazione (art. 12);
- libertà professionale e diritto di lavorare (art. 15);
- non discriminazione (art. 21);
- parità tra uomini e donne (art. 23);
- diritti degli anziani (art. 25);
- inserimento dei disabili (art. 26);
- diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’ impresa (art. 27);
- diritto di negoziazione e di azioni collettive (art. 28);
- diritto di accesso ai servizi di collocamento (art. 29);
- tutela in caso di licenziamento ingiustificato (art. 30);
- condizioni di lavoro giuste ed eque (art. 31);
- divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro (art. 32);
- vita familiare e vita professionale (art. 33); sicurezza sociale e assistenza sociale (art. 34);
- protezione della salute (art. 35).
Su queste materie, individuate nella “Carta” di Nizza, e, più in generale, sulle tematiche oggetto di intervento comunitario, per mezzo di direttive anche di recepimento di intese fra gli attori sociali, appare opportuno che il legislatore nazionale intervenga con una normativa-cornice che assicuri un sufficiente grado di tutela minima. Si tratta di adempimenti di obblighi traspositivi che coinvolgono la responsabilità diretta dello Stato ed in ogni caso vengono toccati diritti fondamentali che reclamano una regolazione nazionale. Sarebbe oltremodo auspicabile che sul punto si esprimessero le stesse parti sociali, oltre che le Regioni, in modo che si apra un fruttuoso confronto sulle caratteristiche e quindi sulla portata della legislazione quadro in materia di lavoro.
L’imperativo di salvaguardare sempre e comunque i “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (art. 117 Cost.) implica uno sforzo progettuale che comporterà necessariamente la rivisitazione di tutti gli istituti che compongono attualmente la legislazione nazionale in materia di mercati e rapporti di lavoro.
Il Governo auspica che su questo argomento, - così innovativo dal punto di vista istituzionale ed altrettanto complesso sul piano dei valori coinvolti e delle tecniche regolatorie utilizzabili – si possano acquisire importanti e significativi contributi di tutti gli interlocutori istituzionali e sociali destinatari del presente Libro Bianco.
I.2. Dialogo sociale
Gli anni novanta sono stati gli anni della concertazione sociale. Le necessità di conseguire importanti obiettivi a livello comunitario favorì l’opzione concertativa. Imperativa era l’esigenza di rafforzare il coordinamento nel governo delle dinamiche nominali dei redditi per evitare derive inflazionistiche. Inoltre, l’intervento sui saldi netti del bilancio pubblico andava fatto rapidamente ed in un clima di consenso sociale, onde evitare tensioni e ricadute inflazionistiche. Va del resto sottolineato come molti dei paesi, anche al di fuori del tradizionale novero di paesi cosiddetti corporativismi, che all’inizio del decennio riscontravano problemi di convergenza rispetto ai criteri di Maastricht, hanno optato per l’uso della concertazione sociale.
Tuttavia, nei fatti, la concertazione ha svolto compiti di governo ben di là degli obiettivi di sviluppare un corretto rapporto tra le parti. Il processo avviato nel 1992 dal I° Governo Amato è stato progressivamente snaturato e portato a ribaltare la logica culturale che l’aveva innestato. Quando, da parte dei diversi governi che si sono succeduti, vi è stato un uso eccessivo della concertazione, intesa come sede consultiva e di legittimazione politica in merito ad iniziative che, in linea di principio, erano spesso di esclusiva competenza del Governo si è determinato un uso distorto e viziato della concertazione stessa. Rispetto ad alcune esperienze generalmente ritenute positive, in particolare il caso olandese, è peraltro da rilevare come il potere d’iniziativa - di fissazione dell’agenda e delle principali linee di azione- da parte dei governi sia stato, in Italia, piuttosto limitato, in buona parte a causa dell’accentuata debolezza politica di quei governi.
E’ del tutto evidente l’impossibilità del modello concertativo degli anni novanta di affrontare la nuova dimensione dei problemi economici e sociali. La concertazione ha, infatti, mantenuto fermi nella politica economica due obiettivi fondamentali: il risanamento dei conti pubblici e l’ingresso dell’Italia nell’Euro. Intorno al ruolo della contrattazione nazionale centralizzata e dell’inflazione programmata si è sviluppato lo scambio fondamentale tra governo e parti sociali. La moderazione salariale e l’abbassamento dell’inflazione hanno consentito il risanamento dei conti pubblici sul versante degli interessi; la produttività del sistema è stata assorbita in gran parte dall’aumento della pressione fiscale, mentre è sostanzialmente rimasta inalterata la quota della spesa sociale sul PIL (con un aumento della spesa pensionistica ed un calo di quella sanitaria). Difesa del salario reale e delle prestazioni sociali (con una compressione della dinamica) sono stati i vantaggi per i sindacati e per i lavoratori. La contrattazione salariale è stata negli anni novanta il riflesso delle esigenze macroeconomiche, rivelandosi irrilevante ai fini di una corretta allocazione dei fattori produttivi. La forbice tra salari contrattuali e quelli di fatto (in alto e in basso) si è aperta ulteriormente.
Tuttavia, raggiunti gli obiettivi dell’abbassamento dell’inflazione e dell’ingresso nell’Euro, i suoi limiti sono subito apparsi evidenti. Emerge con evidenza l’inadeguatezza di un sistema contrattuale centralizzato, il cui perno centrale è rappresentato da un indicatore economico (l’inflazione programmata) che svolge una funzione sociale (difesa del salario reale) ma è indifferente rispetto alle esigenze reali delle singole imprese. La moneta unica, ed il patto di stabilità, richiedono, invece, nel contempo una capacità di rendere strutturali le riforme (mercato del lavoro, previdenza e welfare, fiscali e contributive) e di flessibilizzare l’utilizzo dei fattori produttivi e della loro remunerazione. Inoltre, la competitività del sistema Italia non è più mediata dalla politica monetaria.
Nel nuovo quadro macro-economico, l’espansione della base produttiva e dell’occupazione non può prescindere da una riduzione della pressione fiscale e contributiva nonché da corretta remunerazione dei fattori produttivi. Un eccesso di rigidità delle remunerazioni penalizza l’espansione occupazionale nelle aree a bassa produttività (ovvero favorisce la crescita del sommerso) e contribuisce alle distorsioni territoriali dello sviluppo. La concertazione ha in realtà sistematicamente rinviato la definizione di un nodo centrale delle relazioni industriali, quello della struttura della contrattazione. Nell’Unione Monetaria Europea, l’esigenza di riforma degli equilibri interni della contrattazione salariale fa premio su quella della moderazione salariale aggregata. Al tempo stesso un completamento organico delle riforme in tema di mercato del lavoro e del welfare non può prescindere dall’iniziativa e dalla capacità decisionale del Governo.
I.2.1. Il modello comunitario
In questa situazione le esigenze attuali dell’economia italiana inducono a sperimentare una pratica di “partnership per la competitività e l’occupazione”, dove il confronto fra istituzioni e parti sociali assuma la valenza non di un obiettivo in sé, ma di uno strumento utile al conseguimento di obiettivi di volta in volta condivisi. Il passaggio dalla politica dei redditi ad una politica per la competitività impone l’adozione di una nuova metodologia di confronto, basata su accordi specifici, rigorosamente monitorati nella loro fase implementativa, restando meglio precisata la distinzione delle reciproche responsabilità tra Governo e parti sociali.
Il Governo ritiene che il modello del dialogo sociale, così come regolamentato e sperimentato a livello comunitario, costituisca il punto di riferimento più convincente per una rinnovata metodologia nei rapporti fra istituzioni e parti sociali anche a livello interno. In tal senso, appare del tutto condivisibile la “posizione comune” assunta il 16 luglio 2001 in Francia dalle parti sociali ed indirizzata a quel Governo. Il dialogo sociale non può soltanto rappresentare la soluzione del tutto prioritaria per la trasposizione di direttive comunitarie nell’ordinamento interno, bensì deve costituire anche il metodo per regolare la produzione di regole in tema di affari sociali, con particolare riguardo alla modernizzazione del mercato del lavoro.
Non soltanto a livello statale, ma anche delle Regioni, prima di assumere interventi legislativi o comunque di natura regolatoria in campo sociale e dell’occupazione, è necessario che le istituzioni consultino le parti sociali circa l’intenzione di intervenire su una certa materia che non comporti impegni di spesa pubblica, sollecitandone una reazione in termini di opportunità e modalità di realizzazione. Al termine di questa prima fase di consultazione, da contenere in tempi ragionevolmente brevi, qualora il Governo o la Regione intenda proseguire con l’iniziativa regolatoria dichiarata nella fase precedente, alle parti sociali dovrebbe essere offerta l’opportunità di negoziare sul tema che forma oggetto della iniziativa in questione, assegnando anche in questa occasione un termine ben determinato.
Solo in caso di rifiuto delle parti sociali di impegnarsi in un negoziato, ovvero nell’ipotesi di un esito infruttuoso del medesimo, l’iniziativa legislativa promanante dal Governo o dalla Regione potrà riprendere il suo corso. Nel caso in cui invece il negoziato si sarà concluso positivamente, dovrà prevedersi un impegno politico del Governo o della Regione alla traduzione legislativa dell’intesa stessa.
La stessa funzione del presente Libro Bianco si ispira alla metodologia comunitaria. Riconoscere il primato del dialogo sociale in funzione regolatoria nell’area sociale e dell’occupazione significa riconoscere alle parti sociali un ruolo assai impegnativo che comporta responsabilità quasi legislative. Del resto il Governo ritiene che se questa importante responsabilità è stata riconosciuta dall’ordinamento comunitario nei confronti di attori sociali caratterizzati da un’attività di pochi lustri, a maggior ragione essa possa essere richiesta ad organizzazioni che invece affondano le proprie radici in una storia talvolta secolare, caratterizzandosi per alti livelli di rappresentatività. Naturalmente l’adozione di tale metodologia, assai rispettosa delle reciproche competenze ed attribuzioni, senza alcuna confusione di ruoli, non può compromettere la rapidità del procedimento decisionale. In caso di disaccordo tra gli stessi attori sociali sarà necessario, uniformandosi anche in questo senso all’ esperienza francese, ricorrere alla regola della maggioranza, senza pretendere unanimismi che pregiudicherebbero il buon funzionamento dello stesso dialogo sociale.
Il Governo auspica di poter raccogliere su questa proposta commenti e valutazioni degli interlocutori istituzionali e sociali.
Quanto fin qui affermato non significa a giudizio del Governo escludere il raggiungimento di nuove intese di tipo triangolare, sia a livello nazionale, sia a quello regionale e territoriale. Del resto non solo in Italia ma in molti Paesi europei intese trilaterali sfociano con crescente intensità in patti sociali. Associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali in diversi contesti nazionali hanno stipulato accordi con le autorità governative in materia occupazionale, con ciò svolgendo una funzione in passato di esclusiva spettanza dei poteri pubblici.
Le “linee guida per l’occupazione” -varate nell’ambito del processo di Lussemburgo- attribuiscono alle parti sociali l’assunzione di crescenti responsabilità a riguardo. In proposito appare necessario indirizzare questa attività sul piano locale – anche tenendo conto dei nuovi poteri riconosciuti alle Regioni dalla recente riforma sul federalismo - al fine di cogliere le peculiarità del mercato del lavoro all’interno di ciascun contesto territoriale. Occorre quindi sottoporre a valutazione critica la stagione dei “patti nazionali”, accogliendo una visione regionalista delle politiche del lavoro che coinvolga a questo livello le parti sociali. Tali intese definite su scala territoriale dovranno muoversi in un contesto dinamico, fatto di utili deroghe concordate nei confronti della legislazione e contrattazione a livello nazionale.
I.3. Tecniche regolatorie
I.3.1. Ordinamento comunitario e tecniche di trasposizione
Riflettendo sull’esperienza comunitaria e nella prospettiva di transitare verso un ordinamento federale, si evince la necessità di ripensare radicalmente lo stesso sistema delle fonti dell’ordinamento giuridico del lavoro. Il ruolo della legislazione nazionale dovrebbe essere limitato alla definizione dei diritti fondamentali della persona nel contesto lavorativo. Allorché si tratti di legislazione traspositiva di obblighi comunitari, il legislatore nazionale dovrà in futuro introdurre norme che soddisfino di per se stesse l’obbligo traspositivo, nel rispetto delle prerogative regionali di intervenire con atti di legislazione concorrente per rendere il dato normativo comunitario e nazionale più aderente alle caratteristiche dei mercati del lavoro locali. Del resto il nuovo ruolo legislativo affidato alle Regioni non potrà certo sollevare lo Stato dalla responsabilità primaria di fronte alle autorità comunitarie con riferimento alo stesso processo traspositivo.
Anche la legislazione nazionale di trasposizione diverrà sempre più una legislazione di principi, implementando la direttiva per quanto concerne le scelte fondamentali di adattamento all’ordinamento interno, lasciando tuttavia al legislatore regionale la possibilità di dispiegare pienamente l’esercizio della potestà legislativa concorrente mediante interventi di specificazione dei principi definiti nazionalmente.
Resta fermo, a giudizio del Governo, il primato del dialogo sociale nella trasposizione delle direttive comunitarie, in ossequio a quanto disposto dal Trattato dell’Unione Europea e soprattutto allorché le direttive stesse siano il risultato di questo esercizio condotto su scala comunitaria. Le parti sociali potranno in tale circostanza valutare forme appropriate per assicurare che il processo traspositivo tenga conto delle caratteristiche dei mercati del lavoro locali, nel quadro del nuovo ordinamento federalista.
Il Governo si riconosce pienamente nel principio per cui l'attuazione delle direttive comunitarie non costituisce in nessun caso un valido motivo per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nei settori da esse trattati. Resta tuttavia impregiudicato il diritto degli Stati membri e/o delle parti sociali di stabilire, alla luce dell'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse rispetto a quelle vigenti al momento dell'adozione della presente direttiva, purché le prescrizioni minime previste da quest'ultima siano rispettate. Il significato di questa “clausola di non regressione” è da intendersi nel senso che non deve verificarsi una regressione del livello generale di protezione dei lavoratori in seguito all'adozione della direttiva comunitaria, pur lasciando agli Stati membri la possibilità di adottare misure diverse dettate dalla loro politica socioeconomica, e questo nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal legislatore comunitario. La pretesa che l’ordinamento giuridico debba restare in sostanza immodificabile contrasterebbe con la natura stessa del processo traspositivo che rappresenta esso stesso un momento di aggiornamento del quadro regolatorio rispetto all’ insieme di disposizioni entrate in vigore a livello comunitario, nonché in relazione all’ evolversi della sottostante realtà economica e sociale.
Il Governo italiano ritiene che occorra prestare molta attenzione alla qualità del processo traspositivo, evitando che si ricostituiscano gli elementi distorsivi della concorrenza che la direttiva stessa aveva inteso rimuovere. In questo senso la “clausola di non regressione” mantiene un suo valore del tutto indiscutibile, soprattutto nella prospettiva dell’allargamento dell’Unione Europa e l’integrazione con sistemi economici e sociali assai differenti da quelli degli attuali Stati membri. La stessa Commissione europea dovrebbe prestare maggiore attenzione alla qualità del processo traspositivo, non limitandosi a rilevare soltanto gli estremi per le procedure di infrazione. Il Governo invita le parti sociali ad approfondire nel dialogo fra di loro questi profili dell’esercizio traspositivo, anche al fine di esaltarne le potenzialità di modernizzazione per assicurare tutele qualitativamente efficaci ai lavoratori italiani.
I.3.2. Leggi e contratti
Il principio di sussidiarietà – già fondamentale nel rapporto fra ordinamento comunitario e nazionale, nonché a proposito del dialogo fra Stato e Regioni nel costituendo ordinamento federalista - deve secondo il Governo applicarsi anche nel rapporto fra intervento pubblico e attività delle parti sociali. Il legislatore (nazionale o regionale) dovrebbe intervenire solo dove le parti non abbiano sufficientemente svolto un ruolo regolatorio. In questo senso verrebbe esaltata appieno la funzione del contratto collettivo (nella sua prospettiva interaziendale) come strumento regolatore di una corretta competizione fra imprese sul piano sociale.
Nel contempo, occorre, però, riconoscere i profondi mutamenti intervenuti nell’organizzazione del lavoro, la crescente spinta verso una soggettività nel vissuto della propria condizione lavorativa e quindi rivalutare convenientemente il ruolo del contratto individuale. Tale valorizzazione potrebbe avvenire quantomeno con riferimento a singoli istituti o laddove (per ragioni di mercato del lavoro connesse anche all’alta professionalità del lavoratore in questione) esistano condizioni di sostanziale parità contrattuale tra le parti ovvero anche in caso di specifici rinvii da parte della fonte collettiva. Il Governo chiede alle parti sociali se e a quali condizioni sia possibile modificare l’attuale contesto normativo che inibisce al datore e prestatore di lavoro di concordare condizioni in deroga non solo alla legge ma anche al contratto collettivo, se non entro il limite, sempre più ambiguo, delle condizioni di miglior favore. In un contesto crescentemente individualizzato di rapporti e contratti di lavoro sono individualizzate anche le scelte dei prestatori: ciò che può essere migliorativo per l’uno, può risolversi in una condizione di peggior favore per l’ altro.
E’ utile a tal proposito rifarsi all’esperienza comparata, anche al fine di dimostrare che la prospettiva delineata in alcun modo comporta un appannamento del ruolo della contrattazione collettiva, quanto semmai una sua diversa concezione. Nei Paesi Bassi si sta sperimentando in proposito un sistema di raccordo fra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro definito "a scelta multipla", dove cioè il lavoratore può optare, d’intesa con il datore di lavoro, fra diversi istituti negoziati in sede collettiva. Ad esempio un livello salariale inferiore in cambio di maggior sicurezza del posto di lavoro, scambio fra miglior trattamento retributivo ed allungamento del nastro orario, rinuncia all’indennità natalizia a fronte di azioni della società e così via.
Il Governo pertanto invita le parti sociali a valutare la possibile ridefinizione del rapporto fra momento collettivo ed individuale nella regolazione del rapporto di lavoro, rendendo possibile la definizione di assetti regolatori effettivamente conformi agli interessi del singolo lavoratore ed alle specifiche aspettative in lui riposte dal datore di lavoro, nel contesto d’un adeguato controllo sociale. In aggiunta si potrebbero studiare percorsi a garanzia della effettiva volontà del lavoratore (per realizzare una sorta di “derogabilità assistita”, secondo meccanismi di certificazione e/o validazione della volontà individuale), ad opera di istituzioni pubbliche o anche delle stesse parti sociali, al fine di corrispondere alle attese di flessibilità delle imprese ma anche alle nuove soggettività dei prestatori di lavoro.
Sempre in sede comunitaria, è stata sperimentata con successo una nuova tecnica nel rapporto fra legge e contrattazione collettiva che a giudizio del Governo merita senz’altro di essere ripresa anche all’interno dell'ordinamento italiano. Il riferimento è all’esperienza applicativa della direttiva comunitaria sui "comitati aziendali europei" (CAE). Questa direttiva europea del 1994 affida, infatti, alle parti (direzione centrale della società multinazionale e la rappresentanza dei lavoratori) l’individuazione della composizione e delle funzioni del "comitato aziendale europeo". Solo ed esclusivamente in mancanza di un accordo tra tali soggetti scattano le previsioni di legge; altrimenti l’intesa negoziale è in grado di sostituire interamente il testo normativo che in sostanza non si applica poiché si ritiene già raggiunto il fine che il legislatore si era prefisso di conseguire. Nel caso della direttiva CAE il risultato è stato di oltre 600 accordi stipulati fino ad oggi: in pratica oltre un terzo delle multinazionali hanno preferito la strada negoziale all’applicazione della legge.
Il Governo considera estremamente interessante questo tipo di intervento legislativo che riconosce un ruolo non tanto promozionale quanto premiale alla contrattazione collettiva e ritiene che la direttiva CAE dovrebbe dunque essere assunta come modello anche in Italia ai fini dell’intervento normativo nella materia del diritto del lavoro e delle relazioni industriali. Del resto il compromesso adottato al Consiglio europeo di Nizza (dicembre 2000) sugli aspetti partecipativi riguardanti la Società Europea è largamente ispirato a questo modello. Il Governo auspica di ricevere su questa proposta adeguati approfondimenti delle parti sociali, allo scopo di progettare nuove misure che riprendano questa metodologia adottata in sede comunitaria, e conferire alle parti sociali un ruolo sostanzialmente para-legislativo in modo di stimolare il raggiungimento di intese per realizzare assetti regolatori più confacenti alle singole realtà aziendali.
I.3.3. “Norme leggere” (soft laws)
L’ordinamento giuridico del lavoro in Italia è stato costruito sul presupposto che i rapporti tra datori e prestatori di lavoro siano presidiati da regole vincolanti, dettate dal legislatore o convenute in sede di contrattazione collettiva. Un’impostazione precettiva e prescrittiva che, nella normalità dei casi, produce norme inderogabili, cioè tali da escludere la libera pattuizione individuale e comunque tali da non lasciare alcuna flessibilità alle parti, se non in senso migliorativo per il lavoratore. Spesso si tratta di precetti eccessivamente rigidi, sovente inattuabili, tali da favorire l’evasione e gli aggiramenti, fomentando comunque il contenzioso.
Ancora una volta l’esperienza comparata dimostra che è possibile modernizzare l’ordinamento del lavoro anche sul piano delle tecniche di regolazione. Nei Paesi di tradizione di common law esistono strumenti diversi, come per esempio i codes of practice e, più in generale, le soft laws (“norme leggere”), che mirano ad orientare l’attività dei soggetti destinatari, senza peraltro costringerli ad uno specifico comportamento, vincolandoli tuttavia al conseguimento di un determinato obiettivo. Tali tecniche sono entrate ormai a far parte dell’ordinamento giuridico comunitario. Nell’ambito della Strategia europea per l’occupazione vengono annualmente definiti dal Consiglio gli “orientamenti” in materia di occupazione che costituiscono senz’altro forme di soft laws. Il Consiglio europeo di Stoccolma (aprile 2001) ha preannunciato l’elaborazione, a cura del Consiglio di concerto con la Commissione, di indicatori (anche quantitativi) sulla qualità del lavoro, da adottarsi al Consiglio europeo di Laeken (dicembre 2001). Ancora una volta si tratterà di “norme leggere”, focalizzate sull’obiettivo finale da conseguire assai più che non sulla coercizione ad osservare un comportamento predeterminato minuziosamente in sede legislativa.
Il Governo intende contribuire alla riflessione in corso circa l’identificazione di indicatori di qualità a livello europeo, nella consapevolezza che, in ogni caso, essi non dovranno tradursi in ulteriori vincoli, bensì in strumenti per incentivare opportuni investimenti, anche di carattere formativo, nelle risorse umane.
Tutto lascia quindi prevedere che questa tecnica regolatoria si diffonderà sempre più. I primi esempi di “norme leggere” potrebbero essere sperimentalmente inseriti all’interno dei contratti collettivi nazionali di lavoro, sotto forma di clausole che rinviino alla contrattazione di secondo livello, pur prefigurando il conseguimento di obiettivi predeterminati e preconcordati. Le stesse parti sociali a livello comunitario hanno peraltro già cominciato a sperimentare la stipulazione di accordi sotto forma di “linee guida”, com’è accaduto nel dialogo sociale settoriale che ha prodotto recentemente intese sulla regolamentazione del telelavoro.
Il Governo esprime grande interesse nei confronti della recente intesa intercategoriale sul telelavoro a livello comunitario sulla base di linee-guida od orientamenti. Essa riveste, infatti, un grande significato paradigmatico, costituendo un utile modello per la possibile utilizzazione di questo strumento anche su scala nazionale, soprattutto nell’ottica di una transizione verso un assetto federalista anche in materia di lavoro. Poiché non si tratta di un accordo quadro non sarà necessario un intervento del Consiglio al fine di rendere l’intesa vincolante tramite l’adozione di una direttiva che a sua volta dovrebbe essere trasposta. L’accordo resterà in un ambito strettamente privatistico e la sua attuazione su scala nazionale rimarrà del tutto nelle mani delle parti sociali. Una prospettiva di notevole interesse, compatibile con il diritto comunitario che non esclude questo genere di accordi, al tempo stesso utilmente sperimentabile in Italia anche per realizzare eventualmente un coordinamento “soft” di un modello contrattuale ad impianto federalista.
In ogni caso il Governo ritiene che già sul piano dell’intervento regolatorio pubblico sarà necessario sperimentare queste tecniche innovative. Ad esempio una rivisitazione della normativa sulla salute e sicurezza del lavoratore dovrà comportare il passaggio dal management by regulation al management by objectives. Superare l’inderogabilità della norma giuridica dunque non basta: occorre dotare l’ordinamento del lavoro di una nuova gamma di strumenti regolatori che già sono in uso in Paesi con cui l’Italia si confronta nella competizione globale. Il Governo considererà l’opportunità di ricorrere a questi strumenti regolatori di tipo innovativo ed auspica in quest’ambito di ricevere commenti e proposte dagli attori istituzionali e sociali
I.3.4. Norme semplici e certe
Il Governo ritiene che l’ordinamento giuridico del lavoro italiano sia, al pari di altre branche del diritto dell’economia, estremamente complesso, frutto di interventi normativi stratificatisi nel tempo con un andamento alluvionale che lo rendono, per molti versi, inadeguato a disciplinare fenomeni sociali nuovi e in continuo mutamento. I rapporti fra datori e prestatori di lavoro dovrebbero essere governati da un corpus normativo assai più semplificato, effettivamente utilizzabile dai diretti interessati senza ulteriore aggravio di costi per gli operatori economici di minori dimensioni.
Modernizzare il sistema regolatorio dei rapporti di lavoro significa anche darsi l’obiettivo di una riorganizzazione e di un riordino delle norme vigenti, ricorrendo anche allo strumento dei testi unici. Tale metodologia potrebbe risultare di grande utilità per le imprese ed a tal fine il Governo ha immediatamente disposto affinché venga opportunamente ordinata e semplificata la normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Regole più semplici e chiare contribuirebbero ad agevolare l’opera di regolarizzazione delle condizioni di lavoro con un effetto assai benefico sul piano della correttezza della concorrenza fra imprese.
Il Governo ritiene che, una volta realizzata l’opera riformatrice delineata nel presente Libro Bianco, così come risulterà arricchita ed integrata dai soggetti istituzionali e sociali cui è rivolto, sarà comunque necessario coordinare le nuove disposizioni con la normativa preesistente all’interno di un Testo unico sul lavoro. Tale intervento potrà anche essere anticipato nel corso della presente legislatura non appena saranno operative alcune significative riforme, secondo uno schema di codificazione aperto e flessibile, che consenta un continuo aggiornamento del Testo unico stesso. Sarà questa l’occasione per un opportuno raccordo con le legislazioni regionali che nel frattempo si saranno formate. Il Governo auspica che sul punto si possano registrare utili commenti e proposte dai soggetti istituzionali e dalle parti sociali.
I.3.5. “Statuto dei Lavori”
Il Governo considera necessario alla luce di quanto sopra esposto procedere ad un’opera di complessiva modernizzazione dell’impianto dell’ordinamento del lavoro in Italia nell’ ambito di uno ‘Statuto dei lavori’ che riprende alcune idee progettuali già circolati nel corso della precedente legislatura, spunti che il Governo intende valorizzare pienamente pervenendo ad un organico progetto riformatore sul quale si chiede il concorso dei soggetti istituzionali e sociali.
Nell’accingersi a progettare un disegno riformatore di ampio respiro, occorre tener conto dei vincoli di appartenenza dell’Italia a organismi sopranazionali, unitamente alle logiche della globalizzazione e dell’internazionalizzazione dei mercati, ciò che impone di prendere le mosse da due documenti di particolare rilievo a livello internazionale: la Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del lavoro sui principi e diritti fondamentali sul lavoro approvata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nel giugno del 1998, nonché la Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea proclamata a Nizza lo scorso 7 dicembre. La Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sancisce quattro diritti fondamentali (la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva; l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio; l’effettiva abolizione del lavoro minorile; l’eliminazione di ogni discriminazione sul lavoro e nell’accesso all’impiego. La “Carta” dell’Unione Europea, accanto a questi diritti fondamentali, ne indica in modo dettagliato una serie ulteriore, tra cui il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata; alla informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa; di accedere a un servizio di collocamento gratuito; alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato; a un equo compenso; a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose; di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali, alla protezione dei dati personali. A prescindere dal valore giuridico di questi documenti, in essi sono indubbiamente contenuti alcuni principi profondamente radicati nella tradizione culturale europea e, segnatamente, italiana. A ben vedere, si tratta di principi e diritti formalmente sanciti dalla Carta Costituzionale del 1948.
A seguito dei profondi mutamenti intercorsi nell’organizzazione dei rapporti e dei mercati del lavoro, il Governo ritiene che sia ormai superato il tradizionale approccio regolatorio, che contrappone il lavoro dipendente al lavoro autonomo, il lavoro nella grande impresa al lavoro in quella minore, il lavoro tutelato al lavoro non tutelato. E’ vero piuttosto che alcuni diritti fondamentali devono trovare applicazione, al di là della loro qualificazione giuridica, a tutte le forme di lavoro rese a favore di terzi: si pensi al diritto alla tutela delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, alla tutela della libertà e della dignità del prestatore di lavoro, all’abolizione del lavoro minorile, all’eliminazione di ogni forma di discriminazione nell’accesso al lavoro, al diritto a un compenso equo, al diritto alla protezione dei dati sensibili, al diritto di libertà sindacale. E’ questo zoccolo duro e inderogabile di diritti fondamentali che deve costituire la base di un moderno “Statuto dei lavori”.
Occorre precisare che il riconoscimento di questi diritti fondamentali a tutti i lavoratori che svolgano prestazioni a favore di terzi (datori di lavoro, imprenditori, enti pubblici, committenti, etc.) non risponde solo ed esclusivamente a istanze di tutela della posizione contrattuale e della persona del lavoratore. E’ vero anzi che il riconoscimento di standard minimali di tutela a beneficio di tutti i lavoratori rappresenta — oggi più che nel passato — anche una garanzia dei regimi di concorrenza tra i soggetti economici, arginando forme di competizione basate su fenomeni di dumping sociale (dal lavoro nero tout court a forme di sfruttamento del lavoro minorile, etc.).
Partendo dunque dalle regole fondamentali, applicabili a tutti i rapporti di lavoro a favore di terzi, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto, è poi possibile immaginare, per ulteriori istituti del diritto del lavoro, campi di applicazione sempre più circoscritti e delimitati, operando un’opportuna graduazione e diversificazione delle tutele in ragione delle materie di volta in volta considerate e non (come nel vecchio ordinamento) a seconda delle tipologie contrattuali di volta in volta considerate. Dunque non si tratta di sommare al nucleo esistente delle tutele previste per il lavoro dipendente un nuovo corpo normativo a tutela dei nuovi lavori (ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative). Non può certo essere condiviso l’approccio – proposto senza successo nel corso della precedente legislatura – di estendere rigidamente l’area delle tutele senza prevedere alcuna forma di rimodulazione all’interno del lavoro dipendente.
Individuato, dunque, un nucleo essenziale di norme e di principi inderogabili (soprattutto di specificazione del dettato costituzionale), comuni a tutti i rapporti negoziali aventi ad oggetto esecuzione di attività lavorativa in qualunque forma prestata, occorrerà procedere a una rimodulazione delle tutele caratteristiche del lavoro dipendente. Al di sopra di questo nucleo minimo di norme inderogabili, sembra opportuno lasciare ampio spazio all’autonomia collettiva e individuale, ipotizzando una gamma di diritti inderogabili relativi, disponibili a livello collettivo o anche individuale (a seconda del tipo di diritto in questione).
A ciò dovrà aggiungersi un corrispondente riassetto delle prestazioni previdenziali. L’avvicinamento dei regimi previdenziali contribuirebbe peraltro a sdrammatizzare il problema qualificatorio delle singole fattispecie. Del resto il processo di riallineamento o rimodulazione delle tutele caratteristiche del lavoro subordinato riguarderà anche il profilo della stabilità dell’occupazione. A tal proposito si potrebbero ipotizzare per alcune categorie di lavoratori e/o per determinate tipologie contrattuali, meccanismi di tipo risarcitorio ovvero garanzie crescenti a seconda dell’anzianità di servizio continuativo del lavoratore. Si realizzerà in altri termini un sistema di tutela a geometria variabile, raffigurabile in una serie di centri concentrici di diversa ampiezza secondo le materie trattate, tali da comprendere tipologie più o meno ampie di rapporti.
Sul piano della ridefinizione dei criteri di imputazione delle tutele del lavoro si potrebbe peraltro andare anche oltre la semplice predisposizione di un nucleo di disciplina comune a tutti i tipi di lavoro, rinunciando definitivamente ad una definizione generale e astratta di lavoro subordinato, indicando invece, di volta in volta, il campo di applicazione di ogni intervento normativo. Una soluzione, in questa prospettiva, potrebbe essere quella della creazione di Testi Unici, che, oltre a ridefinire il campo di applicazione — soggettivo e oggettivo — di ogni tutela (equo compenso, licenziamenti, sospensione del rapporto di lavoro, diritto di sciopero, sanzioni disciplinari, etc.), potrebbero anche concorrere alla semplificazione e razionalizzazione della normativa esistente.
In sintesi, il Governo ritiene che sia indispensabile una complessiva rivisitazione del nostro ordinamento giuridico del lavoro, innanzitutto estendendo livelli minimi di tutela a tutte le forme in cui si estrinseca l’attività lavorativa. Dunque partendo dalle regole fondamentali, applicabili a tutte le forme di attività lavorativa rese a favore di terzi, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto, sarà poi possibile ammettere, per ulteriori istituti del diritto del lavoro, campi di applicazione via via più circoscritti, un sistema di cerchi concentrici, con una tutela che si intensificherà a favore di un novero sempre più ristretto di soggetti. Per consegnare alle imprese un nuovo sistema di gestione dei rapporti di lavoro, semplice ed agile, sarebbe utile infine sperimentare una procedura di certificazione, cioè di validazione anticipata della volontà delle parti interessate all’utilizzazione di una certa tipologia contrattuale. La funzione certificatoria, utile a prevenire controversie giudiziali sul piano qualificatorio, potrebbe essere esercitata da strutture pubbliche (in sede amministrativa) od anche sindacali (gli enti bilaterali, ad esempio).
Il Governo auspica che su questa proposta possano essere raccolte osservazioni ed integrazioni, nella convinzione che una riforma di tal genere necessiti del concorso progettuale di tutti gli attori, non esclusa la comunità scientifica nell’ambito della quale esse sono state a lungo dibattute.
I.3.6. Responsabilità sociale delle imprese
Il Governo condivide il recente Libro Verde della Commissione europea Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility (18 luglio 2001, COM(2001) 366 final), auspicando che gli operatori economici italiani possano sviluppare una cultura orientata verso la “responsabilità sociale”. Con questo concetto si allude, come noto, non soltanto al semplice adempimento degli obblighi di carattere legale imposti da precetti legislativi od anche di origine convenzionale, quanto anche all’impegno di andare oltre il semplice adempimento investendo sempre più nelle risorse umane. Andare oltre le prescrizioni legali minime in campo sociale può, del resto, avere un impatto rilevante sulla produttività delle imprese, anche se non può certo considerarsi una metodologia in alcun modo sostitutiva della regolazione dei diritti sociali fondamentali.
La “responsabilità sociale”, intesa come investimento in capitale umano, può rappresentare una scelta strategica vincente per l’impresa, nel senso di migliorare il rendimento dei dipendenti, generando maggiori profitti, ed allo stesso tempo destando una crescente attenzione nei consumatori e negli investitori. Del resto in alcune regioni italiane la situazione del mercato del lavoro impone all’operatore economico un comportamento assai attento ai profili sociali, finalizzato ad attrarre e trattenere il capitale umano di migliore qualità. A questo fine non è certamente sufficiente attenersi agli obblighi di legge od a quanto previsto dal contratto collettivo: è necessario andare ben oltre. A ragione dunque la Commissione europea raccomanda lo sviluppo di una cultura della “responsabilità sociale” che valorizzi l’empowerment dei collaboratori, realizzando condizioni di formazione permanente, sviluppo di carriera, meccanismi di partecipazione ai profitti, puntando in definitiva alla realizzazione di risorse umane di qualità.
Il Governo sollecita tutti gli attori a prestare attenzione al tema della “responsabilità sociale” delle imprese, sperimentandolo anche a mezzo di “codici di condotta” di tipo volontario che consentano ai lavoratori ed ai loro rappresentanti di valutare la politica delle risorse umane delle organizzazioni, instaurando un fruttoso dialogo con il management. Occorre in definitiva sperimentare nuove tecniche, comprensive anche di un diverso funzionamento dei meccanismi delle assicurazioni sociali, che sia ispirato alla logica del management by objectives. Ciò pur nella consapevolezza della difficoltà di definire standard di comportamento validi universalmente, compresa quella del social auditing, del ‘marchio sociale’ ed altre analoghe. La prospettiva suggerita dalla Commissione, autorevolmente confermata dal Consiglio europeo di Goteborg (giugno 2001), appare in questo senso condivisibile: transitare da una prospettiva meramente regolatoria ad un developmental approach costituisce la garanzia per una visione non solo giuridico-istituzionale, ma anche dinamica del funzionamento dei rapporti di lavoro e dei mercati in cui sono inseriti. Le tutele dell’ambiente, dell’igiene e sicurezza nel lavoro, dei diritti fondamentali nella filiera produttiva globale possono rappresentare gli ambiti in cui promuovere lo sviluppo di queste iniziative volontarie.
I.3.7. Giustizia del lavoro
In un quadro regolatorio moderno dei rapporti di lavoro anche la prevenzione e la composizione delle controversie individuali di lavoro deve ispirarsi a criteri di equità ed efficienza, ciò che senza dubbio non risponde alla situazione attuale. La crisi della giustizia del lavoro è, infatti, tale, sia per i tempi con cui vengono celebrati i processi, sia per la qualità professionale con cui sono rese le pronunce, da risolversi in un diniego della medesima, con un danno complessivo per entrambe le parti titolari del rapporto di lavoro. E’ necessario anche in proposito guardare alle esperienze straniere più consolidate (dai tribunali industriali britannici ai probiviri francesi) per trarne motivo di riflessione e di approfondimento.
La situazione, specialmente in alcune sedi giudiziarie, è davvero grave e deve essere affrontata con assoluta urgenza. A tal proposito il Governo considera assai interessante la proposta, da più parti avanzata, di sperimentare interventi di collegi arbitrali che siano in grado di dirimere la controversia in tempi sufficientemente rapidi.
Tutte le controversie di lavoro potrebbero essere amministrate con maggiore equità ed efficienza per mezzo di collegi arbitrali. Con particolare riferimento al regime estintivo del rapporto di lavoro indeterminato, si potrebbe anche considerare a riguardo la possibilità di conferire allo stesso collegio arbitrale di optare per la reintegrazione o per il risarcimento, avuto riguardo alle ragioni stesse del licenziamento ingiustificato, al comportamento delle parti in causa, alle caratteristiche del mercato del lavoro locale.
Fra l’altro alcune recenti intese fra le parti sociali hanno certamente rafforzato la soluzione arbitrale in alternativa a quella giudiziale, pur nei limiti e nel rispetto dei principi costituzionali che vietano l’obbligatorietà di tale mezzo di soluzione delle controversie (v. recentemente Cass. SU 527/2000). Il Governo a riguardo considera con perplessità le conclusioni, non unanimi, cui è approdata sul punto la “Commissione per lo studio e la revisione della normativa processuale del lavoro” che ha operato nel corso della passata legislatura per incarico del Ministero della Giustizia e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Si legge, infatti, nella Relazione che non si è raggiunto consenso sull’abrogazione –pure sostenuta da numerosi commissari- del divieto di compromettibilità in arbitri delle controversie ex art. 409 cod.proc.civ. e su clausole compromissorie, trasfuse nel contratto collettivo e richiamate nel contratto individuale, che consentano la devoluzione in arbitri anche quando abbiano ad oggetto diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o da contratti collettivi, nonché sull’impugnabilità, in un unico grado davanti alla Corte d’Appello, e solo per vizi procedimentali. Insufficiente a rilanciare l’istituto arbitrale nelle controversie di lavoro sarebbe poi la soluzione che vincola l’arbitro al rispetto della legge e dei contratti collettivi –impedendo così giudizi basati sull’equità- e considera impugnabile il lodo, per qualunque vizio, innanzi alla Corte di Appello. Occorre approfondire comunque il confronto su questa prospettiva, nella convinzione che in ogni caso l’ immediata esecutività del lodo nonostante l’impugnazione proposta (principio accolto anche nelle stesse intese fra le parti sociali) potrebbe incentivare considerevolmente questo istituto processuale.
Pure nel rispetto dei limiti di natura costituzionale che impediscono di dichiarare il lodo non impugnabile, l’istituto arbitrale sarebbe assai incentivato nel ricorso volontario delle parti se la decisione venisse resa su base equitativa –unica garanzia per tempi certi- e l’impugnabilità potesse essere proposta solo per vizi di procedura. Il Governo auspica che su questo punto si apra un confronto capace di produrre una proposta capace di modernizzare la gestione della giustizia del lavoro.
II. Obiettivi e politiche
II.1. Occupabilità (more jobs…)
II.1.1. Obiettivi quantitativi
Nel disegnare i diversi singoli interventi di politica del lavoro e più in generale di politica economica e finanziaria, è intenzione del Governo fare costante riferimento ad un obiettivo complessivo di crescita occupazionale –più precisamente di crescita del tasso d’occupazione- verso i livelli posti in sede europea. Intendimento del Governo è di procedere al confronto con le parti sociali e con gli altri attori istituzionali interessati avendo sempre questo obiettivo quantitativo di crescita come misura del proprio operare.
Rispetto ai target europei – 70% e 60 % rispettivamente per il tasso di occupazione totale e femminile nel complesso delle classi d’età tra 15 e 64 anni, 50% per quello dei 55-64enni – il divario che ancora caratterizza il nostro paese è particolarmente ampio. Avendo a riferimento il tasso di occupazione complessivo, l’aumento necessario per eliminarlo (nell’arco di un decennio) sarebbe pari all’incirca al triplo di quanto ottenuto nel quinquennio 1995-2000 e richiederebbe di replicare quanto, in ambito europeo, ottenuto nello stesso periodo solo da Olanda o Irlanda (facendo quindi meglio di Spagna, Finlandia o Portogallo), situazioni in cui la crescita occupazionale è stata innalzata da fattori peculiari, quali il forte sviluppo del part time ed il pieno dispiegarsi d’un processo di catching-up.
Nel delineare lo scenario macroeconomico della legislatura da poco avviata, il DPEF del luglio 2001 ha perciò fissato, come soglia al 2006, impegnativa ma prudente, un livello del tasso d’occupazione complessivo del 58.5% ( cinque punti in più rispetto al 2000). Il raggiungimento di tale obiettivo, che richiede condizioni macroeconomiche favorevoli, già garantirebbe un balzo in avanti rispetto al quinquennio 1995-2000, soprattutto alla luce del fatto che, al contrario di quanto avvenuto in quel quinquennio, i fattori demografici non giocheranno a favore della crescita dell’occupazione ed i livelli occupazionali ormai raggiunti in taluni segmenti di mercato renderanno sempre più pressante il vincolo alla crescita che potrà scaturire dalla carenza di manodopera in talune parti del mercato[21]. La soglia ora indicata è anche l’obiettivo che il Governo ha indicato, in sede Europea, come contributo italiano al raggiungimento dei target che l’Unione ha fissato, al 2005 ed al 2010, per l’insieme dei Paesi Membri.
Il raggiungimento di quella soglia non sarebbe traguardo da poco, anche considerando la necessità che le politiche occupazionali qui descritte si dispieghino in un contesto macroeconomico positivo –un contesto su cui potrebbero incidere in senso sfavorevole le vicende internazionali- e le difficoltà che la situazione dei conti pubblici ereditata dal passato creano agli interventi necessari di riduzione del carico contributivo e di attuazione di adeguate politiche attive e passive del lavoro. Tuttavia, il Governo sottolinea come esso intenda operare affinché l’Italia possa progressivamente accostarsi ai livelli e ai traguardi esistenti per l’UE nel suo insieme.
Le aree dove maggiore è il gap con quei traguardi e dove minori sono stati i progressi pur registrati nel quinquennio 1995-2000 – in particolare il lavoro dei più anziani (calato nel recente passato) e le regioni del Mezzogiorno (dove più flebili e meno consolidati sono stati i segnali di miglioramento nel recente passato) - sono, al tempo stesso, quelle più critiche al fine di raggiungere lo stesso obiettivo minimo prima detto e quelle dove maggiori sono le opportunità di superamento di quell’obiettivo.
II.1.2. Politiche attive
Le caratteristiche del nostro mercato del lavoro mostrano che abbiamo molta strada da percorrere prima di raggiungere gli obiettivi che, con riferimento ai tassi di occupazione, la Comunità ha indicato agli Stati membri. La disoccupazione giovanile, la disoccupazione di lunga durata , la concentrazione della disoccupazione nel Mezzogiorno, il modesto tasso di partecipazione delle donne e degli anziani, sono tutti fattori di debolezza strutturale della nostra economia , che ne limitano il grado di competitività all’interno della Comunità. L’elevata disoccupazione e il basso tasso di occupazione trovano origini lontane nel tempo e devono essere curati con interventi di carattere strutturale. Senza questi interventi, vi è il pericolo che la politica di sviluppo indicata dal Governo vada incontro a strozzature che ne possono limitare l’efficacia e le potenzialità.
L’offerta di lavoro da mobilitare è localizzata soprattutto nelle regioni meridionali, ma anche in quelle settentrionali si riscontrano segmenti consistenti di offerta potenziale che possono essere meglio sfruttati. Nei confronti di questa offerta, in parte palese, in parte nascosta (e in parte impiegata nel lavoro sommerso) occorre agire innanzitutto sui fattori che rendono più conveniente il loro impiego da parte delle imprese del segmento ufficiale del mercato del lavoro. In termini economici occorre sviluppare la domanda di lavoro attraverso interventi sul costo del lavoro per unità di prodotto e, più in particolare, sulle singole componenti in cui esso si articola: retribuzioni, cuneo fiscale e produttività.
Gli strumenti vanno individuati ed attivati in modi diversi, a seconda del segmento dell’offerta su cui si vuole intervenire. In diverse parti del Paese si è raggiunta praticamente la piena occupazione, nel senso che la disoccupazione è scesa a livelli fisiologici, eppure non si sono raggiunti ancora livelli dei tassi di occupazione paragonabili a quelli dei nostri partners europei. Se ne deduce che per raggiungere quell’obiettivo di occupazione occorre far leva sugli strumenti che possano incentivare una maggiore offerta di lavoro, in particolare quella delle donne e degli anziani.
Le componenti strutturali della nostra disoccupazione, quella giovanile, quella concentrata nel Mezzogiorno, quella di lunga durata (e si osservi che esiste una forte sovrapposizione fra queste diverse tipologie di disoccupazione) vanno affrontate con un opportuno “mix” di tutti gli strumenti di politica del lavoro , anche dello strumento che sta alla base del funzionamento stesso del mercato del lavoro e cioè i differenziali retributivi . E ciò vale soprattutto quando lo strumento degli incentivi fiscali non può essere utilizzato nei modi e nelle misure voluti. Questo è il caso della disoccupazione meridionale.
Il Governo ritiene che sia necessario, anche a seguito delle indicazioni che continuano a provenire dalla Commissione Europea nell’ambito della Strategia Europea sull’Occupazione, un nuovo assetto della regolazione e del sistema di incentivi e ammortizzatori che realizzi un bilanciamento tra flessibilità e sicurezza, avendo come obiettivo ultimo più occupazione e meno precarizzazione. Pertanto, esso invita le parti sociali affinché si ponga attivamente in costruzione un sistema di politiche di lavoro nel quale stabilità e sicurezza siano riferite non più al singolo posto di lavoro bensì all’occupazione e al mercato del lavoro.
II.1.3. Servizi pubblici all’impiego
Le politiche attive si basano anzitutto sul miglioramento del sistema di diffusione delle informazioni nel mercato del lavoro, in particolare quelle sui posti vacanti, sui fabbisogni di personale, sulle possibilità di “training” rivolte ai giovani e ai lavoratori e, infine, sulle caratteristiche dei lavoratori disoccupati. Su questo terreno il nostro paese è strutturalmente arretrato e ciò pesa negativamente sul funzionamento di tutto il mercato del lavoro. L’assorbimento di una quota della disoccupazione strutturale e l’innalzamento del tasso di occupazione dipenderanno in misura rilevante dal successo che avranno le politiche di diffusione e di scambio di queste informazioni.
Pertanto, il Governo auspica che, pure nel rispetto delle prerogative di ogni attore, venga impressa una decisa accelerazione alle misure che possano favorire un efficiente ed equo incontro tra domanda e offerta.
Il Governo ritiene che l’attuale ordinamento giuridico del lavoro si limiti a realizzare la protezione del lavoratore in quanto titolare di una posizione lavorativa, garantendo agli insiders una posizione di privilegio a scapito degli outsiders, sostanzialmente abbandonati a se stessi da strutture di collocamento pubblico del tutto inadeguate. Se occorre da un lato rimodulare convenientemente la protezione accordata al lavoratore occupato, dall’altro è necessario assicurare una più alta tutela sul mercato. Sul piano del rapporto di lavoro si tratta quindi di stimolare l’adattabilità dei dipendenti (vale a dire flessibilità e formazione); su quello del mercato le autorità comunitarie richiedono agli Stati membri di realizzare un sistema pubblico di servizi all’impiego che, integrando e lasciando competere al tempo stesso operatori pubblici e privati, garantisca l’occupabilità. E’ del tutto evidente che l’ordinamento italiano contrasta apertamente con tali indicazioni comunitarie: alla iper-tutela degli occupati si contrappone, infatti, la sotto-tutela dei disoccupati.
Come già anticipato, l’Italia non si è adeguata negli ultimi anni alla richiesta fondamentale rivoltale dalle autorità comunitarie nell’ambito della Strategia Europea per l’Occupazione, cioè di riorientare in forma preventiva il proprio sistema di servizi pubblici all’impiego. Nel Paese, a livello di Governo ma anche di Regioni e di enti locali, c’è stata una forte sottovalutazione di questi impegni comunitari finalizzati a migliorare la capacità di inserimento professionale del nostro sistema pubblico di collocamento
Il Governo intende raccogliere le Raccomandazioni rivolte dall’Unione Europea, proseguendo con determinazione nella modernizzazione dei servizi pubblici per l’impiego. A questo proposito sarà necessario un raccordo più stretto con le competenze e l’attività delle Regioni e delle Province, anche al fine di valutare il grado di efficienza raggiunto dalle strutture decentrate del collocamento pubblico. Il d. lgs. 181 rimane certamente la cornice normativa per l’attuazione concreta di politiche preventive, attribuendo ai servizi per l’impiego, tra gli indirizzi generali, il compito di effettuare una proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo, di formazione e riqualificazione a disoccupati e inoccupati di lunga durata, non oltre dodici mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione (sei mesi per coloro che godono di trattamenti previdenziali). Lo stesso decreto prevede inoltre l’offerta da parte dei servizi pubblici per l’impiego di un colloquio di orientamento entro sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione a tutti i giovani disoccupati. Il Governo dunque si impegna in questa prospettiva a riorientare, di intesa con le Regioni e le Province, con maggiore incisività i servizi per l’impiego verso una logica di prevenzione, al fine di ridurre i flussi e le permanenze nella disoccupazione.
In questo quadro, uno sforzo di maggiore attenzione verrà rivolto all’attuazione degli interventi di prevenzione della disoccupazione di lunga durata dei lavoratori anziani e di prolungamento della loro vita attiva. Tali misure riguarderanno il sistema previdenziale, la riduzione nel livello dei sussidi e l’incentivazione, sia sul fronte della domanda sia su quello dell’offerta di lavoro, della permanenza dei lavoratori anziani nella vita lavorativa. Ugualmente ai servizi pubblici all’impiego dovrà essere demandata la funzione di agire in termini di controllo nell’erogazione dei sussidi di disoccupazione.
Il Governo ritiene, pertanto, urgente, una riforma organica delle regole sul mercato del lavoro, nel senso della massima semplificazione delle procedure di collocamento, del più efficace potenziamento delle azioni di prevenzione e della massima efficacia dei servizi, attraverso un modello che contempli la cooperazione e la competizione tra strutture pubbliche, convenzionate e private. Pertanto, vanno individuate e sistematizzate le attività riconducibili ad una residua funzione pubblica (anagrafe, scheda professionale, controllo dello stato di disoccupazione involontaria e della sua durata, azioni di sistema) da assicurare mediante i servizi pubblici all’impiego e strutture convenzionate (pubbliche e private); mentre vanno affidate al libero mercato le attività di servizio, in un regime di competizione e concorrenza tra i servizi pubblici e gli operatori privati autorizzati.
Il Governo valuta positivamente l’esperienza in atto per iniziativa del Comune di Milano dove è stata realizzata un’intesa fra le parti sociali e con la collaborazione della Regione Lombardia e la Provincia di Milano si è dato luogo ad un servizio pubblico finalizzato all’integrazione occupazionale e sociale di categorie a rischio di esclusione (extracomunitari, over 40 espulsi da processi produttivi, ecc.). Tale esperienza testimonia eloquentemente il possibile ruolo che anche gli enti locali possono svolgere, nella collaborazione con le parti sociali, avendo riguardo con maggiore prossimità alle caratteristiche di ogni singolo mercato locale del lavoro.
Il Governo ritiene assai urgente un intervento che, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province, consenta in tempi rapidi un’accelerazione nel processo di riorganizzazione dei servizi pubblici all’impiego, in ottemperanza alle raccomandazioni ricevute dall’Unione Europea.
Occorre intervenire su più fronti. Un intervento prioritario è investire risorse nel servizio stesso, soprattutto in termini di maggiori e migliori competenze e professionalità degli operatori coinvolti. Fare efficacemente intermediazione nel mercato del lavoro significa possedere capacità professionali di alto livello; occorre rompere con la tradizione e la cultura dei timbri e delle pratiche burocratiche. Le competenze necessarie sono di carattere specifico, quasi imprenditoriali e implicano una profonda ed aggiornata conoscenza del mondo e del mercato del lavoro. Al Governo spetta un insostituibile ruolo di monitoraggio, di promozione, di “modellizzazione” degli interventi, di diffusione delle pratiche migliori (gli esempi non mancano) e di indirizzo generale.
La seconda direzione di intervento concerne un regime di competizione e, al tempo stesso, di cooperazione fra attori privati e servizio pubblico. La cooperazione non deve avvenire a discapito del pieno dispiegarsi dei meccanismi concorrenziali tra i diversi operatori, ma sarebbe improponibile per l’operatore pubblico fare a meno della cooperazione con i privati, immaginando di poter gestire efficacemente in-house l’intero spettro di servizi. Il ricorso a meccanismi di mercato in una logica di outsourcing di servizi andrebbe perciò opportunamente valorizzato anche per quanto concerne la fornitura di servizi il cui disegno generale rimanga nelle mani dell’operatore pubblico.
La cooperazione tra pubblico e privato è comunque essenziale soprattutto per quanto riguarda la produzione e l’utilizzo delle informazioni. Tutti i segmenti del mercato del lavoro vanno adeguatamente serviti, ma sarebbe pericoloso e controproducente che il servizio pubblico continuasse a presentare l’immagine di un servizio inefficiente e diretto unicamente alle frange marginali della forza di lavoro. Certamente il target principale deve essere quello di aiutare i più bisognosi, ma si ricordi quanto detto sopra e cioè che l’attivazione dell’offerta di lavoro marginale e potenziale rappresenta nel nostro Paese un obiettivo non solo di equità, ma anche di efficienza di tutto il mercato del lavoro. Questa offerta di lavoro deve essere resa sì “adattabile” e “competitiva” sul mercato del lavoro, ma deve essere resa anche “occupabile” in modo dignitoso e il problema della occupabilità non può essere affrontato in modo tale da accentuare le segmentazioni esistenti nel mercato del lavoro. Per offrire “buoni” posti di lavoro anche a questi segmenti di offerta occorre dare a questi un accesso adeguato alle informazioni che vengono raccolte sulle opportunità di impiego. Il mondo della produzione e le strutture private che sorgeranno per garantire una maggiore e migliore diffusione delle informazioni e per facilitare l’incontro domanda ed offerta, dovranno aiutare il servizio pubblico ad abbandonare l’immagine di un servizio inefficiente, tutt’al più capace di assicurare qualche forma di assistenza diretta di tipo passivo e di svolgere talvolta il ruolo di datore di lavoro di ultima istanza.
Va accelerata la realizzazione di un’infrastruttura informatica integrata, pubblico-privata, per l’incontro domanda-offerta, riformando l’attuale SIL, che dovrà connotarsi come un sistema policentrico, in cui il ruolo del livello centrale sia ricondotto alle funzioni di supporto informativo alle politiche del governo, alla definizione degli standard ed alla gestione dell’interoperabilità tra i vari sistemi regionali e locali. Vanno progettati e supportati interventi specifici per l’implementazione territoriale dell’infrastruttura, attraverso azioni di sistema pilotate con un’agenzia strumentale, d’intesa con Regioni e province. Tali azioni dovrebbero concentrarsi sulla diffusione degli standard, sull’evoluzione delle soluzioni applicative in senso web-oriented e loro messa a disposizione sia dei servizi pubblici (compresi gli istituti scolastici) sia degli operatori privati, sulla formazione degli operatori pubblici alla loro utilizzazione, sullo sviluppo del front-office per una migliore fruizione dei servizi da parte dei cittadini e delle imprese. Al tempo stesso, andrà garantito il coordinamento operativo, anche a fini di vigilanza oltre che di monitoraggio statistico dei fenomeni e delle politiche, tra basi operative degli Enti previdenziali e SIL
Come regolare questo mercato dell’informazione non sarà facile: occorrerà garantire un giusto “mix” fra pubblico e privato, fra comportamenti concorrenziali e comportamenti collaborativi. Saranno le Regioni a trovare il giusto dosaggio dei due fattori e a rendere compatibili le diverse esigenze, entro regole fissate dal Governo e dal Parlamento.
II.1.4. Operatori privati per il lavoro
Il Governo ritiene che occorra agire affinché si fondi stabilmente un sistema maggiormente concorrenziale fra pubblico e privato, consentendo di gestire anche in forma imprenditoriale l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Appare urgente, a tale fine, innanzitutto superare il vincolo dell’“oggetto esclusivo” e consentire l’attività di operatori privati polifunzionali, variamente capitalizzati in relazione ai servizi autorizzati, opportunamente vigilati e regolati in modo da limitare in particolare gli obblighi informativi.
L’attuale normativa sulle agenzie private di collocamento, a causa degli eccessivi appesantimenti burocratici che la caratterizzano, è stata la causa principale dell’evidente insuccesso che finora ha contrassegnato il ruolo degli operatori privati, con l’eccezione delle società di lavoro temporaneo.
Il Governo considera allo stesso modo necessario rivedere pienamente la normativa introdotta per regolare il ruolo degli operatori privati impegnati nel lavoro temporaneo, nella ricerca e selezione del personale, nel supporto alla ricollocazione professionale e, più in generale, che si occupano a vario titolo della mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Il regime farraginoso e inutilmente complesso varato nella scorsa legislatura appare di impossibile gestione ed il Governo ritiene si debba pervenire ad un unico regime autorizzatorio per tutte le organizzazioni private impegnate nel servizio di collocamento nel mercato del lavoro. Una regolazione più semplice ed efficace consentirà, peraltro, un più deciso contrasto di tutte le forme di abusivismo. Ugualmente, il Governo auspica che venga impressa una decisa accelerazione alle misure che possano favorire la diffusione di operatori privati polifunzionali dedicati ad un efficiente ed equo incontro tra domanda e offerta.
II.1.5. Formazione e lavoro
Occorre un ripensamento generale sugli obiettivi che il nostro paese deve perseguire nel settore congiunto del lavoro e della formazione. Il traguardo di elevare sensibilmente il tasso di occupazione comporta una serie di condizioni da soddisfare.
Innanzitutto i giovani che, finiti i loro studi, si presentano sul mercato del lavoro, devono trovare un posto molto più velocemente di quanto non succeda oggi, con tempi di attesa lunghissimi, spesso superiori ad un anno. Appare necessario che Stato e Regioni fissino una serie di tappe da percorrere in vista di un obiettivo finale. Le tappe dovranno indicare una progressione nel numero di giovani che dovranno essere coinvolti in un processo di apprendimento integrato che possa facilitare ed accelerare il passaggio fra scuola e lavoro.
Il riordino dei contratti con finalità formative è stata una delle maggiori inadempienze riscontratesi durante il corso della passata legislatura. Si tratta di un adempimento al quale il Governo è chiamato dall’art. 16 della legge 196 del 1997, il quale prevede l’emanazione di norme regolamentari per disciplinare organicamente la materia in questione. Occorre porre mano senza ulteriori ritardi a questo adempimento, ed il Governo sollecita a tale proposito proposte e commenti di Regioni, enti locali e parti sociali.
Per i contratti a causa mista in senso proprio gioverebbe senz’altro una maggiore distinzione delle funzioni alle quali tali tipologie contrattuali possono assolvere. In questa ottica potrebbe prospettarsi una distinzione orientata da un lato a valorizzare il ruolo dell’apprendistato come strumento formativo per il mercato, mentre il cfl dovrebbe essere concepito come strumento per realizzare un inserimento mirato del lavoratore in azienda.
Un’impostazione del genere farebbe dell’apprendistato una tipologia contrattuale funzionale alla esigenze effettive del mercato del lavoro, logica che dovrebbe essere imposta anche dall’applicazione del principio innovativo introdotto dalla stessa legge 196 del 1997, consistente nella subordinazione del riconoscimento dei benefici contributivi alla partecipazione dell’ apprendista alle iniziative di formazione esterne all’ azienda.
Il cfl dovrebbe, invece, concorrere a realizzare un adeguamento della professionalità posseduta dal lavoratore alle concrete esigenze dell’impresa che lo assume. Un intervento riformatore potrebbe utilmente uniformare i benefici contributivi per tutti i settori, stabilendo una soglia di età unica ed estendendone la durata. Anche l’iter procedimentale di assunzione andrebbe snellito e velocizzato. Inoltre, potrebbe ipotizzarsi anche una revisione dei limiti di età ed un’individuazione dei target di popolazione da raggiungere in coerenza con le scelte comunitarie, rendendo tale istituto funzionale anche al reinserimento lavorativo e aggiungendo una rimodulazione degli incentivi che – per i lavoratori con anzianità superiore a quella consentita dalla normativa comunitaria – potrebbero consistere in una forma di rimborso dei costi sopportati per le attività formative.
Il Governo intende però anche verificare in che misura un sistema normativo meno rigido – per quanto attiene il lavoro a termine in genere e l’inserimento nel mondo del lavoro dei più giovani in particolare - possa consentire di liberare risorse finanziarie dall’incentivazione dei contratti a causa mista.
Occorre semplificare e chiarire il sistema attuale, confermando la validità delle “esperienze lavorative” (come i tirocini con finalità formative) che, per espressa previsione legislativa, non costituiscono un rapporto di lavoro, occasioni estremamente preziose per consolidare un collegamento fra scuole/università e mondo delle imprese. A tale proposito, il Governo considera assolutamente decisiva l’attuazione della riforma degli ordinamenti didattici universitari laddove essa prevede che gli studenti possano maturare crediti formativi attraverso lo svolgimento di tirocini presso aziende e pubbliche amministrazioni. E’ davvero auspicabile che le Università italiane compiano uno sforzo per assicurare a tutti gli studenti un’occasione di occupabilità, realizzando un’insostituibile funzione di facilitare la transizione dalla scuola al lavoro. Il Governo richiama anche l’attenzione delle Regioni, degli enti locali e delle parti sociali affinché su scala territoriale si sviluppi un’intensa collaborazione con gli Atenei per agevolare la nuova funzione di orientamento al lavoro.
Il Governo ritiene utile insistere nella sperimentazione del tirocinio d’impresa, cioè del meccanismo finalizzato a favorire il subentro del tirocinante nell’attività imprenditoriale. Al giovane dovrebbe essere corrisposto un sussidio simile a quello già previsto per le borse-lavoro, mentre all’imprenditore verrebbero riconosciute agevolazioni fiscali e previdenziali. Qualora il tirocinio si concluda con la cessione dell’impresa al tirocinante, potrebbe essere riconosciuta una sorta di prestito d’onore. Misure di questo genere devono essere promosse per incoraggiare una cultura dell’imprenditorialità, consentendo, nel contempo, ai titolari dell’impresa di programmare la cessione della propria attività.
Il Governo invita le parti sociali a riflettere in merito alla riforma dei contratti a causa mista in corso, soprattutto sullo strumento dell’apprendistato, approfondendo gli aspetti della quantità e della qualità della formazione esterna e interna ai luoghi di lavoro, anche in considerazione delle sollecitazioni che a tale riguardo provengono dall’Unione Europea.
Così come si finanzia con risorse pubbliche il processo di innovazione, altrettanto si deve fare con la formazione continua, sostenendone la domanda. I sistemi migliori più rapidi e a maggior diffusione, utilizzati per concedere agevolazioni in questo settore, sono quelli di tipo diretto. L’intermediazione delle parti sociali può essere utile, soprattutto nei processi di ristrutturazione, laddove la formazione può risultare necessaria per salvaguardare il patrimonio di risorse umane costruito nel tempo. Per il resto è opportuno rendere i finanziamenti più diretti e trasparenti. Molte lentezze di tipo semi-burocratico hanno impedito sinora un sufficiente volume di investimenti in formazione continua. Il credito di imposta può essere considerato nella maggioranza dei casi, come lo strumento migliore per garantire tempestività e trasparenza dell’aiuto pubblico.
Gli investimenti formativi effettivi decisi da imprese e lavoratori con strumenti automatici, nello stimolare la domanda di formazione, inducono un effettivo adeguamento dell’offerta formativa alla domanda medesima. In proposito si ricorda che già sono state previste, nella cosiddetta Tremonti-bis, norme volte a detassare gli investimenti in capitale umano. Ciò dovrebbe consentire una più attenta destinazione di risorse ad azioni che difficilmente trovano una chiara e puntuale applicazione da parte delle imprese. Oltre al credito di imposta per le imprese si possono ipotizzare “bonus“ ai lavoratori e alle famiglie, da utilizzare per “comprare” servizi di formazione presso le strutture private o convenzionate che danno maggiore fiducia agli utilizzatori del servizio. Forme di “quasi-mercato” devono essere individuate e su queste deve aprirsi un confronto costruttivo con le parti sociali. Il sostegno alla domanda delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie potrà stimolare la riqualificazione dell’offerta sulla base di impulsi competitivi. Nel caso dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro che difficilmente hanno le capacità di accedere autonomamente alle opportunità offerte, verranno previsti strumenti di supporto.
Il problema di un’adeguata informazione e della qualità dell’offerta formativa deve essere risolto, oltre con l’azione dal lato della domanda, anche con l’intervento pubblico, perché lasciato a se stesso il mercato non riesce a dare, in questo campo, i risultati migliori. E’ in questo contesto che si richiede un intervento pubblico per dare indirizzi e garantire standard minimi della formazione. Gli indirizzi derivano da una migliore conoscenza di quali sono i fabbisogni professionali espressi dal mondo della produzione. Occorre uscire dalla logica, spesso seguita in passato, secondo la quale i contenuti della formazione venivano fissati da chi gestiva l’offerta senza molto interesse per le necessità espresse dalla domanda, vale a dire per i fabbisogni professionali espressi dai processi produttivi. Non vi è dubbio che i contenuti della formazione professionale devono rispondere alle esigenze del mondo produttivo e alla necessità di produrre quelle competenze che le imprese maggiormente richiedono, senza perdere di vista i valori formativi di carattere generale, le competenze di base che, nella società dell’informazione, ogni lavoratore deve possedere e quelle conoscenze che possono anticipare crescita e sviluppo. Anche questo è un servizio di natura pubblica ed occorre che anche le parti sociali, attraverso i loro enti bilaterali, diano il loro contributo. Ma l’autorità pubblica, le Regioni, deve comunque garantire che queste informazioni sui fabbisogni professionali vengano accuratamente raccolte, perché esse sono un ingrediente necessario per fare correttamente una programmazione delle attività formative. Anche in questo caso, il contributo delle parti sociali, indispensabile per creare consenso sugli indirizzi da dare alla formazione professionale, deve costituire un elemento di stimolo per i tempi di implementazione di questo strumento strategico e non un improprio condizionamento in favore delle strutture dell’offerta formativa. Il Governo invita le parti sociali ad una comune riflessione critica sull’efficacia delle attività finanziate dal fondo alimentato sulla base dello 0,30% del monte salari aziendale.
Gli standard minimi di qualità sono un altro importante settore di intervento pubblico. Anche in questo caso le idee e le discussioni non sono mancate, si è prodotta legislazione al riguardo, ma si è fatto in concreto molto poco. Gli standard minimi devono riguardare da un lato la “qualità” dei produttori di formazione, i quali ricevono risorse pubbliche e di queste devono rendere conto. Questo problema riguarda il delicato processo di “accreditamento” delle strutture: queste devono garantire standard minimi di efficienza. L’altro aspetto riguarda la qualità del prodotto. Questo implica innanzitutto che il sistema delle qualifiche, dei titoli, dei crediti formativi vada regolato: i contenuti della formazione devono rispettare certi standard minimi per essere riconosciuti e soprattutto per essere “apprezzati” da chi li deve utilizzare. In secondo luogo va ripensato il problema sul se e sul come legare i finanziamenti pubblici alla bontà dei risultati finali raggiunti. I finanziamenti pubblici, infatti, devono incoraggiare l’efficienza e l’efficacia degli interventi di formazione.
II.1.6. Enti strumentali
Le politiche attive sono assegnate alle Regioni, ma al Governo (e alla Conferenza unificata) compete un ruolo importante di raccordo. I mercati del lavoro sono tendenzialmente locali, ma occorre facilitare al massimo la mobilità tra i mercati locali. Questo è il motivo per cui il governo centrale deve svolgere un ruolo di raccordo degli interventi regionali anche su questi delicati aspetti della raccolta delle informazioni sul mercato del lavoro e sul garantire la qualità della formazione. Ad esempio, i sistemi di monitoraggio dei fabbisogni professionali nonché l’individuazione degli standard minimi della qualità delle strutture formative e dei contenuti professionali delle qualifiche devono condividere caratteristiche comuni sul territorio nazionale per evitare una segmentazione dei mercati regionali del lavoro che andrebbero contro gli interessi delle stesse Regioni. In ogni caso gli aspetti nazionali del nostro mercato del lavoro vanno difesi, curati e potenziati, perché ci presentiamo ancora all’interno e all’esterno, soprattutto nei confronti dell’Unione Europea, come un unico sistema nazionale che vuole raggiungere obiettivi di carattere nazionale. Per il resto, le Regioni devono esercitare in piena autonomia le loro funzioni.
Il buon funzionamento del mercato del lavoro è un loro obiettivo specifico e strategico: ne consegue che devono avere gli strumenti, le competenze, le risorse, per raggiungerlo. Stato e Regioni potranno avvalersi dell’aiuto delle due strutture nazionali presenti nel campo delle politiche del lavoro: ISFOL e Italia Lavoro.
In particolare la missione dell’ISFOL è quella di svolgere, oltre alla sua attività tradizionale di sostegno attraverso la ricerca e l’assistenza strategica al Governo e alle Regioni con le azioni di sistema a favore della qualificazione e dell’innovazione dei processi formativi previste dai Piani di utilizzazione del Fondo Sociale, un’attività di analisi, di monitoraggio dei principali indicatori del mercato del lavoro e di valutazione delle politiche. Ciò al fine di verificare se gli obiettivi indicati nel programma governativo di crescita dell’occupazione e di riforma del mercato del lavoro vengano progressivamente realizzati. A questo scopo l’ISFOL si raccorderà con le diverse strutture pubbliche esistenti presso le Amministrazioni centrali e regionali e sarà parte fondamentale dell’attività di monitoraggio delle politiche intraprese, anche tramite iniziative ad hoc, da parte del Governo, predisponendo altresì rapporti periodici da presentare al Governo e alle Regioni per farne oggetto di riflessione al fine di misure correttive.
Il decentramento delle competenze istituzionali aumenta l’esigenza di orientare le politiche attive del lavoro attraverso l’adozione di standard minimi di riferimento per i servizi e di azioni rivolte a riequilibrare i divari territoriali nel mercato del lavoro. In questa direzione Italia Lavoro può svolgere il ruolo di agenzia strumentale delle istituzioni, al fine di effettuare compiti di assistenza tecnica per lo sviluppo delle politiche attive del lavoro, in particolare verso le categorie deboli. Inoltre, può contribuire alla diffusione degli standard dei servizi pubblici per l’impiego (informatici e metodologici), alla cooperazione tra servizi pubblici e soggetti privati nell’ambito delle azioni di sistema verso la disoccupazione di lunga durata, l’immigrazione, il reinserimento delle categorie deboli.
In quest’ambito occorre rendere effettivo l’impegno, richiesto ancora una volta dalle autorità comunitarie, di costruire una società della conoscenza che si fondi su un sistema formativo che accompagni il lavoratore durante tutto l’arco della vita. Il Governo promuoverà, in stretto raccordo con le Regioni e le stesse parti sociali, azioni utili a che entro il 2003, tutti i lavoratori abbiano un’opportunità di formazione nell’informatica, secondo gli impegni assunti in sede comunitaria nell’ambito delle “linee guida” 2001 per l’occupazione.
II.1.7. Incentivi e ammortizzatori
Il Governo intende procedere, sempre in una prospettiva attiva e preventiva, alla riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione, così da portare a razionalizzazione – e semplificare – un quadro normativo diventato non solo ineffettivo e inefficace, ma anche fonte di spreco di risorse pubbliche.
Il riesame degli ammortizzatori, non operato nella precedente legislatura, oltre alle necessità discendenti dal quadro generale d’un mercato del lavoro diverso e più flessibile, dovrà tener conto del fatto che, allo stato, coesistono almeno tre diversi modelli d’uso degli ammortizzatori:
- Un sistema assicurativo con tutele limitate nel tempo e negli importi nei settori extra-agricoli (l’indennità ordinaria);
- Un sistema assicurativo ben più generoso, soprattutto per quanto attiene le durate complessivamente raggiungibili, proprio del settore industriale e che si articola su due strumenti, la mobilità e la CIG – al suo interno ulteriormente articolata su interventi ordinari, aventi una natura più ciclica, e interventi straordinari, spesso anticamera della mobilità;
- Un uso come integrazione del reddito da lavoro dei trattamenti di disoccupazione, in quanto tali non generosi, nel settore agricolo – dove vi è uno squilibrio strutturale tra prestazioni e contribuzioni – e, crescentemente, nello stesso settore extra-agricolo con lo strumento dei trattamenti con requisiti ridotti.
Un mercato del lavoro più flessibile – caratterizzato da maggiori flussi di creazione e distruzione di posti di lavoro e da una maggiore incidenza di carriere e percorsi lavorativi più irregolari e discontinui nel tempo – ed in cui un ruolo in parte diverso, in connessione con lo sviluppo della previdenza complementare, potrà essere assunto dalle somme oggi accantonate per il TFR, richiede ammortizzatori sociali più sviluppati. È di tali sfide che deve farsi carico il processo di superamento delle differenziazioni ed iniquità del sistema tradizionale.
In una logica di medio termine ciò implica la necessità:
- di estendere il livello delle tutele minime fornite dagli ammortizzatori;
- di prevedere trattamenti omogenei e non ingiustificatamente difformi;
- di minimizzare, tenendo conto del nuovo contesto del mercato del lavoro, i possibili disincentivi al lavoro che dagli ammortizzatori possono discendere.
La prima esigenza implicherà, sia pure gradualmente, un ampliamento verso le medie comunitarie dei livelli del volume di spesa da finanziare per via contributiva. Nella spesa complessiva - e quindi anche nel volume di contribuzioni a suo finanziamento, stante la ridotta entità della spesa addebitale a fiscalità generale - l’Italia dista dagli standard comunitari medi per oltre un punto percentuale di PIL. La necessità di rafforzare la tutela a fronte del rischio di disoccupazione, nel quadro del passaggio da un regime di tutele rigide e spesso inefficaci nell’ambito dei singoli rapporti di lavoro in essere ad un regime di tutele nel mercato e che favoriscano la mobilità del lavoro, ha perciò implicazioni che vanno riconosciute anche da un punto macroeconomico e per la politica finanziaria nel suo complesso.
Essendo ferma intenzione del Governo di procedere nella riduzione progressiva del carico fiscale e contributivo gravante sul lavoro, stretti appaiono i collegamenti tra riforma degli ammortizzatori e riequilibrio complessivo della spesa per protezione sociale. Sarà inoltre presumibilmente inevitabile procedere con un approccio graduale, in cui la fermezza della direzione di marcia da intraprendere si abbini ad una gradualità dei passi concreti, che andranno intrapresi man mano che le risorse necessarie si renderanno effettivamente disponibili.
La seconda esigenza comporta il passaggio da una molteplicità di strumenti ad un regime assicurativo di protezione dal rischio di disoccupazione unitario per tutti i lavoratori dipendenti (ed assimilati) che abbiano, senza colpa e non per propria iniziativa, perduto un posto di lavoro e che ne stiano attivamente cercando un altro.
Coerentemente con l’approccio generale più volte esposto in questo Libro Bianco, nulla vieta che ad un regime unico che fornisca una protezione ragionevole ma contenuta si sovrappongano, per autonoma decisione degli interessati e senza alcun onere per la finanza pubblica, schemi a carattere mutualistico-settoriale. Questi possono tener conto della volontà di lavoratori ed imprese di un particolare settore di mantenere il più alto livello di protezione che oggi li caratterizza, ed utilmente mettere a frutto talune esperienze mutualistiche realizzate nel territorio tramite gli enti bilaterali.
Al tempo stesso, è inoltre essenziale che determinate funzioni non propriamente assicurative oggi svolte da taluni ammortizzatori sociali – si pensi ad esempio al regime dei cd requisiti ridotti, di dimensioni tra l’altro crescenti nel tempo – vengano considerate nel disegno complessivo del sistema fiscale e di protezione sociale, al fine di incentivare l’offerta di lavoro e sostenere i redditi dei soggetti più deboli. In tale ottica sarà opportuno integrare ammortizzatori sociali di stampo assicurativo, schemi assistenziali soggetti alla prova dei mezzi, quali ad esempio il Reddito Minimo d’Inserimento sperimentato nei passati anni, e disegno del prelievo fiscale – in particolare per quanto concerne le detrazioni ed i benefici connessi con lo svolgimento d’un lavoro – per far sì che il lavoro, specie nel caso dei soggetti con minori potenzialità reddituali, sia conveniente e quindi risulti essere incentivato .
La terza esigenza richiamata suggerisce che il disegno di prestazioni e contribuzioni sottolinei la natura assicurativa degli ammortizzatori. Queste ultime debbono essere strettamente connesse con le prime, il cui importo non deve esser tale da disincentivare la ricerca di lavoro, dovendosi prevedere precisi limiti al ricorso continuato o ripetuto nel tempo alle prestazioni. Rispetto alle durate oggi garantite dal cumularsi nel tempo di più strumenti nei settori industriali, intenzione del Governo è quella di pervenire ad una riduzione significativa.
Altrettanto importante è infine il collegamento da istituire tra percezione delle prestazioni e politiche attive, il cui fine primo deve esser quello di evitare abusi nel ricorso agli ammortizzatori. Si tratta di introdurre anche nel nostro ordinamento una fondamentale innovazione: nessuna forma di sussidio pubblico al reddito potrà essere erogata se non a fronte di precisi impegni assunti dal beneficiario secondo un rigoroso schema contrattuale. L’erogazione di qualunque forma di “ammortizzatore sociale” dovrà preventivamente basarsi su un’intesa con il percettore affinché questi ricerchi attivamente un’occupazione secondo un percorso – che possa avere anche natura formativa e che eventualmente potrà vedere anche il coinvolgimento di operatori ed intermediari privati, da concordare preventivamente con i servizi pubblici per l’impiego. Rafforzando il coordinamento, anche a livello di assolvimento dei compiti ispettivi e di connessione tra sistemi informativi, tra Centri per l’Impiego, DPL ed Enti previdenziali, la corresponsione del sussidio o indennità dovrà immediatamente essere sospesa in caso di mancata accettazione di opportunità formative od occupazionali o di inottemperanza dello schema a cui il beneficiario si sia preventivamente impegnato. In caso di reiterato rifiuto il beneficiario perderà ogni titolo a percepire il sostegno preventivamente accordato.
Nel riordino dei diversi incentivi, una prima questione che il Governo intende affrontare concerne l’esperibilità di bonus fiscali e/o contributivi che vadano specificamente a vantaggio dei lavoratori a più basso reddito e più bassa qualificazione e che ne incentivino la presenza nel mercato e l’offerta di ore aggiuntive. La finalità, come in altri paesi in cui si è proceduto lungo questa strada (come ad esempio il Family credit del Regno Unito, una deduzione di imposta riservata ai lavoratori con basse retribuzioni e familiari a carico), è quella di contrastare trappole della disoccupazione e della povertà.
Le questioni da affrontare in proposito sono complesse, dovendosi tener conto della interazione tra trattamento fiscale e contributivo e dei rischi di elusione fiscale e sottoinquadramento retributivo e contrattuale insiti nella presenza di trasferimenti a favore di chi non superi una data soglia reddituale. Rispetto ad altre esperienze internazionali, è anche da tenere in conto il fatto che dal raccordo tra incentivi al singolo lavoratore e soglie di reddito familiare potrebbero scaturire disincentivi all’offerta di lavoro femminile nel caso delle donne sposate il cui coniuge sia già occupato, un segmento di offerta di lavoro potenziale da sollecitare che, in Italia, è ben più importante di quello delle singles con figli a carico[22].
Alla complessità si associano peraltro potenzialità di rilievo, dato il contesto di forte concentrazione geografica dei bassi salari nel caso italiano. La presenza di misure di questo tipo potrebbe, infatti, facilitare il processo di decentramento della contrattazione salariale e la creazione di differenziali salariali su base geografica più rispondenti alle diversità esistenti al suo interno.
Il Governo chiede alle parti sociali se non sia giunto il momento di provvedere alla definizione di schemi di incentivazione aventi tali caratteristiche, al fine di attenuare possibili effetti di esclusione sociale e di povertà in alcune fasce cosiddette a rischio della popolazione.
Per quanto concerne gli incentivi all’occupazione in senso proprio, le esigenze da rispettare nel quadro di un riordino complessivo della materia, inattuato nella precedente legislatura, sono:
- L’aumento di selettività degli incentivi a favore dei soggetti deboli, identificabili su base territoriale (in base allo stato del mercato del lavoro tanto a livello locale quanto della macroarea in cui il soggetto opera) o sulla base di caratteristiche individuali ben precise (lavoratori licenziati, soggetti con carichi familiari, persone a rischio di divenire disoccupati di lunga durata etc.);
- La previsione di sostegni e di un regime contributivo che complessivamente favorisca la trasformazione e il ricorso al contratto a tempo indeterminato, tenendo così tra l’altro conto del minor rischio di disoccupazione in esso insito e contrastando l’insorgere di segmentazioni nel mercato del lavoro.
Due considerazioni appaiono in proposito rilevanti. Intenzione del Governo è riordinare gli strumenti esistenti alla luce del parallelo riordino delle tipologie contrattuali. In questo quadro, spazi finanziari atti ad accrescere la selettività degli incentivi potranno esser ottenuti dalla creazione d’un contesto normativo generale meno rigido, ed in cui meno necessario sia prevedere specifici incentivi finanziari a compensazione di rigidità normative. In particolare, il Governo vuole verificare quanto tale strada possa essere perseguita nel caso dei contratti a causa mista e delle esperienze lavorative a termine dei più giovani.
Una seconda considerazione, in parte peraltro collegata con quanto sinora detto, attiene l’esigenza di tener conto, nell’individuazione dei soggetti deboli da sostenere, delle modifiche del contesto economico e sociale. Da questo punto di vista il Governo sottolinea in particolare l’esigenza di procedere ad un graduale spostamento di enfasi dalla platea dei soggetti più giovani a quella dei soggetti più anziani, la cui permanenza nel mondo del lavoro è tra gli obiettivi prioritari dei prossimi anni, attraverso una combinazione di incentivi alla permanenza e disincentivi alla fuoriuscita dal mondo del lavoro.
Un’importante questione da affrontare è quella che concerne il peso del dato territoriale nell’identificazione dei soggetti deboli, un connotato senza dubbio essenziale nel definire la difficoltà di accesso al mercato dei diversi soggetti e da cui qualsiasi sistema d’incentivazioni non può prescindere. In questa prospettiva si è già sottolineato come sia intenzione del Governo verificare in che misura siano esperibili ed efficaci misure che facilitino la creazione di un differenziale nei costi del lavoro tra aree territoriali attraverso la previsione di misure a sostegno dei redditi da lavoro più bassi.
Allo stesso scopo è anche intenzione del Governo valutare attentamente anche gli effetti della riforma in senso federale dello Stato sulle politiche di incentivazione monetaria delle imprese. E’ noto, infatti, che l’art. 87 del Trattato CE non vieta l’adozione di misure di incentivazione di applicazione generale e automatica su tutto il territorio (c.d. misure generali), ma solo interventi selettivi che favoriscano talune imprese o talune produzioni rispetto a quello che è il «sistema generale di riferimento» in cui di volta in volta si colloca la singola misura incentivante adottata. In uno Stato federale, a seconda della ripartizione di competenze tra Stato federale e Stato federato, può infatti sostenersi che il «sistema generale di riferimento» rispetto al quale le autorità comunitarie sono chiamate a valutare la compatibilità di una singola misura non sia più quello dello Stato federale ma quello del singolo Stato federato. Nella prospettiva delle politiche di sviluppo del Mezzogiorno la riforma in senso federale dello Stato potrebbe pertanto garantire maggiori margini di manovra rispetto al passato anche con riferimento ai vincoli posti dall’Unione Europea.
Nel riordino delle misure d’incentivazione, i nessi tra queste e gli ammortizzatori sociali, nonché tra interventi finanziari, passivi od attivi, e servizi all’impiego dovranno essere riesaminati. Il ruolo semplicemente notarile fino ad oggi assolto dalle strutture pubbliche è evidentemente inadeguato. Pur dovendosi preferire il ricorso a strumenti automatici, tanto nel caso delle misure passive quanto in quello delle misure attive, i servizi per l’impiego, pubblici e privati, possono, infatti, utilmente operare nel senso della prevenzione di abusi e di aumento della selettività effettiva di determinati strumenti, promuovendone il ricorso effettivo tra i soggetti più deboli.
Il Governo ritiene che le tecniche di incentivazione economica debbano essere opportunamente combinate con adeguate forme di incentivazione normativa, specialmente con riferimento alle tipologie contrattuali più innovative. Il caso offerto dal part time, dove gli incentivi di recente previsti per le assunzioni part time a tempo indeterminato sono state sottoutilizzate per via delle rigidità normative che tuttora persistono nel ricorso allo strumento, è al riguardo particolarmente emblematico. Infatti, a fronte di 200 miliardi stanziati nel 2000, ne sono stati utilizzati appena 5, pari al 2,6%, per un totale di poco più di 3300 contratti stipulati. Tra le forme di incentivazione normativa potrà essere considerata anche l’esclusione dal computo dei dipendenti –al fine di stabilire le soglie occupazionali necessarie per l’applicazione di istituti vari del diritto del lavoro- dei soggetti che abbiano stipulato con il datore di lavoro tipologie contrattuali che si intendono sostenere e promuovere al fine di incentivare l’occupazione. In quest’ambito anche lo stesso contratto a tempo indeterminato potrebbe essere considerato non computabile –sempre che esso sia funzionale alla creazione di occupazione aggiuntiva- ancorché temporaneamente per incentivare le imprese a sfuggire alla sindrome del “nanismo”, espandendosi quindi oltre le dimensioni occupazionali minime stabilite per l’applicazione di taluni istituti del diritto del lavoro.
II.2. Qualità (...better jobs)
La qualità del lavoro (e quindi del mercato in cui opera) è un problema europeo, certamente non solo italiano. Il Consiglio europeo di Lisbona (2000) e quello di Stoccolma (2001) hanno significativamente molto insistito sul tema dei more and better jobs e tutti gli attori istituzionali e sociali devono indirizzare le politiche del mercato del lavoro e la relativa regolazione istituzionale per sostenere quanti si trovano occupati in lavori di bassa qualità, affinché progrediscano verso occasioni di migliore qualità anziché scivolare nell’esclusione sociale e nella disoccupazione, specie se di lunga durata.
Le proposte della Commissione Europea sono condensate in una recente comunicazione intitolata Employment and social policies: a framework for investing in quality (20.6.2001, COM(2001) 313 final), indirizzata al Consiglio ed al Parlamento europeo in vista del Consiglio Europeo di Laeken, dove dovranno essere adottati orientamenti vincolanti in materia per gli Stati membri, incorporandoli nella stessa Strategia Europea per l’ Occupazione. Non è evidentemente necessario ripercorrere in questa sede le proposte della Commissione sulla qualità del lavoro. In ogni caso il Governo condivide l’approccio, ormai consolidatosi da parte della Commissione europea, sempre meno interessato al profilo regolatorio più tradizionale ed invece proiettato con crescente intensità verso una dimensione altamente innovativa quanto a tecniche di intervento per realizzare gli obiettivi condivisi in sede comunitaria.
Nell’impegnarsi a favore di una migliore qualità del lavoro il Governo intende soprattutto impegnarsi a favore di un mercato privo di segmentazioni al suo interno tra posti di lavoro precari ed ipergarantiti, ed in cui il lavoro sia effettivo strumento d’inclusione sociale. Per un paese come il nostro, un primo concreto estrinsecarsi di questo impegno per la qualità del lavoro è nella battaglia contro il sommerso. Più in generale, ne deriva che la qualità del lavoro è da misurare non solo e non tanto con riferimento a specifiche caratteristiche, salariali e non salariali, dei singoli rapporti di lavoro concreti, quanto con le chances che a questi si associano di ulteriore progresso nel mercato del lavoro, innanzitutto in termini di chances lavorative future. Il riferimento alla qualità del lavoro non è perciò da intendere come limitativo dell’obiettivo d’innalzamento del tasso d’occupazione prima esplicitato.
Il Governo italiano sosterrà al Consiglio europeo di Laeken l’integrazione del principio della “qualità del lavoro” fra gli obiettivi della Strategia Europea per l’Occupazione, in una logica di mainstreaming. Non si deve trattare di una semplice adesione formale, quanto della convinta utilizzazione di una nuova metodologia per realizzare un confronto con Regioni, enti locali e parti sociali sui temi del lavoro e dell’occupazione. Le riflessioni e gli indicatori quantitativi di qualità proposti dalla Commissione devono essere attentamente valutati in vista delle decisioni che, a fine anno, verranno adottate. A questo fine il Governo raccomanda in particolare alle parti sociali di prestare a questi indicatori la dovuta attenzione all’interno dello stesso dialogo sociale, così che eventuali intese o comunque le convergenze realizzate possano giovarsi di questa nuova metodologia.
Concordare, ad esempio, che un lavoro potrà definirsi “buono” quando ad esso sono connesse prospettive di carriera o comunque sono apprestate misure finalizzate alla promozione di una prospettiva di carriera implica poi convenire sulle tecniche per realizzare questo obiettivo. Le parti sociali hanno un interesse convergente a perseguirlo, in una logica di valorizzazione e fidelizzazione delle risorse umane, per motivarle più convenientemente, esaltandone la lealtà e la produttività. Il Governo non può certo a sua volta non fare una scelta in proposito e senza dubbio occorre pronunciarsi per una politica delle risorse umane che esalti le potenzialità, la creatività, la capacità innovativa dei lavoratori italiani che devono essere messi in grado, anche con l’intervento pubblico sul mercato del lavoro, di vivere da protagonisti l’esperienza della loro vita lavorativa.
Il Governo auspica che il tema della “qualità del lavoro” diventi rilevante nel confronto con gli attori istituzionali e sociali, producendo proposte ed approfondimenti in relazione agli orientamenti espressi in proposito dalla Commissione europea. In ogni caso, gli indicatori di qualità concordati in sede comunitaria saranno opportunamente utilizzati anche per la definizione dell’intervento legislativo di cornice in ragione della prospettiva federalista, al fine di disegnare un nuovo assetto regolatorio orientato al perseguimento degli obiettivi di qualità prefissati, pure nella varietà delle misure che verranno adottate, di iniziativa legislativa oppure di natura convenzionale.
II.2.1. Lavoro regolare
Tutti gli obiettivi sin qui elencati non potranno essere facilmente raggiunti se continueranno a perdurare gli attuali livelli di occupazione irregolare e clandestina che, come noto, raggiungono stime percentuali due o tre volte superiori rispetto a quanto si verifica negli altri paesi europei. Secondo dati ISTAT, la percentuale di lavoratori irregolari sulla forza-lavoro totale è pari a circa il 15 per cento mentre il CENSIS stima questa quota al 23 per cento. Altre recenti indagini considerano il peso dell’economia sommersa in Italia in una misura doppia rispetto a quella della media dei paesi dell’Unione Europea. In continuo aumento è anche il fenomeno del lavoro irregolare da parte di immigrati clandestini, privi di regolare permesso di soggiorno. La gravità del fenomeno è evidente per tutti: non si tratta soltanto di arginare fenomeni di concorrenza sleale, ma anche di creare regole per una competizione equa e socialmente sostenibile, e che soprattutto eviti il rischio di degenerare in fenomeni di collusione con la criminalità organizzata, con il caporalato, con lo sfruttamento del lavoro minorile e di soggetti con scarsa forza contrattuale sul mercato del lavoro.
Le analisi socio-economiche sulle ragioni di questa larga diffusione del lavoro sommerso sono concordi nel sottolineare la maggiore convenienza del lavoro nero rispetto a quello regolare, e questo sia sul lato della domanda sia su quello dell’offerta. Le convenienze del lavoro irregolare, cioè, raramente sono imposte da uno dei due contraenti, ma sono in genere tali da dare vita a fenomeni di collusione difficili da sradicare. Da questo punto di vista la soluzione dei c.d. contratti di riallineamento retributivo, da tempo sperimentata nel nostro ordinamento, se certo ha rappresentato un’innovazione nelle strategie di emersione del lavoro non regolare, in quanto affianca alla logica repressivo-sanzionatoria una prospettiva di tipo promozionale e incentivante, non pare tuttavia in grado di fornire risposte soddisfacenti.
Il vero limite dei contratti di gradualità è che essi si limitano a neutralizzare temporaneamente, con un incentivo economico, il disincentivo alla regolarizzazione rappresentato da norme sul lavoro che risultano impraticabili in alcune aree del Paese, senza incidere sulle cause che inducono le imprese e i lavoratori a fuoriuscire dal mercato del lavoro regolare. Ampia dimostrazione di ciò è data dalle enormi difficoltà di sopravvivenza in cui si imbattono le (non molte) imprese sino a oggi emerse per un numero di posizioni lavorative regolarizzate (circa 190.000) del tutto marginale rispetto alle attuali dimensioni del fenomeno. La vera soluzione pare dunque quella di affrontare alla radice i problemi del mercato del lavoro e dell’economia italiana, sia attraverso una seria politica industriale che, invece di sprecare risorse pubbliche per ammortizzare i costi del lavoro, incentivi le imprese a intraprendere i necessari cambiamenti, sia attraverso un adattamento delle regole del mercato del lavoro. Per questo motivo il Governo ritiene importante il nuovo provvedimento contenente “norme per l’emersione dell’economia sommersa” adottato nell’ambito dei provvedimenti dei 100 giorni per il rilancio dell’economia. Questa nuova misura di incentivazione fiscale, per quanto innovativa rispetto al passato e perfettamente compatibile con i vincoli posti dal diritto comunitario della concorrenza in materia di aiuti di Stato, rappresenta peraltro solo il primo provvedimento di una ben più ampia strategia di razionalizzazione del sistema produttivo e di lotta alla illegalità.
Gli alti tassi di lavoro irregolare spiegano peraltro i modesti tassi di occupazione del nostro Paese. Questo fenomeno alimenta un circuito perverso: i bassi tassi di occupazione e il lavoro regolare restringono la base imponibile e, con essa, il gettito fiscale necessario per alimentare la spesa pubblica. La conseguenza è o un inasprimento della pressione fiscale, con conseguente spinta all’immersione nel lavoro irregolare, o un contenimento della spesa per occupazione, politiche attive del lavoro, infrastrutture, ecc. Accanto all’intervento strutturale sul mercato del lavoro e ad un migliore e più efficiente utilizzo degli incentivi all’emersione, una strada per contrastare il lavoro nero potrebbe essere quella di agire sulla leva fiscale, come peraltro suggerito dalla Commissione Europea e realizzato in alcuni Paesi europei. Da questo punto di vista la riforma forse più interessante è quella proposta dal Consiglio UE nell’ambito della Strategia Europea per l’Occupazione, volta a ridurre in modo generalizzato la pressione fiscale e contributiva sui salari più bassi, che sono poi la vera area di proliferazione del sommerso. Considerato che i salari più bassi sono peraltro particolarmente diffusi al Sud, soprattutto tra la popolazione giovanile e femminile, questo provvedimento avrebbe innanzitutto un benefico effetto per il Mezzogiorno aumentando nel contempo le prospettive di occupabilità per le categorie sociali soggette a maggiori rischi di esclusione sociale.
Assieme alla Grecia, l’Italia è il Paese dell’Unione Europea con il più elevato tasso di ‘lavoro nero’. L’incapacità di affrontare con coraggio una riforma del mercato del lavoro è un vincolo non più sostenibile per le imprese che spesso sono costrette a lavorare ai margini della legalità, anche in assenza di un intento fraudolento. Proprio dall’angolo prospettico della modernizzazione del mercato del lavoro, l’esperienza comparata insegna che l’adozione di nuove e più moderne tipologie contrattuali può risultare decisiva nel contrastare il fenomeno del lavoro non dichiarato. La diffusione del lavoro autonomo tra gli immigrati può concorrere a perpetuare mestieri altrimenti destinati a scomparire nonché a favorire i processi di integrazione sociale.
Assai interessante è ad esempio il caso spagnolo dove sono in corso di sperimentazione i “contratti a costo zero”. Allorché occorra sostituire una dipendente in permesso di maternità, viene consentito al datore che assuma una disoccupata di essere esentato dal pagamento degli oneri previdenziali. Una misura sicuramente convincente soprattutto per le unità aziendali di piccole e piccolissime dimensioni. Anche l’esperienza belga del “lavoro accessorio” è sorretta dalla medesima finalità di favorire la riemersione. Si tratta di attività varie (assistenza familiare e domestica, aiuto alle persone ammalate o con handicap, sorveglianza dei bambini, insegnamento supplementare, piccoli lavori di giardinaggio, collaborazione a manifestazioni sociali, caritatevoli, sportive, culturali). Tali attività vengono svolte a beneficio di famiglie, società senza scopo di lucro ed enti pubblici da soggetti quali disoccupati di lunga durata, casalinghe, studenti, pensionati. Fulcro dell’esperimento è costituito dall’utilizzazione di “buoni” in alternativa ai pagamenti diretti, per semplificare il processo e, nel contempo, certificare le prestazioni.
Ogni accorgimento volto a creare un sistema di convenienze nella gestione del rapporto di lavoro contribuisce senz’altro a regolarizzare ampie zone di evasione fiscale e contributiva. Si consideri ancora il settore dei servizi di assistenza alla persona, con particolare riferimento agli anziani, caratterizzato da una diffusissima area di clandestinità, anche in considerazione del massiccio ricorso a personale di origine extracomunitaria. A tale riguardo è interessante il tentativo di realizzare intese a livello locale (come è avvenuto, ad esempio, ad iniziativa del Comune di Modena), valorizzando tipologie contrattuali come le collaborazioni coordinate e continuative che possono agevolare il processo di regolarizzazione nell’ambito di una disciplina concordata dalle parti sociali e dagli enti locali in sede territoriale. Anche lo stesso ‘Patto di Milano’ sta contribuendo a creare occupazione regolare coinvolgendo soggetti a rischio di esclusione sociale (anche in questo caso lavoratori extracomunitari ed altre categorie). La diffusione del lavoro autonomo tra gli immigrati può concorrere a perpetuare mestieri altrimenti destinati a scomparire nonché a favorire i processi di integrazione sociale.
Il Governo ritiene che anche dalla modernizzazione del mercato del lavoro possa provenire una forte spinta alla regolarizzazione del lavoro non dichiarato. Tutte le misure, sintetizzate nel presente Libro Bianco, devono essere concepite nell’ottica di un disegno complessivo volto a semplificare e quindi a bonificare il nostro tessuto occupazionale.
II.2.2. Lavoro a tempo indeterminato
Legislazione e contrattazione mantengono come obiettivo centrale la conservazione del posto di lavoro piuttosto che la mobilità del singolo nelle transizioni tra scuola e lavoro, tra non lavoro e lavoro, tra lavoro e formazione, determinando in questo modo anche una crescente divaricazione rispetto alle necessità delle imprese di forme flessibili di adeguamento della manodopera. Peraltro il permanere di situazioni occupazionali caratterizzate da un alto livello di tutela accanto a quelle, in rapida diffusione anche grazie a recenti riforme (lavoro temporaneo, assunzioni a termine, ecc.), caratterizzate da rapporti di lavoro altamente flessibili, genera nuove forme di segmentazione del mercato, contrastando gli effetti benefici della liberalizzazione dei meccanismi di ingresso nel mondo del lavoro. Una delle soluzioni potrebbe essere quella di una riforma “simmetrica” della regolamentazione che si traduce in un duplice e contemporaneo intervento sulla normativa relativa sia al contratto a tempo determinato, sia a quello a tempo indeterminato. Ciò che rileva è rendere, tra l’ altro, meno difficoltoso il passaggio a condizioni di lavoro stabile per i lavoratori che iniziano il proprio percorso con occupazioni temporanee ed eviterebbe possibili fenomeni di riduzione degli investimenti in capitale umano.
Il Governo ritiene che alla nozione di sicurezza data dall’inamovibilità del singolo rispetto al proprio posto di lavoro occorra sostituire un concetto di sicurezza conferito dalla possibilità di scelta effettiva nel mercato del lavoro. Non solo ma è davvero urgente creare le condizioni perché si elevi la qualità della nostra occupazione, stimolando maggiori investimenti in risorse umane assunte in forma stabile, a tutto vantaggio di una crescente fidelizzazione, produttività, creatività e, quindi, qualità, della stessa forza lavoro. Occorre dunque incentivare convenientemente il ricorso al contratto di lavoro a tempo indeterminato, così da incrementarne l’uso, evitando, nel contempo, che si diffondano forme di flessibilità in entrata per aggirare i vincoli o comunque le tutele predisposte per la flessibilità in uscita.
Il Governo dichiara a tale proposito di riconoscersi pienamente nel principio del “licenziamento giustificato”, peraltro ora solennemente proclamato nella Carta di Nizza dell’Unione Europea. Il modello sociale europeo deve certamente essere modernizzato ma non è assolutamente revocabile in dubbio la regola fondamentale per cui atti estintivi del rapporto di lavoro devono essere giustificati e motivati dal datore di lavoro, nonché sottoposti eventualmente al vaglio di un’autorità indipendente. Fin dal 1966 questa fondamentale acquisizione fa parte dell’ordinamento giuridico italiano ed il Governo dichiara di ritenerla definitivamente acquisita. Del pari deve ritenersi consolidato il regime attuale in connessione con i divieti del licenziamento discriminatorio, del licenziamento della lavoratrice in concomitanza con il suo matrimonio e del licenziamento in caso di malattia o maternità, tutte ipotesi che restano completamente estranee alla riflessione in atto.
E’ bene aver presente in proposito ancora una volta l’esperienza comparata. In primo luogo, esistono Stati membri dell’Unione in cui in caso di licenziamento riconosciuto illegittimo il lavoratore può pretendere unicamente il risarcimento del danno. Si tratta del Belgio, della Danimarca, del Regno Unito, della Finlandia (dove il lavoratore può tuttavia pretendere interventi di formazione, a carico del datore, che conservino o migliorino la sua professionalità). Negli altri ordinamenti è sempre prevista la possibilità di corrispondere un’indennità compensativa in alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro. Così in Francia dove il datore non è tenuto a dar corso all’ ordine di reintegrazione del conseil des purd’hommes, potendo liberarsi corrispondendo un’ indennità sostitutiva fino ad un massimo di 39 settimane di retribuzione. Stesso regime vige in Germania (dove tuttavia il datore di lavoro ha l’onere di motivare le ragioni che rendono impraticabile la reintegrazione), in Grecia, in Spagna (occorre un rifiuto motivato del datore a reintegrare e viene in tal caso comminata una indennità fino ad un massimo di 15 giorni di retribuzione per anno di lavoro, senza superare le 12 mensilità), in Svezia (l’indennità sostitutiva è compresa tra le 16 e 48 mensilità, a seconda dell’ età e della anzianità di servizio del prestatore).
Il Governo ritiene che, per valorizzare appieno il capitale umano, presente nel nostro Paese debba essere creato un quadro istituzionale più favorevole all’utilizzazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Occorrerà procedere ad un attento monitoraggio dell’utilizzazione di tipologie contrattuali diverse, al fine di rilevare eventuali spinte verso un’eccessiva precarizzazione del nostro mercato del lavoro. Nel contempo il Governo ritiene debbano essere studiate nuove forme di incentivazione nell’ uso del contratto a tempo indeterminato –con particolare riguardo alla trasformazione del contratto a termine- e chiede in particolare modo alle parti sociali di confrontarsi su questo argomento, accertando l’eventuale esistenza di ostacoli normativi che frenino il ricorso a questa tipologia contrattuale, senz’ altro fondamentale per garantire una società attiva basata sulla qualità del lavoro.
II.3. Flessibilità e sicurezza
II.3.1. Organizzazione e rapporti di lavoro
Il Governo italiano condivide pienamente la affermazione della Commissione europea secondo cui è necessario procedere organicamente ad una modernizzazione dell’ organizzazione e dei rapporti di lavoro, così come espressa nel Libro Verde Partnership for a new organisation of work (COM(97) 128) e quindi nella Comunicazione Modernising the organisation of work – a positive approach to change (COM(98) 592). Tale posizione si è poi consolidata all’ interno delle “linee guida sull’ occupazione” nel quadro del processo di Lussemburgo (v. § 3,4) dove è stato individuato un pilastro apposito, quello della “adattabilità” che impone agli Stati membri obblighi molto precisi.
Giova ricordare in proposito che la ‘linea guida’ 14 per il 2001 prevede che “gli Stati membri, se del caso assieme alle parti sociali, o sulla scorta di accordi negoziati dalle parti sociali:
- “esamineranno il quadro normativo esistente e vaglieranno proposte relative a nuovi provvedimenti e incentivi per assicurarsi che essi contribuiscano a ridurre gli ostacoli all’occupazione, ad agevolare l’introduzione di un’organizzazione del lavoro moderna e ad aiutare il mercato del lavoro ad adeguarsi ai mutamenti strutturali in campo economico;
- al tempo stesso, tenendo in considerazione la crescente diversificazione delle forme di lavoro, esamineranno la possibilità di contemplare nella normativa nazionale tipologie contrattuali più flessibili e faranno in modo che coloro che lavorano con contratti di tipo flessibile godano di una sicurezza adeguata e di una posizione occupazionale più elevate, compatibili con le esigenze e le aspirazioni dei lavoratori (…)”.
E’ bene tenere presente inoltre che la ‘linea guida’ 15 tratta della necessità di sostenere l’adattabilità nelle aziende nell’ ambito dell’ apprendimento lungo tutto l’arco della vita. A tal proposito si prevede che:
- “le parti sociali, a tutti i livelli appropriati, sono invitate a concludere accordi, se del caso, sull’apprendimento lungo tutto l’arco della vita per agevolare l’adattabilità e l’innovazione, in particolare nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. In tale contesto dovrebbero essere poste le condizioni per offrire entro il 2003 a ogni lavoratore un’opportunità di apprendere le tecniche della società dell’informazione”.
Il Governo segnala alle parti sociali che alcune parti delle ‘linee guida’ appena citate riguardano direttamente la loro responsabilità e le invita ad adoperarsi conseguentemente affinché nella redazione del Piano Nazionale di azione per l’Occupazione (NAP) per il 2002 se ne possa dare adeguatamente conto. Per quanto attiene alla sua diretta responsabilità il Governo dichiara di considerare urgente predisporre misure di modernizzazione, auspicabilmente concordate con le parti sociali, anche al fine di facilitare la transizione verso un’economia fondata sulla conoscenza, così come sottolineato dalle conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona. Del resto, la stessa “Agenda di Politica Sociale”, concordata al Consiglio Europeo di Nizza, insiste sull’importanza di adattare la regolazione dei rapporti e dei mercati del lavoro al fine di creare un opportuno equilibrio tra flessibilità e sicurezza, invitando apertamente le parti sociali a continuare nel loro dialogo sull’organizzazione del lavoro ed in particolare sulle nuove forme di occupazione.
Non è certo revocabile in dubbio che il progresso tecnologico così come i mutamenti nelle condizioni di mercato abbiano, negli ultimi decenni, modificato profondamente l’ambiente nel quale le imprese si trovano ad operare. Si è così determinata una crescente necessità di reagire con maggiore flessibilità ai cambiamenti sul fronte dell’ offerta e della domanda, mentre gli sviluppi tecnologici hanno consentito alle imprese di introdurre modalità nuove e più flessibili nell’ organizzazione dei processi produttivi. Al fine di trarre pieno vantaggio da questo potenziale evolutivo, appare evidente – nella valutazione delle autorità comunitarie, del tutto condivisa dal Governo italiano – la necessità di adattare il presente quadro regolatorio, legislativo e contrattuale, a queste nuove circostanze. L’attuale quadro regolatorio riflette, infatti, un’organizzazione del lavoro oggi completamente superata.
Per quanto riguarda in particolare il contesto italiano, la modernizzazione dell’ordinamento giuridico e contrattuale del lavoro è inoltre da considerarsi componente essenziale di una politica che intende contrastare il preoccupante fenomeno del lavoro non dichiarato e clandestino. Nella passata legislatura sono stati realizzati interventi importanti (ad es. la legge 196/97, il cd. Pacchetto Treu) ma ancora del tutto insufficienti. Si è proceduto troppo lentamente, scontando pregiudiziali ideologiche incompatibili con gli orientamenti comunitari richiamati. Il Governo è determinato nell’arco della presente legislatura a realizzare le riforme concordate a livello comunitario, nella convinzione che la necessità di rivedere l’assetto istituzionale preposto alla regolazione dei rapporti e dei mercati del lavoro non possa ulteriormente essere messa in discussione. Anche a tal proposito si ribadisce la finalità di questo Libro Bianco ad aprire un confronto con i soggetti istituzionali e sociali che sia produttivo di idee e proposte.
II.3.2. Part-time
E, bene ricordare come questa tipologia contrattuale, largamente valorizzata negli orientamenti comunitari, pure conoscendo negli ultimi tempi un netto incremento, viene ancora utilizzata in una misura ridotta rispetto agli altri paesi comunitari. In Europa usano il part time meno di noi solo Spagna e Grecia, paesi ai quali ci accomuna anche una quota ridottissima (meno dell’8%) di lavoratori anziani (fra i 55 e i 64 anni) occupati con questa forma contrattuale, così da poter favorire l’ingresso di giovani nel mercato del lavoro, uscendone loro stessi con gradualità.
L’esperienza comparata è assai significativa quanto soprattutto alle tecniche incentivanti utilizzate per incoraggiare la stipulazione di contratti a tempo parziale. La Francia, al pari dell’Italia, rappresenta un caso dove gli incentivi di natura contributiva sono vanificati nella loro finalità promozionale a causa di una disciplina legislativa e regolamentare del tutto disincentivante. Invece in Germania tra gli incentivi di natura normativa è bene ricordare che fin dal 1985 le imprese con meno di 5 dipendenti sono esentate dall’applicazione della normativa sui licenziamenti illegittimi e nel computo di questo campo di applicazione rientrano soltanto i prestatori che lavorano un minimo di 10 ore settimanali o di 45 ore mensili. Sulla falsariga dell’esperienza olandese, è ora riconosciuto al lavoratore tedesco con anzianità di servizio di almeno sei mesi il diritto di ridurre l’orario di lavoro settimanale, salvo motivate ragioni aziendali. Ancor più significativo è il fatto che in Germania il datore ed il prestatore di lavoro possono concordare che quest’ultimo esegua la propria prestazione di lavoro a seconda delle necessità (cd. lavoro a chiamata o a richiesta). Nei Paesi Bassi non esistono limiti al ricorso al lavoro a chiamata, anche perché questo non viene considerato dall’ordinamento alla stregua di un vero e proprio contratto di lavoro subordinato
Anche in Spagna ci si è resi conto dell’insufficienza di incentivi economici non collegati a quelli di natura normativa e con la riforma del 2001 sono stati significativamente ampliati gli spazi di ricorso al lavoro supplementare, flessibilizzando anche la distribuzione dell’orario concordato. Vale la pena ricordare infine che nel Regno Unito non esistono limiti di sorta né al lavoro a chiamata, né al lavoro supplementare.
In Italia l’attuazione della direttiva europea 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale ad opera dei decreti legislativi 61/2000 e 100/2001 costituisce ad avviso del Governo un esempio di trasposizione non rispettosa della volontà delle parti sociali a livello comunitario, confermata dalla suddetta direttiva. Mentre, infatti, la direttiva stessa invita gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena utilizzazione di questa tipologia contrattuale in una logica di promozione dell’occupazione, i decreti emanati nel corso della passata legislatura introducono nuovi vincoli e pertanto tradiscono l’intento promozionale del legislatore comunitario.
Da questo punto di vista, il d. lgs. 100/2001 rappresenta senza dubbio un’ulteriore occasione mancata per rimuovere le incongruenze del quadro legale scaturito dal d.lgs. 61/2000. Inutili appesantimenti burocratici mortificano l’autonomia individuale delle parti. Soprattutto i vincoli legislativamente imposti a quelle che il legislatore chiama impropriamente “clausole elastiche” (mentre in realtà si tratta di “clausole flessibili”, relative cioè alla collocazione temporale della prestazione lavorativa ad orario ridotto e non alla sua estensione) costituiscono un vulnus all’autonomia delle parti sociali ed a quella dei soggetti titolari dei rapporti di lavoro, trattati con ingiustificata subalternità dal legislatore. Occorre rivedere prontamente tale disciplina, restituendo alla contrattazione collettiva ed alle pattuizioni individuali piena operatività.
Con particolare riferimento al tema della “clausole elastiche” il d.lgs. 100/2001 ha mantenuto sostanzialmente inalterata la struttura di base del d.lgs. 61/2000, che pure dichiarava di voler modificare. In particolare sopravvivono sostanzialmente due vincoli che rendono questo strumento ben poco utilizzabile in pratica. Anzitutto la contrattazione collettiva può prevedere clausole elastiche “in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa”, introducendo quindi un elemento di rigidità in un istituto che invece potrebbe, se inteso con la necessaria flessibilità, contribuire a regolarizzare numerose forme di lavoro prestato con intermittenza e non suscettibile di esatta predeterminazione dalle parti. Il legislatore rivela in proposito un’ispirazione vincolistica davvero non condivisibile e non si vede perché le parti, a livello individuale, non possano accordarsi anche sulla elasticità della durata della prestazione dedotta in contratto e non già soltanto sulla flessibilità della collocazione temporale, peraltro penalizzata da vincoli di preavviso assai rigorosi. Il Governo ritiene che possa essere richiesto al datore di lavoro di specificare nel contratto le ragioni di natura tecnica, organizzativa o produttiva che rendono necessaria la natura elastica della prestazione, senza dar luogo ad ulteriori limiti od impedimenti ad opera della legge, così da non comprimere inutilmente l’autonomia contrattuale delle parti.
In secondo luogo non si comprende la fondatezza del diritto del lavoratore di denunciare lo stesso patto volontariamente stipulato in vista di una prestazione di lavoro ad orario parziale secondo la formula delle “clausole elastiche”. Questo esercizio di uno jus penitendi all’interno di un accordo contrattuale liberamente sottoscritto appare del tutto incomprensibile e contravviene ai principi che governano il generale il diritto delle obbligazioni. Ancora una volta è rilevabile un atteggiamento di sospetto e di prevenzione nei confronti di forme innovative che opportunamente utilizzate potrebbero arricchire il tessuto occupazionale di nuovi posti di lavoro regolari, coniugando opportunamente esigenze di lavoro ed aspettative familiari e personali. Il Governo ritiene che l’istituto della “denuncia” debba senz’altro essere superato, al fine di rispettare pienamente la libertà contrattuale delle parti.
Altri ancora sono gli aspetti in relazione ai quali il legislatore nazionale ha disatteso alcune prescrizioni della direttiva comunitaria. E’ sufficiente in questa sede ricordare la mancata esclusione dei lavoratori occasionali, nonché la disciplina del diritto di precedenza dei lavoratori che hanno trasformato il rapporto da full-time a part-time in caso di nuove assunzioni a tempo pieno da parte del datore di lavoro, ben più temperata nella direttiva (“per quanto possibile, i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione…”) che nel testo legislativo italiano, la cui assolutezza rischia peraltro di innescare ampi spazi di contenzioso. Occorre anche ricordare che il testo della direttiva scoraggia il ricorso al lavoro supplementare, vanificato dalla previsione del diritto di rifiuto, dal diritto al consolidamento e dalle maggiorazioni previste per legge.
Da ultimo è bene ricordare che le misure legislative, finora emanate con lo scopo di incentivare il ricorso al lavoro a tempo parziale, sotto l’aspetto previdenziale si sono dimostrate assolutamente inefficaci. In particolare, l’elemento che ha inciso negativamente sulle finalità incentivanti è l’aver collegato i benefici contributivi – come ha fatto il decreto interministeriale 12 aprile 2000, in attuazione del disposto del decreto legislativo 61/2000 – solo alla stipula di part-time ad incremento della base occupazionale. Una conferma della inadeguatezza della scelta legislativa è data dallo scarsissimo impiego delle risorse finanziarie, stanziate dalle legge e già esigue di per se stesse.
Un reale ed efficace impulso all’attivazione di contratti di tale tipologia può, invece, derivare da soluzioni più flessibili, tali da valorizzare convenientemente i benefici contributivi accordati, con particolare riferimento anche alla stipula di contratti a tempo parziale in favore di particolari categorie di lavoratori, considerate svantaggiate ai fini dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro (giovani disoccupati, pensionati, lavoratori nel ciclo conclusivo della propria vita lavorativa, dopo che riprendono il lavoro dopo un periodo di inattività, ecc.).
II.3.3. Lavoro interinale e intermediazione
Il Governo ritiene che il lavoro temporaneo tramite agenzia di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 abbia costituito una positiva riforma nel senso della modernizzazione del mercato del lavoro italiano. I risultati in termini di promozione dell’occupazione appaiono estremamente eloquenti ed il Governo auspica a tale riguardo che non vengano frapposti ulteriori ostacoli per sperimentare altre forme di modernizzazione capaci di provocare ricadute così interessanti sul piano occupazionale. Questo giudizio positivo non può esimere tuttavia dal rilevare che si tratta comunque di una legislazione più restrittiva di quella esistente in numerosi Paesi dell’area comunitaria, con particolare riferimento al regime di ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo.
Tuttavia la legge 196/1997, all’art. 2, comma 2, lett. A), secondo periodo, prevede per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo che tale attività rappresenti, in via esclusiva, l’oggetto sociale. Ciò comporta che a tali imprese è preclusa l’attività di mediazione privata tra domanda e offerta di lavoro, l’attività di ricerca e selezione del personale non finalizzata immediatamente alla fornitura di lavoro temporaneo, nonché le attività di supporto alla ricollocazione professionale. Stante l’attuale situazione di grave ritardo nel funzionamento dei servizi pubblici per l’ impiego, la esclusività dell’ oggetto sociale di tali imprese comporta nei fatti una limitazione alle attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro già in concreto gestite con grande efficienza, per il solo lavoro temporaneo, dalle imprese di fornitura.
Al fine di favorire l’incontro di domanda e offerta di lavoro nonché di aprire il mercato della mediazione privata alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, occorre superare l’attuale divieto posto dalla norma citata, prevedendo espressamente che esse possano, in presenza dei requisiti stabiliti dall’art. 10 del d. lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, modificato dall’art. 117, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), svolgere anche le attività di mediazione nonché di ricerca, selezione e di supporto alla ricollocazione professionale. Poiché l’art. 10 appena citato prevede tuttavia l’ esclusività dell’ oggetto sociale anche per le imprese che attualmente svolgono mediazione, ricerca e selezione o supporto alla ricollocazione professionale, anche tale disposizione deve essere rivista nell’ ambito di un disegno riformatore che riconduca ad un unico sistema autorizzatorio l’intervento dei privati nella mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Una riforma in tal senso equiparerebbe la disciplina italiana a quella già vigente in Germania, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi.
Appare altresì opportuno provvedere ad un coordinamento tra la disciplina del lavoro temporaneo e quella sui contratti a termine. E’, infatti, necessario estendere alcune forme di flessibilità recentemente introdotte affinché il lavoro temporaneo tramite agenzia non risulti ingiustificatamente penalizzato da questo jus superveniens. Si tratta di introdurre nella normativa sul lavoro temporaneo due principi, quello relativo alla causale generale di apposizione del termine e quello che rinvia alla contrattazione collettiva per la definizione dei limiti quantitativi di utilizzo del lavoro temporaneo, pur con l’esenzione da tali limiti in alcuni casi specificamente individuati.
Il Governo italiano valuta infine con preoccupazione la conclusione infruttuosa del dialogo sociale a livello comunitario, a lungo coltivato in vista di un’intesa sul lavoro temporaneo mediante agenzia. Pur nel rispetto delle iniziative che ora la Commissione europea vorrà intraprendere, il Governo segnala la necessità che la futura disciplina comunitaria tenga convenientemente in considerazione le peculiarità dei diversi sistemi nazionali, pur non rinunciando ad affermare il fondamentale principio della parità di trattamento già peraltro sancito dalla legislazione italiana.
Il Governo ritiene che il lavoro temporaneo tramite agenzia possa assolvere anche ad un’importante funzione di integrazione sociale a favore di soggetti a rischio di esclusione. Una prima utilizzazione in tal senso potrebbe riguardare gli adempimenti di legge connessi al collocamento mirato dei disabili, ammettendo che anche l’utilizzazione del lavoro interinale possa soddisfare gli obblighi di legge. Una seconda prospettiva riguarda la regolarizzazione del mercato irregolare dei lavoratori extracomunitari, impegnati in attività di assistenza domiciliare a favore di anziani non autosufficienti. E’, in altri termini, auspicabile che vengano esplorate ancor di più le potenzialità occupazionali di una tipologia contrattuale troppo a lungo avversata che si sta dimostrando di eccezionale efficacia.
La positiva sperimentazione della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo consente ora di ripensare criticamente l’impianto complessivo della legge n. 1369/1960 che vieta la somministrazione di lavoro altrui come disposizione di carattere generale e tendenzialmente onnicomprensiva. Questa normativa, come noto, non solo ha per lungo tempo vietato l’introduzione nel nostro ordinamento del lavoro temporaneo tramite agenzia, ma ha altresì alimentato fenomeni anomali di esternalizzazione del lavoro che incidono pesantemente sia sulla correttezza della competizione fra le imprese sia sulle dimensioni delle aziende stesse che compongono il tessuto produttivo del nostro Paese.
Buona parte dei precetti contenuti nella legge n. 1369/1960 appaiono superati, almeno nella loro persistente perentorietà, dall’evoluzione dei rapporti di produzione e di circolazione della ricchezza al punto da indurre spesso le imprese a “saltarli” completamente: non tanto in ragione di finalità fraudolente o di elusione dei diritti inderogabili del lavoro, quanto soprattutto per l’incompatibilità del dato legale in essa contenuto con le logiche della nuova economia. Le attuali forme di organizzazione del lavoro, soprattutto nel terziario, presuppongono ipotesi di somministrazione di lavoro (si pensi, solo per fare un esempio, alla pratica del c.d. body rental nell’ambito della consulenza informatica) che nulla hanno a che vedere con le ipotesi di speculazione parassitaria sul lavoro a cui si riferiva il legislatore all’inizio degli anni Sessanta.
Le ridigità nell’utilizzo della forza-lavoro introdotte dalla legge n. 1369/1960, del resto, non trovano pari nella legislazione degli altri Paesi e penalizzano la posizione delle aziende italiane nel confronto globalizzato. Pratiche di outsourcing, ampiamente diffuse in altri contesti (ad esempio negli Stati Uniti e in Gran Bretagna), sono in Italia tuttora vietate. Il riferimento è, in particolare, all’istituto del c.d. leasing di manodopera: una tecnica innovativa di gestione del personale imperniata su rapporti con agenzie specializzate nella fornitura a carattere continuativo e a tempo indeterminato (e non a termine, come nel lavoro interinale) di parte della forza-lavoro di cui l’azienda ha bisogno per alimentare il processo produttivo. Agenzie, è bene precisare, che opererebbero in forme sicuramente più trasparenti e con maggiori tutele, di legge e di contratto collettivo, di quanto non accada oggi per effetto di vincoli soffocanti.
Anche rispetto ai processi di esternalizzazione del lavoro il Governo reputa dunque necessario avviare un percorso di riforma complessiva della materia, di modo che le istanze di tutela del lavoro, che devono essere mantenute rispetto a forme di speculazione parassitaria sul lavoro altrui, non pregiudichino la modernizzazione dei meccanismi di funzionamento del mercato del lavoro.
II.3.4. Lavoro intermittente
Il Governo ritiene che sarebbe utile introdurre nel nostro ordinamento una nuova tipologia contrattuale definibile come “lavoro intermittente” (altrimenti detto “a chiamata”), al fine di contrastare tecniche fraudolente o addirittura apertamente contra legem, spesso gestite con il concorso di intermediari e caporali. Forme di lavoro intermittente o a chiamata, consistenti cioè in prestazioni svolte con discontinuità pur nell’ ambito dell’aspettativa datoriale di poter contare sulla disponibilità del prestatore, quindi nell’ ambito dello schema nagoziale del lavoro subordinato, sono assai diffuse naturalmente nel mercato del lavoro nero, ma anche molti lavoratori titolari di partita Iva ovvero inquadrati come parasubordinati costituiscono di fatto altrettante fattispecie di job on call (stand-by workers) di cui brulica soprattutto il terziario. Si tratta di elementi distorsivi della stessa competizione corretta tra imprese che contrastano con un’impostazione volta a modernizzare le regole del nostro mercato del lavoro.
Appare opportuno un intervento legislativo che consenta di inquadrare questo fenomeno non tanto come sottospecie del part time, bensì come ideale sviluppo del lavoro temporaneo tramite agenzia, da inquadrarsi non necessariamente nello schema del lavoro subordinato. La versione più persuasiva è senz’altro quella olandese che imposta appunto il lavoro intermittente o a chiamata” come una forma contrattuale che a fronte della disponibilità del prestatore a rendersi disponibile alla prestazione, prevede la corresponsione a carico del datore di lavoro di una “indennità di disponibilità”, similmente a quanto accade nell’ipotesi di lavoro interinale. Il Governo auspica di ricevere utili commenti a questa proposta.
II.3.5. Lavoro a tempo determinato
Il Governo non può che ribadire la valutazione positiva del negoziato attivato tra le parti sociali il 24 luglio 2000 ai fini della trasposizione della direttiva 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato. Nel merito del provvedimento, la nuova disciplina stabilisce i principi generali ed i requisiti minimi per la stipulazione di contratti a termine, semplificando a razionalizzando il quadro normativo e ponendo la legislazione italiana al livello di quella esistente negli altri paesi europei. Essa, infatti, intende contribuire al miglioramento della qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l’applicazione del principio di non discriminazione e definendo un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dalla utilizzazione di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato.
Sul piano del metodo il Governo sottolinea come si sia proceduto all’integrale recepimento dell’accordo raggiunto fra le parti sociali italiane, pur nel rispetto delle prerogative del Parlamento in cui si è svolto un dibattito che ha consentito di apportare alcuni miglioramenti al testo negoziato. Si tratta quindi di un’esperienza positiva in cui l’ esercizio del dialogo sociale si è saldato con l’ attività legislativa propria del Parlamento e, su delega di questo, del Governo.
Infine, è opportuno sottolineare ancora che, in conformità allo spirito ed alla lettera della direttiva comunitaria, in ogni singolo contratto a termine devono dunque essere indicate le ragioni che, direttamente o indirettamente, consentono l’apposizione di un termine al rapporto di lavoro, nonché i casi nei quali non è invece ammesso il ricorso al contratto a termine. Si tratta di un sistema più semplice ma al tempo stesso più controllabile di quello preesistente, capace di realizzare un allargamento dell’ occupazione di buona qualità, cioè anzitutto regolare, provvedendo ad assicurare al lavoratore tutele non meno efficaci del regime precedente, visto che in caso di contenzioso incomberà pur sempre sul datore di lavoro l’onere della prova della giustificatezza dell’assunzione a termine.
II.3.6. Lavoro a progetto
Le proposte discusse nel corso della passata legislatura con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative suscitano ad avviso del Governo profonde perplessità di metodo e di merito. E’ bene, infatti, non dimenticare che la cosiddetta parasubordinazione appartiene pur sempre all’area del lavoro autonomo e, almeno in certi casi, della auto-imprenditorialità (non si tratta quindi di un tertium genus, ibridamente collocato in una grigia zona di frontiera, intermedia fra lavoro autonomo e subordinato) e come tale deve essere trattata. Del resto le parti sociali si stanno esercitando in una prima fase negoziale che occorre seguire con interesse nel suo sviluppo, senza quindi precostituire in sede legislativa soluzioni che finirebbero per mortificare l’autonomia contrattuale.
Sembra invece utile coltivare un’iniziativa legislativa limitatamente alla identificazione e regolazione di una fattispecie particolarmente diffuse, specialmente ma non esclusivamente nel terziario, comunque riconducibile all’ area dell’ art. 409, n.3, cod.proc.civ., e quindi introdurre una forma contrattuale denominabile “lavoro a progetto”. Il Governo ritiene infatti che sia necessario evitare l’utilizzazione delle “collaborazioni coordinate e continuative” in funzione elusiva o frodatoria della legislazione posta a tutela del lavoro subordinato, ricorrendo a questa tipologia contrattuale al fine di realizzare spazi anomali nella gestione flessibile delle risorse umane. Sarebbero riconducibili a questa tipologia i rapporti in base ai quali il lavoratore assume stabilmente, senza vincolo di subordinazione, l’incarico di eseguire, con lavoro prevalentemente od esclusivamente proprio, un progetto o un programma di lavoro, o una fase di esso, concordando direttamente con il committente le modalità di esecuzione, la durata, i criteri ed i tempi di corresponsione del compenso.
In sintesi, si tratta di conferire riconoscimento giuridico ad una tendenza che si è rivelata visibile con il passare degli anni, soprattutto in ragione della terziarizzazione dell’economia, quella appunto di lavorare e progetto. Si rintracciano sovente caratteristiche di coordinamento e continuità nella prestazione, ma pur sempre in un ambiente di autonomia organizzativa, circostanze che reclamano un’apposita configurazione. Il che non significa affatto propendere per un intervento legislativo “pesante”: al contrario la tipizzazione di questa forma contrattuale è finalizzata ad assicurare il conveniente esercizio dell’autonomia contrattuale delle parti. Ancorché si richieda la forma scritta, il compenso corrisposto dovrà essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni analoghe nel luogo di esecuzione del rapporto, salva la previsione di accordi economici collettivi.
La legge dovrebbe chiarire alcuni diritti fondamentali. Ad esempio, qualora il progetto o programma consista in un impegno orario personale superiore alle 24 ore settimanali, calcolate su una media annuale, il collaboratore dovrebbe aver diritto in ogni caso ad una pausa settimanale, di durata inferiore ad un giorno, nonché ad una pausa annuale, comunque di durata non inferiore a due settimane, secondo modalità concordate fra le parti. Tali pause non dovrebbero comportare alcuna corresponsione di compensi aggiuntivi. Analoghe garanzie dovrebbero essere previste in caso di malattia, gravidanza ed infortunio.
Sarà sufficiente in questa sede precisare ancora che, in omaggio alle caratteristiche fattuali connaturate a questi rapporti, la cessazione non potrà che avvenire al momento della realizzazione del programma o del progetto o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto, salva diversa volontà espressa dalle parti nel contratto scritto.
Il Governo intende, infine, sperimentare una procedura di certificazione al fine di ridurre il contenzioso in materia di rapporti di lavoro, consentendo quindi alle parti di procedere alla stipulazione di contratti a progetto diminuendo grandemente il rischio di contenzioso. La proposta è di delegare per legge il Governo ad emanare una disciplina in materia ispirata ai seguenti criteri e principi direttivi:
- carattere volontario e sperimentale della procedura di certificazione;
- individuazione dell’organo preposto alla certificazione del rapporto di lavoro in enti bilaterali costituiti ad iniziativa delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ovvero nella Direzione provinciale del lavoro;
- definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione;
- indicazione del contenuto e della procedura di certificazione;
- in caso di controversia sulla esatta qualificazione del rapporto di lavoro realizzato, valutazione da parte dell’autorità giudiziaria competente anche del comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione.
Al fine di evitare abusi o comunque utilizzazioni fraudolente di questa figura contrattuale innovativa, converrà stabilire per legge che i contratti di lavoro subordinato non possono essere convertiti in contratti di lavoro a progetto, salvo che le parti esperiscano la procedura di certificazione appena sunteggiata. Il Governo auspica di ricevere, in merito alla presente proposta, approfondimenti, osservazioni e commenti.
II.3.7. Lavoro in cooperativa
La recente riforma della disciplina giuridica del socio di una cooperativa di produzione e lavoro è un modello assai interessante, anzitutto sul piano del metodo. Il legislatore, travolgendo una giurisprudenza di legittimità acriticamente arroccata su posizione formaliste di chiusura, ora ammette che si possa stipulare un contratto di lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato od altre tipologie contrattuali entro cui collocare la prestazione del cooperatore di lavoro. Si supera dunque il principio del numerus clausus a favore di una soluzione aperta che quasi arieggia la tradizione contrattuale anglosassone. Interessante è anche notare la possibilità di derogare ai minimi salariali contrattuali in caso di crisi aziendale o start-up di nuova imprenditorialità. Non solo ma si afferma che in caso di collaborazioni non occasionali (cioè coordinate e continuative) i compensi dovranno essere ragguagliati ai prezzi di mercato, senza interventi della contrattazione collettiva. Si tratta di innovazioni legislative importanti che vanno ben al di là dell’area del lavoro cooperativo.
Il Governo invita le parti sociali ad approfondire queste aperture metodologiche, assai interessanti per realizzare un’opera di complessiva modernizzazione del quadro regolatorio del mercato del lavoro.
II.3.8. Orario di lavoro
In seguito al ricorso proposto alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee l’Italia è stata condannata (assieme alla Francia) per insufficiente adozione delle disposizioni di applicazione della direttiva 93/104/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (Causa C-386/98, Commissione contro Repubblica dell’Italia, sentenza del 9 marzo 2000). La Commissione europea ha avvertito che, non avendo ricevuto alcuna comunicazione delle misure adottate in esecuzione della sentenza della Corte, queste procedure di infrazione continuano in base all’art. 228 del trattato CE. Il Governo intende prontamente porre rimedio a questa persistente inottemperanza degli obblighi comunitari, soprattutto in considerazione del fatto che già il 12 novembre 1997 le parti sociali avevano raggiunto un’intesa che avrebbe dovuto favorire una tempestiva e completa trasposizione.
La mancata trasposizione di questa direttiva europea sta, infatti, dando luogo a non pochi problemi interpretativi (si pensi alla questione della esistenza o meno nel nostro ordinamento di un unico limite settimanale alla durata normale dell’orario di lavoro ovvero di due limiti concorrenti, uno giornaliero e l’altro settimanale). L’implementazione della direttiva consentirebbe in particolare di superare definitivamente alcune interpretazioni, tese a sminuire la riforma dell’orario di lavoro delineata nell’art. 13 della Legge 196/1997, che ancora oggi vorrebbero subordinare la possibilità di modulare l’orario di lavoro su base settimanale, mensile o annuale al vincolo delle otto ore di lavoro giornaliere come orario di lavoro normale.
Occorrerà pertanto procedere rapidamente a completare la trasposizione con riferimento alle disposizioni riguardanti il riposo giornaliero, la pausa giornaliera e le ferie annuali. Il Governo auspica di ricevere tempestivamente eventuali suggerimenti a riguardo, trattandosi di una materia fondamentale per realizzare una politica effettiva di qualità del lavoro per realizzare le pari opportunità.
II.3.9. Igiene e sicurezza
Numerose e importanti direttive comunitarie in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sono state recepite nel nostro ordinamento giuridico, a partire dai primi anni del ‘90.
Tali norme si sono sommate ad un precedente corpo normativo, tuttora vigente, improntato a differenti principi di logica giuridica. Proprio la compresenza di leggi vecchie di decenni con il nuovo impianto comunitario rappresenta la prima e più importante giustificazione della necessità di riordinare e riunificare tutta la materia attraverso la predisposizione di un testo unico.
Quest'ultima non è la sola motivazione che induce alla predisposizione di tale testo. Infatti, la legislazione che ha recepito le numerose direttive europee è stata, per molti versi, complicata e burocratizzata, tanto che nella sua pratica attuazione stenta a portare effettivi benefici concreti al fenomeno infortunistico e delle tecnopatie.
Infatti, nel corso del 2000, secondo dati di una ricerca del CENSIS, commissionata dall'INAIL gli infortuni sono saliti dell'1,2% sfiorando il milione di casi, distribuiti in tutti i settori produttivi e riguardanti sia i lavoratori uomini sia le donne. Anzi per quest'ultime si registra un aumento, rispetto al 1999, di circa 4000 unità (dal 22% al 24% del totale).
Inoltre, sono del tutto assenti, nelle attuali norme, criteri prevenzionistici specifici, anche in chiave promozionale, per le piccole e medie imprese e per il settore dell'agricoltura. Va, poi, notato che la nuova normativa sulla sicurezza è stata interpretata più in chiave repressiva che preventivo consulenziale e, quindi, poco orientata verso la creazione di buone prassi che si traducessero in reale aiuto alle imprese anche sotto il profilo organizzativo e gestionale. Tutto questo ha favorito un altro fenomeno negativo: un aumento del lavoro sommerso, perché gli adempimenti di sicurezza sono tali e tanti che inducono all'elusione ed al lavoro in nero.
Manca sufficiente chiarezza e, quindi, certezza del diritto, in materia di applicazione soggettiva delle norme. Ciò vale, soprattutto, con riferimento alle emergenti e sempre crescenti tipologie di lavoro alternative al modello tradizionale dell'impiego a tempo pieno, a tempo indeterminato e svolto in ambito aziendale. Valga per tutti l'esempio della lacuna costituita dalla mancata regolamentazione delle norme a tutela dei telelavoristi e dei collaboratori continuatitivi coordinati.
Va, poi, conferita maggiore chiarezza alla carente regolamentazione in materia di obblighi contravvenzionali delle macchine, di rinvio a norme tecniche e di libera circolazione delle macchine certificate CE.
Infine, va rimodulato il rapporto tra sanzioni contravvenzionali e amministrative e vanno riesaminate le fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti erroneamente equiparate, quanto ad ampiezza delle fattispecie, a quelle a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti.
Pertanto, si rende opportuno ed urgente il varo di un Testo Unico i cui principi e criteri direttivi siano i seguenti:
- riordino e coordinamento in un unico Testo di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia e tenendo conto degli indirizzi già espressi attraverso atti amministrativi dalle competenti istituzioni pubbliche;
- semplificazione di disposizioni che dalle esperienze fin qui maturate si siano dimostrate praticamente inapplicabili, in relazione alla realtà lavorativa nazionale o comunque abbiano rivelato la loro natura di mera burocraticità;
- individuazione di criteri prevenzionistici specifici, anche in chiave promozionale e di buone prassi, per le piccole e medie imprese e per il settore dell'agricoltura;
- delegificazione e riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione;
- riordino dell'apparato sanzionatorio, anche in omaggio al principio del management by objectives, con precipuo riferimento alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti e alla rimodulazione delle sanzioni amministrative accanto a quelle penali contravvenzionali;
- studio di meccanismi contributivi propriamente basati sul principio dell’experience-rating (con contribuzioni più alte per l’impresa in cui in passato si siano avuti più incidenti, o indennizzi in parte a carico dell’impresa quando l’incidente avvenga nei primissimi giorni di lavoro dell’individuo, caso che potrebbe celare o una certa negligenza nell’addestramento o, molto spesso, fenomeni di lavoro sommerso, denunciato solo contestualmente all’avvenuto incidente);
- integrazione dei sistemi informativi a fini di vigilanza e attuazione di pratiche preventive
II.4. Pari opportunità e inclusione sociale
II.4.1. Politiche di parità
Una corretta politica delle pari opportunità deve innanzitutto basarsi su interventi diretti ad abolire ogni pratica discriminatoria e quindi qualsiasi tipo di differenziale retributivo, a parità di lavoro svolto. Al tempo stesso, però, la presenza femminile nel mondo del lavoro deve essere promossa a tutti i livelli e resa possibile operando con gli strumenti propri di un’economia di mercato.
Una politica delle pari opportunità deve basarsi sugli incentivi fiscali, sulle politiche attive, sulla flessibilità dei contratti atipici (part-time), nonché sulle politiche sociali di sostegno alle donne sposate che lavorano, per dare loro la possibilità di meglio conciliare l’attività lavorativa con gli impegni familiari. Una politica di pari opportunità, nel contesto del nostro paese, non va rafforzata solo per ragioni di equità sociale, ma per motivi di efficienza del nostro mercato del lavoro. In diverse parti del Paese si è raggiunta praticamente la piena occupazione, nel senso che la disoccupazione è scesa a livelli fisiologici, eppure non si sono raggiunti ancora livelli dei tassi di occupazione paragonabili a quelli dei nostri partners europei. Se ne deduce che per raggiungere quell’obiettivo di occupazione occorre far leva sugli strumenti che possano incentivare una maggiore offerta di lavoro, in particolare quella delle donne e degli anziani.
Modernizzare le tecniche regolatorie del mercato del lavoro significa anche ripensare tutto l’attuale quadro istituzionale in un’ottica di promozione delle pari opportunità. Del resto un Paese caratterizzato da un gender gap superiore al 30%, inferiore soltanto a quello di Grecia e Spagna, non può che ammettere l’insuccesso delle politiche finora adottate in proposito e che ci hanno meritato una severa ‘raccomandazione’ da parte dell’ Unione Europea. Giustamente viene infatti rilevato che nel nostro ordinamento manca un approccio basato sull’integrazione di genere nell’attuazione delle ‘linee guida’ sull’occupazione. Tutti gli strumenti richiamati nel presente Libro Bianco devono essere ritenuti utili a concepire in modo più moderno le pari opportunità, affrontando anzitutto il problema della discriminazione tra donne e uomini. Le politiche in materia di interruzione della carriera, di congedo parentale, di lavoro part-time e di formule di lavoro flessibili rivestono particolare interesse a riguardo. Occorre altresì fornire sufficienti strutture di buona qualità per la custodia dei bambini e l’assistenza alle persone a carico non autosufficienti, al fine di favorire l’ingresso e la permanenza delle donne sul mercato del lavoro. E’ essenziale a questo proposito un’equa ripartizione delle responsabilità familiari. In particolare occorre agevolare il reinserimento delle donne sul mercato del lavoro dopo un periodo di assenza.
Le politiche per l’occupabilità, l’imprenditorialità e l’adattabilità devono pertanto essere ripensate complessivamente anche nella prospettiva di rafforzare realmente le opportunità di lavoro e di carriera dei gruppi discriminati e a rischio di esclusione sociale, con ciò contribuendo anche a rafforzare le politiche volte a innalzare gli attuali tassi di occupazione. Parallelamente il Governo si impegnerà a rimuovere tutti quei fattori esterni al lavoro che influenzano negativamente la decisione delle donne di iniziare una attività lavorativa. L’occupazione e un lavoro di qualità devono diventare gli elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuire concretamente all’attuazione del dettato costituzionale che riconosce la piena partecipazione di tutti i lavoratori, anche e soprattutto di quelli a rischio di esclusione e segregazione, la piena partecipazione alla vita economica, culturale e sociale del Paese e una soddisfacente realizzazione personale.
Particolare importanza assume, in questa prospettiva, anche il processo di trasposizione nel nostro ordinamento della Direttiva n. 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che “stabilisce un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o sulle convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro”, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. La direttiva in questione sollecita, infatti, ad incoraggiare anche su questo versante, in conformità e nel rispetto delle tradizioni e prassi nazionali, il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, tra l’altro attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, la stipulazione di contratti collettivi, l’adozione di codici di comportamento nella logica della legislazione promozionale e soft, nonché ricerche e scambi di esperienze e di buone pratiche. Del pari ogni Stato membro è invitato, nel rispetto delle tradizioni e prassi nazionali, a incoraggiare le parti sociali a concludere al livello appropriato, e lasciando impregiudicata la loro autonomia, accordi che fissino regole antidiscriminatorie con riferimento alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente sia autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione e alle prospettive di carriera.
La Direttiva n. 2000/78/CE è davvero innovativa in questa materia anche perché aiuta a comprendere il significato del concetto di «azione positiva» con riferimento alle pari opportunità e alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro: tema su cui si è aperta una polemica, talvolta molto accesa, incentrata sulle azioni positive a favore dei lavoratori extracomunitari e dei lavoratori over quaranta, previste nel già ricordato Patto sul lavoro di Milano. Secondo la direttiva (art. 7.1), infatti, allo scopo di assicurare completa parità nella vita professionale, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche, e quindi differenziate, dirette a evitare o compensare svantaggi correlati all’appartenenza a uno dei gruppi a rischio di esclusione sociale. Si tratta di una formula che coglie esattamente le tecniche promozionali in corso di sperimentazione nell’intesa milanese.
La prospettiva delle pari opportunità richiede, in definitiva, l’adozione di politiche più efficaci, volte a incidere sul contesto culturale, da un lato, e sulle convenienze dei soggetti coinvolti, dall’altro lato, abbandonando definitivamente una logica meramente repressivo-sanzionatoria come quella delle quote obbligatorie, previste ancora oggi dalla nostra legislazione, logica in definitiva controproducente nei confronti degli stessi soggetti che pur vorrebbero garantire nei loro diritti fondamentali. Da questo punto di vista, in particolare, per assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento con riferimento ai disabili, devono essere previste soluzioni ragionevoli e adeguati incentivi economici. Ciò significa, come ancora chiarisce la Direttiva n. 2000/78/CE, che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte dello stesso datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato.L’onere finanziario non è considerato sproporzionato allorché sia compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili.
Il Governo si impegnerà a rimuovere tutti quei fattori esterni al lavoro che influenzano negativamente la decisione delle donne di iniziare una attività lavorativa. Particolare attenzione verrà in proposito prestata al trattamento fiscale dei redditi da lavoro, in modo da non disincentivare il lavoro femminile anche quando aggiuntivo all’interno di un dato nucleo familiare, ed alla disponibilità di servizi di cura a beneficio delle famiglie. Spazi concreti d’ulteriore crescita dell’occupazione femminile potranno poi venire dalle forme contrattuali flessibili, in particolare dal part time. E’ però altrettanto importante che anche le parti, ed in primo luogo le imprese, adeguino le proprie politiche del personale alla crescente presenza femminile nel mercato del lavoro, imparando a gestire e valorizzare un segmento di forza lavoro comunque caratterizzato da una più discontinua presenza sul mercato del lavoro. Da tale valorizzazione, che il Governo intende promuovere e favorire, potrà discendere un ulteriore stimolo all’offerta di lavoro femminile
II.4.2. Lavoro minorile
Il lavoro illegale dei minori in Italia presenta caratteri preoccupanti non solo o non tanto per la sua dimensione globale quanto per la concentrazione in specifici ambiti sociali, territoriali e merceologici.
Il Ministero del Lavoro ha conferito all’Istituto Nazionale di Statistica, in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, l’incarico di effettuare una ricerca sul fenomeno con lo scopo di produrre un sistema informativo sul lavoro minorile in Italia. Tale sistema costituisce la premessa indispensabile per orientare le azioni di prevenzione e contrasto e per verificare periodicamente la loro efficacia in termini quantitativi.
Il Governo propone alle parti sociali una lettura congiunta dei primi risultati prodotti allo scopo di focalizzare gli ulteriori campi di indagine, con particolare riguardo alle situazioni che costituiscono immanente pericolo per l’incolumità fisica o psichica dei minori secondo la definizione della recente Convenzione ILO dedicata alle “forme peggiori” di sfruttamento.
Il contrasto dello sfruttamento dei minori nel lavoro costituisce ovvia priorità nel più generale programma di progressiva riduzione dell’economia sommersa in Italia ma anche impegno internazionale, a partire dai processi di delocalizzazione, fornitura e sub-fornitura cui sono interessate le imprese italiane. A questo proposito il Governo intende invitare le parti sociali ad una rinnovata fase negoziale per la produzione di codici di condotta condivisi e dei relativi sistemi di controllo e divulgazione.
Il complesso delle azioni previste dalla “carta di impegni per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed eliminare il lavoro minorile” sottoscritta dalle parti sociali con il Governo, dovrà essere oggetto di una rivisitazione congiunta allo scopo di procedere finalmente a fatti operativi, di ordine generale e più specificamente rivolti alle aree ove il fenomeno è particolarmente concentrato.
II.4.3. Immigrazione
Il Governo considera con favore l’ iniziativa della Commissione europea di indirizzare al Consiglio ed al Parlamento Europeo una Comunicazione intitolata An open method of coordination for the Community Immigration Policy (11 luglio 2001, COM(2001) 387 final) e ne condivide sia l’ ispirazione sia le proposte operative. In essa si propone sostanzialmente di ricorrere alla metodologia del “coordinamento aperto” applicandola alle tematiche immigratorie, anziché ricorrere ai tradizionali strumenti regolatori del diritto comunitario quali i regolamenti e le direttive.
In particolare della proposta della Commissione può essere condivisa l’idea di una “linea guida” volta a “rinforzare la lotta contro l’immigrazione illegale”, con particolare riguardo ai cd. “immigrati economici”. A tal proposito la Commissione osserva giustamente che numerosi Stati membri stanno ora attivamente reclutando immigrati economici, compresi lavoratori ad alta professionalità, come per esempio ricercatori e specialisti di estrazione accademica. Nel contesto di un invecchiamento e diminuzione della popolazione su scala continentale europea, si ritiene necessaria la revisione dell’ uso dei canali legali per l’ammissione dei cittadini provenienti da Paesi terzi per cogliere le necessità del mercato del lavoro, prestando attenzione al tempo stesso ai rischi che il fenomeno cd. di brain drain può comportare per i Paesi d’ origine. In particolare va condivisa l’affermazione della Commissione secondo cui la necessità di una politica di maggiore apertura nei confronti dell’immigrazione extracomunitaria deve essere accompagnata da misure aggiuntive per eliminare il lavoro non dichiarato che è esso stesso causa o comunque sostegno dell’ immigrazione illegale.
Negli anni novanta l’Italia ha subito i flussi migratori che si sono determinati in larga parte a prescindere dalla domanda di lavoro e che si sono diretti a coprire i lavori di cattiva qualità, alimentando il fenomeno del sommerso e del lavoro clandestino. Pure escludendo che tale afflusso di manodopera abbia prodotto una rilevante frizione diretta sugli stessi posti di lavoro tra lavoratori nazionali e lavoratori immigrati, poiché ha interessato prevalentemente impieghi rifiutati dai lavoratori nazionali, tuttavia essa ha prodotto una frizione di carattere indiretto non meno pericolosa. Infatti, come afferma una ricerca commissionata dall’ILO, alimentando l’economia sommersa, i flussi in entrata hanno contribuito alla mancata modernizzazione dell’economia italiana, con ciò rallentando la domanda di posti di lavoro più adatti ai lavoratori nazionali.
D’altra parte, la legge Turco-Napolitano non ha orientato i comportamenti dei datori di lavoro perché si è rivelata di faticosa attuazione producendo una programmazione di flussi che trovava il suo compimento nella metà dell’anno di riferimento e non anticipatamente. Ne è conseguito che il risultato più immediato è stato una sanatoria a posteriori dei lavoratori che erano già presenti sul territorio nazionale in modo irregolare.
La scelta del Governo è, invece, quella di avvicinare la domanda e l’offerta di lavoro. Questo obiettivo è conseguibile, da un lato, intervenendo sui Paesi di origine dei flussi migratori e agendo in stretta collaborazione soprattutto con i paesi con i quali esistono accordi di cooperazione su questa materia, al fine di creare mercati del lavoro interregionali, trasparenti e governabili. In tale ambito, è opportuno favorire azioni di formazione e screening preventivo nei paesi di origine, supportando l’azione degli operatori privati e delle associazioni di categoria.
Dall’altro, occorre pianificare in maniera più efficiente e tempestiva i flussi migratori, in modo tale da orientare i comportamenti degli operatori e discutendo tale programmazione con le parti sociali, soprattutto con le associazioni dei datori di lavoro, per gli aspetti di domanda di lavoro, e con le Regioni e gli enti locali per comprendere anche i problemi di una compiuta integrazione nel territorio.
In questa direzione, anticipando anche i contenuti di altre misure in corso di elaborazione da parte della stessa Commissione europea, il Governo ha predisposto un disegno di legge che prevede modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recente il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e al decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 39. In questo provvedimento occorre segnalare l’introduzione del “contratto di soggiorno per lavoro” che potrà essere sottoscritto in relazione ad un lavoro stagionale con durata non superiore a nove mesi, ad un lavoro subordinato a tempo determinato con durata pari a quella del contratto e comunque non superiore ad un anno, ad un lavoro subordinato a tempo indeterminato con durata non superiore a due anni. Il testo chiarisce che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e, comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non superiore a sei mesi.
Il Governo ritiene del tutto prioritario assicurare ai lavoratori extracomunitari, già iscritti nelle liste dei servizi pubblici per l’impiego ed ancora in cerca di un’occupazione un adeguato sbocco nel mercato del lavoro. Solo un mercato del lavoro efficiente e trasparente può garantire ai lavoratori nazionali e agli immigrati già legalmente residenti quella naturale priorità che ad essi va riconosciuta.
Come già accennato, le intese fra le parti sociali, anche a livello locale, potranno sperimentare utilmente altre forme di regolarizzazione delle attività svolte da cittadini extracomunitari in Italia, inserendoli pienamente nel circuito del mercato del lavoro regolare. Inoltre, appare opportuno incentivare anche forme di lavoro autonomo tra gli immigrati, al fine di favorire il permanere di quei mestieri che appaiono oggi abbandonati dai lavoratori italiani, nonché per garantire una maggiore inclusione sociale.
III. Relazioni Industriali
III.1. Sistema contrattuale
La centralizzazione della contrattazione collettiva garantita dagli Accordi del 1992 e del 1993 anche se contribuisce a regolare la coerenza macroeconomica, tuttavia ostacola gli aggiustamenti relativi dei salari, ciò che aiuterebbe il processo di riduzione della disoccupazione.
Se si vuole optare per un maggior decentramento della struttura contrattuale (e per una trasformazione del livello nazionale in una sorta di minimum wage, fornitore di una protezione minima) appare necessario intervenire sugli assetti della contrattazione.
Il CCNL potrebbe sempre più assumere il ruolo di “accordo quadro” capace di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni minime, di fissare standard minimi comuni, di assicurare un clima di fiducia reciproca nel sistema di relazioni industriali. Tale funzione di “accordo quadro” potrebbe essere rafforzata ipotizzandone un periodo di validità diversa dall’attuale, in coerenza con i documenti programmatici del Governo che fissano le grandezze economiche ed eliminando, eventualmente, il momento contrattuale intermedio.
Rafforzare la contrattazione decentrata può rendere più flessibile la struttura della retribuzione. Questo livello di contrattazione non dovrebbe produrre un effetto di sommatoria sulla dinamica complessiva delle retribuzioni e quindi generare aspettative inflazionistiche. A questo fine occorrerebbe che la contrattazione decentrata, pure non prevedendo trattamenti inferiori ai minimi previsti dal CCNL, fosse concepita in senso non sovrapponibile allo stesso CCNL.
Una rivisitazione dell’attuale modello dovrebbe rendere effettivo un principio già presente nel Protocollo 23 luglio 1993, cioè l’affermazione del criterio generale di coerenza complessiva del sistema, volto a far sì che la crescita retributiva e le dinamiche inflattive risultino coerenti non rispetto ad un solo livello di contrattazione (la sede categoriale), bensì considerando l’insieme delle voci di costo collettivamente determinate, quale che sia la sede in cui sono trattate.
Il Governo si rivolge alle parti sociali per prospettare loro l’opportunità di rivisitare l’attuale assetto contrattuale, al fine di dotarlo di una maggiore flessibilità. Ciò che risulterebbe utile, oltre che per redistribuire produttività, anche per facilitare la riemersione del “sommerso” e per superare temporanee crisi occupazionali, in particolare nelle piccole e medie imprese o in determinate aree territoriali. Il Governo desidera ricordare ancora alle parti sociali che una flessibilizzazione ed un riassetto dell’organizzazione contrattuale si giustifica anche in considerazione del venir meno della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi differenziati per il Sud.
Va peraltro precisato che la riorganizzazione della struttura contrattuale riguarda l’intero complesso del lavoro dipendente, compreso quello del settore pubblico. Da tempo è in corso un processo di “privatizzazione” del rapporto di lavoro in questo settore ed è intenzione del Governo proseguire con determinazione verso una maggiore omogeneità non solo delle norme ma anche delle relazioni sindacali e dei comportamenti effettivi nei due settori, pubblico e privato.
La tendenza verso un maggior decentramento delle relazioni industriali è, negli ultimissimi anni, emersa in connessione con il decentramento nelle amministrazioni pubbliche.
Il rafforzamento del livello decentrato della contrattazione collettiva non potrà quindi non coinvolgere anche il settore pubblico. Le Regioni e gli enti locali potranno svolgere un’azione di stimolo e di proposta su questo in parallelo alla compiuta definizione di un contesto più responsabile della finanza regionale e locale.
Il Governo è pienamente consapevole che tale materia è affidata anzitutto al confronto tra le parti sociali e confida pertanto che questo produca risultati coerenti con le complessive esigenze di modernizzazione del mercato del lavoro. Al tempo stesso il Governo dichiara la propria intenzione di non volere assumere iniziative legislative in materia di rappresentatività degli attori negoziali, nel pieno rispetto della tradizione autoregolamentare delle parti sociali italiane ed in ossequio al principio di reciproco riconoscimento, consolidatosi ormai anche in sede comunitaria.
III.2. Partecipazione
Si può senz’altro riconoscere che gli assetti regolativi dei sistemi di relazioni industriali in Europa si siano crescentemente caratterizzati, nel corso dell’ ultimo decennio, in termini sempre più collaborativi e partecipativi ed un ruolo di rilievo è stato assunto dalle misure adottate a livello comunitario. Già nel corso degli anni ’80 l’adattamento alle sfide della globalizzazione e dell’internazionalizzazione dei mercati aveva registrato rilevanti successi soprattutto in quei Paesi che per tradizione disponevano di un quadro istituzionale decisamente partecipativo e collaborativo (Paesi scandinavi, Paesi Bassi, Austria e Germania). Nel corso del decennio successivo questo modello regolatorio ha continuato ad estendersi ad di là di ogni previsione anche ad altri Paesi, con la sola esclusione di Francia e Regno Unito, soprattutto grazie all’adozione di politiche concertative a livello macro-economico e la stipulazione di patti sociali a livello nazionale, comunque in ragione dell’emersione generalizzata di risposte di tipo partecipativo nella soluzione delle tensioni provocate dalle crisi di sviluppo delle economie europee.
Come chiaramente indicato da primo Rapporto della Commissione europea sulle relazioni industriali, in tutta Europa i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori risultano oggi più partecipativi anche solo di un decennio fa e in ogni caso molto meno conflittuali rispetto al passato, visto che il numero di scioperi si è drasticamente ridotto. La ricerca di soluzioni partecipative è comunque delineata ora dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata nel dicembre 2000 a Nizza che all’ art. 27 sancisce il diritto dei lavoratori all’ informazione e alla consultazione nell’ ambito della impresa (“Ai lavoratori ed ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l’informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali”).
Il Governo italiano condivide l’ispirazione della politica comunitaria in tema di relazioni industriali e saluta con favore questa evoluzione così caratterizzante del modello sociale europeo, auspicando che anche in Italia i rapporti tra le parti sociali si sviluppino in senso sempre più partecipativo. Pur nel massimo rispetto di un tema che, al pari di quello relativo agli assetti contrattuali, è di primaria responsabilità e competenza delle parti sociali, è opportuno creare le condizioni favorevoli allo sviluppo di intese partecipative fra le stesse, nella convinzione che ciò possa contribuire ad accrescere la competitività del nostro sistema economico. La partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nel quadro di un sistema di relazioni industriali, tanto a livello macroeconomico quanto su scala micro, contribuisce ad elevare la qualità del lavoro, accrescendo le potenzialità di sviluppo professionale e di carriera dei dipendenti, incidendo positivamente sulla loro motivazione, nella ricerca di un ambiente lavorativo fondato sul riconoscimento delle capacità personali e sulla valorizzazione delle aspettative individuali e collettive.
L’esperienza comparata insegna che i sistemi di relazioni industriali più partecipativi riescono a conferire maggiore competitività al sistema produttivo, pure nella grande varietà dei modelli adottati, sia che la legge assuma un ruolo centrale (Germania), sia che la partecipazione si fondi sulla prassi e la consuetudine senza alcuna interferenza di carattere regolatorio (Giappone). Si ottengono risultati incoraggianti sul piano del miglioramento dell’efficienza organizzativa, riducendo le resistenze alle innovazioni tecnologiche, supportando le decisioni manageriali con una maggiore legittimazione e coinvolgendo i rappresentanti dei lavoratori in una logica di confronto che non esclude certo la possibilità di ricorrere al conflitto ma privilegia la ricerca di soluzioni condivise in quanto hanno più facilità di essere implementate con successo. La partecipazione è dunque un elemento costitutivo di un sistema di relazioni industriali basato sulla qualità, contribuendo positivamente a sostenere e qualificare lo sviluppo di un sistema economico nel suo insieme e delle singole imprese.
Dopo il successo della direttiva comunitaria sui Comitati Aziendali Europei (CAE), con l’affermazione di un ruolo premiale della contrattazione collettiva in funzione partecipativa, incentivata al punto da poter derogare interamente rispetto a disposizioni minime di legge, sta per concludersi il pluridecennale processo decisionale che porterà entro breve tempo alla normativa comunitaria sulla costituzione della Società Europea (SE). Dopo l’accordo di Nizza, il Consiglio ha approvato un testo che è attualmente in lettura al Parlamento europeo. Appare pertanto opportuno, alla vigilia dell’approvazione definitiva di questo provvedimento, così a lungo atteso, che il Governo sottolinei l’importanza di una riflessione sui temi della partecipazione, in vista di un’impegnativa fase di trasposizione che dovrà avvenire nell’arco di questa legislatura.
La disciplina giuridica della Società Europea, sia nel regolamento sia nella direttiva, si fonda sul riconoscimento del carattere fisiologico della partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Non sono mancate, in passato, direttive comunitarie che hanno affermato diritti di informazione e consultazione in presenza di situazioni di crisi aziendali (licenziamenti collettivi, trasferimento di azienda) dando luogo ad atti di recepimento che anche nell’ordinamento giuridico italiano hanno fondato diritti di informazione e consultazione. Tuttavia è con la direttiva CAE, peraltro limitata alle relazioni industriali che caratterizzano le imprese di dimensione trasnazionale, che si è affermata una tendenza regolatoria a promuovere la partecipazione anche in cicli economici favorevoli nella vita delle imprese, quindi non soltanto su base eccezionale ma anche in una prospettiva permanente. La direttiva sulla SE prosegue in questa direzione, anche se la parte riguardante la partecipazione potrà (in omaggio al compromesso politico che ha consentito a Nizza di superare le ultime resistenze della Spagna) essere oggetto di opting out da parte dei singoli Stati membri ai quali sarà quindi consentito non procedere alla trasposizione di questa parte delle disposizioni comunitarie.
Il Governo italiano invita fin d’ora le parti sociali ad avviare un confronto sui modi di trasposizione della direttiva, anche per quanto riguarda le disposizioni riguardanti il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti. E’ di grande interesse infatti che la direttiva stessa, riprendendo il modello CAE, affermi che il regime di partecipazione della SE dovrebbe essere definito a seguito di un’intesa da stipularsi ad opera delle parti interessate o, in mancanza di essa, con l’ applicazione delle norme accessorie che ogni Stato membro dovrà darsi nell’adempimento dell’obbligo traspositivo.
Può essere senz’ altro condivisa la tecnica, sempre mutuata dal modello CAE, che consente alle parti sociali di regolare interamente la materia partecipatoria nella singola SE prescrivendo tuttavia che l’accordo regolamenti obbligatoriamente un certo numero di materie (ad es. il campo di applicazione del medesimo accordo, le attribuzioni e la procedura prevista per l’ informazione e la consultazione dell’organismo di rappresentanza, le risorse finanziarie e materiali da attribuire all’organo di rappresentanza, ecc.). Si tatta di un modello che il Governo ritiene debba essere attentamente seguito nell’opera traspositoria, ed in tal senso confida che anche le parti sociali lo apprezzino ugualmente sperimentandolo nel loro dialogo.
L’Unione Europea non impone al nostro sistema di relazioni industriali alcun modello predeterminato, ma crea le condizioni di quadro istituzionale affinché le parti sociali trovino intese per esercitare i diritti di informazione e consultazione negoziando intese ovvero, in difetto di queste, utilizzando una disciplina di base che dovrà essere realizzata in sede traspositiva. E’ questo il senso di un’altra direttiva che sta per essere approvata (anche in questo caso è stato raggiunto in Consiglio l’ accordo politico e si attende la lettura del Parlamento europeo), quella che riguarda l’ esercizio dei diritti di informazione e consultazione nelle imprese nazionali. Essa intende valorizzare il principio secondo cui l’informazione e la consultazione in tempo utile può rappresentare una condizione preliminare ed imprescindibile per il buon esito di processi di ristrutturazione e di adattamento delle imprese alle nuove condizioni indotte dalla globalizzazione dell’ economia, in particolare mediante lo sviluppo di nuove procedure di organizzazione del lavoro. Attualmente, come già accennato, il quadro giuridico in materia di informazione e consultazione è orientato, tanto a livello comunitario quanto su scala nazionale, soprattutto in funzione del trattamento ex post dei processi di cambiamento.
In vista di questi prossimi appuntamenti traspositivi il Governo sollecita le parti sociali ad una riflessione che consenta di migliorare la qualità delle nostre relazioni industriali rendendole maggiormente partecipative, secondo formule liberamente concordate ed in relazione alle quali l’intervento legislativo dovrà limitarsi a garantire la funzione premiale della contrattazione collettiva unitamente all’esigibilità di condizione minime di esercizio dei diritti di informazione e consultazione. In particolare il Governo ritiene auspicabile che il dialogo sociale individui le sedi e le altre modalità per regolare convenientemente i diritti di informazione e consultazione, affinché l’esercizio delle prerogative manageriali sia ispirato da una logica di trasparenza e di fiducia tra le parti.
III.3. Democrazia economica
Sul tema della partecipazione finanziaria dei lavoratori la Commissione europea ha recentemente avviato una nuova iniziativa sottoponendo agli Stati membri un documento di riflessioni al quale anche il Governo italiano risponderà (Financial participation of employees in the European Union, 27 luglio 2001, SEC(2001) 1308). Si tratta, infatti, di una prospettiva della tematica partecipativa che deve essere tenuta in considerazione ed a proposito della quale è necessario svolgere una attività di stimolo, in quanto anche nel nostro Paese è riscontrabile quello che nel documento comunitario appena richiamato viene definito “problema culturale” ovvero di “deficit culturale”, nel senso che i dipendenti ed i loro rappresentanti si sentono estranei ad una prassi di coinvolgimento di tipo finanziario nell’impresa in cui sono occupati.
Lo stesso legislatore del resto ha recentemente contribuito a rilanciare l’idea di un più esteso ricorso all’azionariato dei dipendenti. Il nuovo testo dell’art. 48, 2à comma, del Testo Unico Imposte sui redditi, come modificato dall’art. 3, 1° comma, del d. lgs. 314/1997, ha introdotto una disciplina di particolare favore sotto il profilo fiscale per le società che emettono nuove azioni a favore dei propri dipendenti. Successivamente, attraverso l’esercizio della delega sulla riforma dei mercati finanziari e delle società quotate (d.lgs. 58/1998) è stata confermata questa opzione di favore verso l’ accesso dei dipendenti al capitale azionario, introducendo una disciplina di sostegno per le società aventi azioni quotate, al fine di favorire i cd. piani di stock options e cioè l’ attribuzione del diritto a sottoscrivere azioni da parte dei lavoratori.
E’ sin qui mancata tuttavia una disciplina organica che, sulla scorta di quanto da tempo sollecitato in sede comunitaria, conducesse ad una regolamentazione di sostegno in grado di sciogliere i nodi principali di una materia tanto controversa quanto complessa. Non può quindi sorprendere che nel nostro Paese lo sviluppo dell’azionariato dei dipendenti si sia fin qui manifestato in modo frammentario e lacunoso (soprattutto a margine di singoli processi di privatizzazione di aziende pubbliche), privo com’ è di una moderna base normativa di supporto e incentivazione comparabile con quella presente in numerosi altri ordinamenti. Le sfide della new economy, della società dell’informazione e delle nuove tecnologie impongono ora di esplorare con più determinazione anche questa strada per una modernizzazione delle nostre relazioni industriali.
Si possono in materia proporre alcuni spunti utili per aprire una riflessione ed un confronto. Importanti esperienze di altri paesi dell’Unione Europea (Regno Unito, Francia, Germania, Belgio ed Irlanda) dimostrano l’utilità di subordinare ad esempio la concessione delle agevolazioni fiscali alla condizione che per le azioni oggetto del piano di partecipazione finanziaria sia prevista, con apposita deliberazione dell’assemblea ordinaria, la loro inalienabilità per un certo numero di anni successivamente alla effettiva cessione. Previa intesa con le rappresentanze dei lavoratori i piani di partecipazione finanziaria potrebbero eventualmente prevedere un periodo maggiore di inalienabilità delle azioni. Un intervento anche di natura legislativa potrebbe precisare, valorizzando in proposito il ruolo della contrattazione collettiva, le modalità di sottoscrizione o acquisto di azioni nell’ambito di un piano di partecipazione finanziaria, prevedendo anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, l’impiego di quote o elementi della retribuzione, il ricorso al credito eventualmente attraverso l’intervento dei fondi pensione in deroga a quanto disposto dal d. lgs. 124/1993.
E’ vero tuttavia che, in una prospettiva de jure condendo, la vera questione da affrontare è quella dell’alternativa tra azionariato collettivo e azionariato individuale: sembra questo il nodo politico più difficile da sciogliere per quanto attiene alla partecipazione finanziaria dei lavoratori a livello di impresa.
Potrebbe essere utile un intervento legislativo che aprisse ulteriori possibilità di azione al confronto tra le parti sociali, anche per facilitare i processi di privatizzazione, rafforzando la posizione dei dipendenti azionisti e rendendo più equilibrato il rapporto assunzione del rischio-potere di controllo insito nella adesione ad un piano di partecipazione azionaria.
Il tema della partecipazione azionaria si lega evidentemente con quello dell’utilizzazione del trattamento di fine rapporto (TFR) per la costituzione dei fondi pensione, salvaguardando ben s’intende il principio di assoluta volontarietà. Tuttavia, occorre aver sempre a mente la necessaria sperimentazione che soluzioni di questa natura devono avere, nonché l’inevitabile differenziazione della relativa disciplina. E’ la contrattazione aziendale a potere produrre le applicazioni sperimentali più utili ed è pertanto in questa sede che converrebbe, anzitutto, avviare un confronto costruttivo.
Il Governo ritiene utile verificare modalità di partecipazione finanziaria finalizzate ad esaltare la fidelizzazione di figure apicali o comunque chiave nell’ambito dell’organizzazione del lavoro di piccole e piccolissime imprese, inclusi esercizi turistico-commerciali ed unità artigiane. A tal fine è necessario ristabilire un uso corretto del contratto di associazione in partecipazione, ovvero ricorrere ad altre forme di partecipazione agli utili, sostenendo questi strumenti anche con opportuni incentivi di carattere economico e fiscale.
III.4. Servizi pubblici essenziali e conflittualità
Il Governo ritiene che non si possa certo ignorare la situazione, spesso caratterizzata da comportamenti irrispettosi delle esigenze degli utenti e dei consumatori, del conflitto nei servizi essenziali, con particolare riferimento al settore dei trasporti. Le modifiche introdotte nel 2000 alla legge che regola l’esercizio del diritto di sciopero in questo contesto non sembrano essere state adeguatamente valorizzate dalle parti sociali interessate ed è a questo proposito opportuno che la Commissione di garanzia utilizzi più incisivamente le attribuzioni ed i poteri accordati dalla legge, intensificando la propria attività anche in funzione di mediazione e conciliazione dei conflitti. In quest’ottica di applicazione più coerente della legge 83/2000 occorre ad avviso del Governo attuare con maggiore rigore il principio di “rarefazione oggettiva”, richiamando le amministrazioni e le imprese ad una più puntuale osservanza degli obblighi previsti con riferimento all’informazione degli utenti e consumatori in caso di sciopero.
La legge 83/2000 che ha riformato la legge 146/1990 dispone che nei contratti o accordi collettivi concordati per individuare le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero “devono in ogni caso essere previste procedure di raffreddamento e conciliazione obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero”. Appare cruciale che tali accordi, sottoposti alla validazione della Commissione di garanzia per acquistare efficacia generalizzata, contengano effettivamente questo genere di clausole, decisive per dare al conflitto in questi contesti caratteristiche di civiltà.
Nell’ambito della nozione di ‘raffreddamento’ del conflitto appare utile sperimentare l’istituto del referendum, come preventivo accertamento della volontà di tutti coloro che verrebbero chiamati a scioperare dai promotori del conflitto e come condizione quindi per la legittima proclamazione dello sciopero. L’ indizione del referendum – almeno in forma consultiva, senza quindi coinvolgere la questione della titolarità alla proclamazione e all’ esercizio dello sciopero - potrebbe essere proposta dai soggetti interessati alla promozione dello sciopero, congiuntamente o disgiuntamente. Del pari interessante sarebbe la sperimentazione di forme di sciopero virtuale e/o solidale, prevedendo azioni di protesta che, pur comportando il sacrificio economico di ambedue le parti, non producano la sospensione o l’interruzione del pubblico servizio. L’ammontare del sacrificio/danno economico sopportato dalle parti potrebbe essere devoluto ad un fondo gestito bilateralmente dalle parti e la cui utilizzazione verrebbe da esse concordata
Il Governo ritiene che occorra approfondire l’ipotesi di sostituire la Commissione di Garanzia con un organismo specializzato in materia di prevenzione e composizione delle controversie collettive di lavoro, con particolare, ma non esclusiva, competenza nella gestione del conflitto nei servizi essenziali. Occorrerebbe in tale prospettiva valutare anche l’opportunità di dotare questo organismo di professionisti con esperienza nella gestione diretta delle vertenze collettive di lavoro, incaricandolo delle attribuzioni fino ad oggi esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché della stessa Commissione di garanzia per l’esercizio del diritto sciopero nei servizi essenziali.
[1] Per lavoro atipico si intendono qui i rapporti di lavoro a tempo parziale e/o determinato, come tali facilmente identificabili nell’indagine sulle forze di lavoro. Questa classificazione peraltro lascia indefinite, nel senso che non le caratterizza necessariamente né come tipico né come atipico, le collaborazioni coordinate e continuative, che non sono identificabili come tali nell’indagine citata. La crescita delle collaborazioni coordinate e continuative è stata particolarmente marcata: in termini di iscritti alla speciale gestione presso l’INPS si è passati da poco meno di un milione di unità al dicembre 1996 a quasi due milioni al luglio 2001; meno marcata, ma pur sempre notevole, è la crescita dei soggetti per i quali siano stati effettivamente versati contributi alla speciale gestione INPS (e che quindi nell’anno in questione abbiano effettivamente operato e percepito dei redditi come collaboratori), nel cui caso si passa dagli 839mila individui del 1996 ai 1272mila del 1999 (cfr., Ministero del Lavoro, Rapporto di monitoraggio no. 2-2000, Box A1 e no. 1-2001, scheda 12).
[2] In senso opposto aveva invece operato, in tutti gli anni ottanta, la forte crescita del fenomeno del doppio lavoro.
[3] Il Belgio, ove i livelli dell’occupazione dei più anziani erano significativamente più bassi che in Italia, ha evidenziato una tendenza espansiva, mentre l’Italia è riuscita, a partire dal 1998, soltanto a stabilizzare i propri livelli, che oggi l’accomunano sotto il 30% solo a Belgio, Austria, Francia e Lussemburgo.
[4] Più accentuate di quelle medie dell’intero quinquennio 1995-2000 tanto per l’Italia (e il Centro-Nord al suo interno) che per la media UE complessiva.
[5] Le tendenze dell’ultimo quinquennio appaiono peraltro più favorevoli, con un leggero miglioramento relativo del Mezzogiorno in parte da ricollegare alla ripresa dei flussi migratori tra le due aree (il saldo netto dei movimenti da Sud a Nord, pari a 30mila persone all’anno nel decennio 1985-1994 è stato di 80mila persone nel 1999 ed in parte alla migliore performance relativa del PIL meridionale, dopo il picco ciclico del 1995. Quest’ultima, non è peraltro da sopravvalutare. Essa è infatti intervenuta in un momento di difficoltà sui mercati internazionali delle produzioni italiane, comunque largamente localizzate nel Centro-Nord. Avuta presente la condizione ciclica del periodo, più che di un maggior sviluppo del Mezzogiorno, si deve inoltre parlare di una minore frenata di quelle regioni, il cui andamento è comunque tradizionalmente meno dipendente dal ciclo economico.
[6] Il divario è ancor più ampio tra i 25-34enni (10% contro 16,5%) per via del ritardo alquanto elevato con cui in Italia vengono conclusi gli studi: secondo le recenti valutazioni del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), la laurea viene in media conseguita in 7 anni, all’età di 27 anni e mezzo, con un ritardo rispetto alla durata legale del corso universitario tra i due ed i quattro anni.
[7] Tra i 25-34enni si è passati da 10 a 10,9 anni tra il 1991 ed il 1999, a fronte di incrementi di 1,4 e 2,3 anni nei due decenni precedenti.
[8] Va inoltre ricordato che le forme di alternanza tra scuola e lavoro concretamente realizzate hanno spesso fatto ricorso a tipologie contrattuali in linea di principio pensate con altre finalità e con una dote d’incentivazione finanziaria. Con riferimento al caso del Veneto, dove più intenso è il lavoro estivo di chi durante l’inverno frequenti la scuola, si può stimare che circa un quarto degli apprendisti in essere alla fine di luglio (picco stagionale del fenomeno) non è più tra gli occupati a tre mesi di distanza, essendo rientrato (presumibilmente) sui banchi di scuola (cfr., Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Rapporto di Monitoraggio no.2-2000, box B3 e no. 1-2001, scheda 11).
[10] Il dato riportato nella Figura 2, derivante dal set di dati ESSPROS dell’Eurostat, risente ovviamente di peculiarità definitorie. In particolare è da ricordare che la spesa pensionistica include le erogazioni relative al TFR e che i trattamenti pensionistici includono anche quelli operanti a titolo assistenziale (pensioni sociali etc.) a favore dei soggetti più anziani. I prepensionamenti in senso proprio, purché originati da cause economiche, sono invece inclusi nella voce relativa ai trattamenti di disoccupazione. Operando definizioni diverse, ad esempio escludendo il TFR, la connotazione pensionistica della spesa sociale italiana si attenuerebbe, senza però venir meno da un punto di vista qualitativo.
[11] I dati aggiornati del Rapporto di monitoraggio no. 1-2001 evidenziano come tale bassa incidenza non muterebbe neppure includendovi la spesa relativa ai Lavori Socialmente Utili, che per coerenza contabile con gli schemi Eurostat vengono normalmente inclusi tra le politiche attive in quanto schemi di creazione diretta di posti di lavoro: il totale prima citato si eleverebbe di poco meno di un decimo di punto percentuale di PIL (l’ultimo dato di consuntivo riguarda il 1999 e la spesa per LSU si può cifrare in circa 1.500 mld di lire).
[12] Tra gli oneri relativi a CIG e mobilità non è stata inclusa la spesa per gli sgravi all’assunzione dei lavoratori in CIGS e mobilità (classificata tra le politiche attive).
[13] La figura considera i trattamenti ordinari extra-agricoli escludendo la gestione speciale per l’edilizia. Il quadro non muterebbe includendo pure quest’ultima. Il raggiungimento dell’equilibrio finanziario per le indennità ordinarie extra-agricole è stato anche favorito dalla previsione normativa, operante a tutti gli effetti dal 1999, che ha teso ad escludere più nettamente i soggetti dimessisi dal precedente lavoro dalla platea dei beneficiari effettivi.
[14] Nel Rapporto di monitoraggio del Ministero del Lavoro no. 2-2000 si richiama l’attenzione sulle cd ripetente nel ricorso agli ammortizzatori, sull’uso cioè ripetuto nel tempo dei diversi ammortizzatori, facendo particolare riferimento proprio ai trattamenti con requisiti ridotti: vi si stima (cfr. Box B8) che circa la metà dei beneficiari di un anno risulta tra i beneficiari anche l’anno successivo; il 30% circa è tra i beneficiari anche 4 anni dopo.
[15] Per quanto concerne il risultato relativo al 2001 è da ricordare che la spesa per trattamenti ridotti potrebbe essere contenuta dal fatto che l’innalzamento dei trattamenti ordinari definito di recente dal legislatore (dal 30 al 40% della precedente retribuzione) non è stato applicato anche ai trattamenti con squisiti ridotti.
[16] Per maggiori ragguagli si rimanda al Rapporto di monitoraggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , no. 1-2001.
[17] Su tale evoluzione ha influito, da un lato, la normativa nazionale – la cd. legge Treu (L. 196/1997), che ha ampliato l’area di copertura dell’apprendistato in termini di fasce d’età (oggi si va dai 16 ai 24 anni, con possibilità di ulteriore innalzamento nelle aree depresse ed in caso di soggetti con invalidità) ed indicato nell’apprendistato una delle tre forme di assolvimento del cd obbligo formativo nella fascia d’età tra i 15 ed i 18 anni (cfr. oltre). Dall’altro la contestazione comunitaria (con successiva condanna dello Stato italiano) della legittimità della differenziazione degli sgravi previsti dai CFL in relazione all’area geografica, alla tipologia di azienda ed al settore produttivo.
[18] In base alla rilevazione ISTAT sulle forze lavoro dell’aprile 2000, si può stimare che solo il 5,4% dei giovani tra 15 e 24 anni impegnati in contratti a causa mista avessero partecipato ad attività formative vere e proprie nelle 4 settimane precedenti l’indagine (cfr. Rapporto di monitoraggio no. 1-2000). Tra le diverse difficoltà insite nella previsione dell’apprendistato come cursus formativo in senso proprio, il Rapporto di monitoraggio no. 2-2000 evidenziava, a partire dall’esperienza specifica del Veneto, la durata spesso assai breve dei singoli rapporti di lavoro posti in essere, molti dei quali interessano del resto studenti che nella pausa estiva lavorano come apprendisti ma che rientreranno a breve nell’iter formativo della scuola superiore (o dell’università).
[19] Gran parte delle misure ora citate si applicano (in proporzione) anche alle nuove assunzioni a tempo parziale. A queste è esplicitamente diretto lo strumento previsto dal decreto legislativo 61 del 2000, che però è stato utilizzato in maniera estremamente limitata.
[20] Il contributo spetta tuttavia, fermo restando il requisito retributivo, anche per i lavoratori assunti successivamente al 1 dicembre 1997 a seguito di turn-over ed escludendo i casi di licenziamento effettuati nei dodici mesi precedenti all’assunzione.
[21] Sull’entità i entrambi i fattori si veda il Rapporto di Monitoraggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle politiche del lavoro no. 1-2001, scheda 1.
[22] L’esperienza statunitense dell’Earned Income Tax Credit evidenzia come i forti effetti d’incentivazione dell’offerta di lavoro femminile siano stati concentrati nel gruppo delle madri non coniugate, dove i problemi di esclusione sociale e dipendenza dal sistema di welfare erano peraltro concentrati. Nel caso italiano, la minore rilevanza di questo gruppo demografico ovviamente dovrebbe suggerire soluzioni originali.