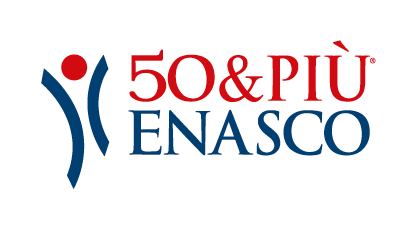IL TESTO DELL'AUDIZIONE IN COMMISSIONE BILANCIO
IL TESTO DELL'AUDIZIONE IN COMMISSIONE BILANCIO
Signor Presidente,
in occasione dell’audizione sul Documento di programmazione economico-finanziaria, osservammo che toccava al disegno di legge finanziaria per il 2005 il compito di dare risposta agli interrogativi che permanevano circa i modi con cui si sarebbe reso compatibile l’impegno per il risanamento dei conti dello Stato con le politiche per lo sviluppo.
Politiche indispensabili per sottrarsi alla trappola della crescita rallentata, all’interno della quale risulta impervio lo stesso percorso di risanamento strutturale della finanza pubblica.
Purtroppo, questi interrogativi neppure ora – a fronte del testo della Finanziaria per il 2005 – trovano, a nostro avviso, una compiuta risposta. Non la trovano, perché le misure che dovrebbero agire ai fini di sostenere tanto la competitività del nostro sistema produttivo, quanto la domanda interna e i consumi delle famiglie sono “rinviate” – ivi compreso l’intervento sulle aliquote IRE e sull’IRAP – a successivi interventi legislativi che, variamente qualificati sotto il profilo tecnico, dovrebbero comunque collegarsi, sul piano sostanziale, ai saldi generali della finanza pubblica, che vengono determinati dal presente disegno di legge finanziaria.
Insomma, sul piano del metodo, ci sembra che rendere più immediatamente e direttamente leggibile il nesso tra le misure volte a contenere entro il 2,7 per cento del PIL l’indebitamento delle pubbliche amministrazioni e ad irrobustire l’avanzo primario - assicurando il pareggio del deficit corrente e la destinazione del maggiore indebitamento all’esclusivo finanziamento della spesa in conto capitale - e gli impegni per l’accelerazione dello sviluppo sarebbe stata una saggia scelta politica.
Una scelta in linea con l’esigenza - fortemente segnalata dal documento unitario sottoscritto, un paio di settimane fa, da tutte le associazioni di impresa - di “coniugare il rigore di bilancio con l’azione di modernizzazione e innovazione della struttura produttiva, offrendo la disponibilità di risorse per gli investimenti pubblici, le infrastrutture – materiali e immateriali – e gli strumenti di sostegno allo sviluppo, ivi comprese le politiche del capitale umano, e alla domanda interna”.
Peraltro, anche una lettura tutta “interna” all’impianto del disegno di legge finanziaria non può non allarmare sia circa l’effettiva conseguibilità del suo obiettivo proprio – l’aggiustamento strutturale dei conti pubblici – sia circa l’agibilità che essa determina per le scelte immediatamente successive volte all’innalzamento del tasso di crescita dell’economia.
Relativamente all’aggiustamento strutturale dei conti pubblici, la nuova “regola aurea” è stata individuata – come è noto – in un approccio che non parte più dalla dinamica della spesa tendenziale, ma dalla situazione attuale di spesa. Rispetto alla quale, si procede poi all’aumento del 2 per cento di tutte le voci di spesa corrente, fatta eccezione per la spesa previdenziale e per altre prestazioni sociali, attesa in crescita nella misura del 3,9 per cento e con una sostenibilità affidata ai contenimenti derivanti dall’applicazione a regime della recente riforma previdenziale e stimati nella misura dello 0,6-0,7 per cento del PIL.
Dal cosiddetto “metodo Brown” dovrebbe derivare “un aggiustamento della spesa corrente (rispetto al tendenziale) pari allo 0,5 per cento del PIL, a cui corrisponde un valore di 6, 2 miliardi di euro”.
Sarà pur così, anche se, in particolare, si dovrà verificare la tenuta del “metodo Brown” alla prova del rinnovo del contratto del pubblico impiego. Ma affidare, per un verso, la sostenibilità della spesa previdenziale all’orizzonte di medio termine degli effetti a regime della riforma del sistema previdenziale e, per altro verso, incrementare la disponibilità di spesa per il Servizio sanitario nazionale - sia pure subordinandola ai principi virtuosi di una futura Intesa tra Stato e Regioni finalizzata al contenimento della dinamica dei costi - non sembra davvero una scelta, di metodo e di merito, coerente con la dichiarata volontà di intervenire in maniera strutturale sull’andamento delle grandi voci della spesa pubblica.
E ciò mentre, ancora, Regioni ed enti locali – e qui siamo nel pieno del paradosso politico e costituzionale di un federalismo senza federalismo fiscale – potranno aumentare le spese finali – correnti e in conto capitale – del 4,8 per cento nel 2005 rispetto all’esercizio 2003, salvo tornare alla regola aurea dell’incremento del 2 per cento a partire dal 2006. Ulteriori spese di investimento saranno comunque possibili, “nei limiti delle maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e di tariffe”, anche in considerazione del fatto che viene meno il blocco delle addizionali regionali e comunali per IRE ed IRAP.
Insomma, già al nastro di partenza, il rigore del “metodo Brown” presenta eccezioni e contraddizioni, che rischiano di risolversi in costi aggiuntivi per le famiglie e per le imprese.
E’ altrove, invece, che il rigore del metodo dispiegherà fino in fondo i suoi effetti :
- sul Fondo per le aree sottoutilizzate, con un limite di pagamento per il 2005 di circa 6,5 miliardi di euro pari alla quota per le sole infrastrutture definita con la delibera CIPE di riparto del Fondo del 29 settembre;
- sul Fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle Attività Produttive, con un limite di pagamento per il 2005 di circa 2,7 miliardi di euro, che riduce di circa 1 miliardo di euro i pagamenti annui effettuati.
Poco male per chi – come la nostra Confederazione – ha sempre denunciato i limiti del tradizionale assetto del sistema degli incentivi. Ma davvero tanto di cui preoccuparsi per chi – come le imprese che la Confederazione rappresenta – attende ora di conoscere se, come, con quali tempi e con quali risorse opererà l’atteso, nuovo Fondo rotativo e si procederà, per il Mezzogiorno, alla “istituzione di una fiscalità di vantaggio”. Strumenti ai quali peraltro tanto il Dpef quanto la Relazione di accompagnamento al disegno di legge finanziaria affidano un ruolo precipuo rispetto al sostegno degli investimenti fissi lordi.
Quanto alle entrate tributarie correnti, la “manutenzione” della base imponibile dovrebbe contribuire ad una loro crescita nella misura del 3,5 per cento del PIL. Ma del nesso, almeno, fra questa manutenzione e quella più volte prospettata riduzione della pressione fiscale ad invarianza di gettito complessivo, sembrano davvero essersi perse anche le ultime tracce in questo disegno di legge finanziaria.
Concorrono alla “manutenzione” della base imponibile :
- le misure per la lotta al sommerso e per il recupero dell’evasione in materia di redditi immobiliari: titolo all’interno del quale sono, tra l’altro, incastonati interventi per la revisione dei valori catastali, una sorta di “minimum tax” per i redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazione e una tassazione dello smaltimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani che prevede, ora, “che il parametro della superficie, cui è commisurato l’importo della tassa, non deve essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale”, senza però tenere conto delle superfici sulle quali si producono rifiuti speciali e di quelle che non possono produrre rifiuti, per destinazioni d’uso o caratteristiche strutturali. Insomma, un quadro di misure, “arricchito” dall’introduzione della polizza assicurativa obbligatoria anticalamità, che colpisce fortemente il bene-casa – “nocciolo duro” del risparmio degli italiani - e che è destinato a ripercuotersi sui valori dei canoni, ivi compresi quei canoni per le locazioni commerciali che già oggi, in molte realtà, hanno raggiunto livelli difficilmente compatibili con l’andamento dei ricavi aziendali. Né mancano ulteriori, stringenti e complessi obblighi di comunicazione a carico degli intermediari del settore immobiliare;
- le misure per il contrasto all’evasione in materia di IVA, nel cui contesto si “segnalano” la riduzione della soglia di volume d’affari minimo per l’obbligo dell’invio telematico della dichiarazione da circa 26.000 euro a 10.000 euro e il recupero dell’obbligo di presentazione degli “elenchi clienti e fornitori”;
- ma soprattutto la pianificazione fiscale concordata e gli interventi concernenti gli studi di settore.
La pianificazione fiscale concordata si realizza attraverso la proposta - formulata dall’Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti rientranti nella platea degli studi di settore – di adesione individuale alla definizione preventiva per un triennio “della base imponibile caratteristica dell’attività svolta”.
Ma di “concordato” – in questa pianificazione – sembra esserci davvero ben poco, poiché il contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione potrà essere attivato “esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare una evidente infondatezza” della proposta di adesione, riferita ai suoi dati di costruzione.
In altri termini, rispetto a quanto si configura come una sorta di accertamento preventivo – costruito tenendo conto “delle risultanze degli studi di settore, dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente” – quest’ultimo potrà “contestare” non il risultato della proposta, ma i suoi complessi presupposti di formulazione, facendo valere e documentando “significative variazioni degli elementi strutturali nell’esercizio dell’attività” rispetto a quelli considerati ai fini della proposta medesima o una sensibile divergenza, all’atto della definizione, di “dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta”.
Il debutto della pianificazione fiscale concordata e gli interventi sugli studi di settore vanno letti insieme. E’, infatti, la lettura del loro “combinato disposto” a chiarire che, senza alcun dubbio, siamo di fronte ad una radicale rottura del patto, della compliance tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, che è stata la filosofia costitutiva dell’esperienza degli studi di settore e che aveva fin qui dato buona prova di sé, consentendo di innescare una rapida crescita della percentuale di contribuenti congrui che, già nel 2000, risultava prossima al 75%.
L’operazione è chiarissima :
- per un verso, si mette sul piatto l’appeal della pianificazione fiscale concordata riconducibile ai “benefici” – qui il virgolettato è davvero d’obbligo – dell’inibizione degli accertamenti, della riduzione di 4 punti – per la parte che eccede il reddito definito – dell’aliquota marginale IRE (esclusa l’aliquota al 23%) e di quella IRES, dell’esclusione – sempre sulla parte di reddito eccedente quello definito – dei contributi previdenziali, comunque versabili in via volontaria;
- per altro verso, si configura l’intervento sugli studi di settore, abolendo – ai fini degli accertamenti in base agli studi – ogni distinzione tra contabilità semplificata e ordinaria, prevedendone una revisione – sentite le categorie economiche – ogni quattro anni, ma soprattutto aggiornandone i risultati ogni anno “con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sulla base delle elaborazioni dell’ISTAT che individuano, in relazione ai dati di contabilità nazionale, indici differenziati per settore, territorio e dimensione dei soggetti interessati”.
Dunque, la struttura, il metodo, la revisione periodica medesima degli studi verrebbero – ogni anno – alterati dall’elemento esterno ed estraneo di “indici” non meglio definiti e, con ogni probabilità, difficilmente definibili. Né può francamente essere considerato significativo il fatto che, ad elaborazioni effettuate, il Direttore dell’Agenzia delle entrate senta le associazioni professionali e di categoria, prima di pubblicare il provvedimento in Gazzetta.
Stiamo infatti parlando di 235 studi di settore e di 1.897 modelli organizzativi che coinvolgono 4 milioni di contribuenti, con una classificazione territoriale diversificata per gli 8.100 comuni italiani. Insomma, una base dati complessa ed articolata che consente di leggere “congruità” dei ricavi e “coerenza” dei costi. Rispetto a questo sistema, non si vede davvero come potrebbero analiticamente interagire i dati di contabilità nazionale ad oggi disponibili, riferiti a circa 50 settori di attività economica e con una apertura territoriale fino al livello delle province.
I dati di contabilità nazionale – tanto per fare un esempio – aggregano l’intero commercio al dettaglio in un solo settore, e lo stesso fanno per il commercio all’ingrosso. Mentre – sempre per procedere ad esempi – ben 8 studi e 198 modelli organizzativi riguardano gli intermediari del commercio, 36 modelli organizzativi indagano le caratteristiche del commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature, 20 modelli organizzativi leggono la realtà del commercio al dettaglio di elettrodomestici, casalinghi, dischi e nastri.
Francamente, non ha senso alcuno – dal punto di vista economico e dal punto di vista di un equo rapporto con il fisco – ricomprendere, ai fini dell’aggiornamento annuale dei risultati degli studi, entro uno stesso indice generale di settore l’intera gamma delle attività del commercio al dettaglio o quella delle attività del commercio all’ingrosso !
Né ha senso alcuno – come invece fa la Relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge finanziaria – mettere a confronto l’andamento dei ricavi teorici da studi di settore con la variazione percentuale della produzione ai prezzi di mercato in euro.
Non ha senso appunto perché questa variazione è resa disponibile dall’ISTAT in riferimento a soli 50 macroindici settoriali, senza distinzione alcuna – sempre per restare nell’area del commercio – tra piccole, medie e grandi imprese, i cui risultati economici si sono ovviamente profondamente differenziati a fronte di un processo strutturale di modifica delle relative quote di mercato.
Non ha senso, ancora, perché la variazione ISTAT richiamata in sede di Relazione è un dato complessivo, rispetto al quale non si dispone di un’apertura specifica concernente le imprese con ricavi fino a circa 5 milioni di euro, che costituiscono invece la platea propria di applicazione degli studi di settore.
Insomma, l’alternativa rispetto alla quale il Governo, ma ora anche il Parlamento, sono chiamati a scegliere è netta : o si recupera fino in fondo la filosofia e la struttura degli studi di settore – strumento per l’accertamento dei ricavi e non del reddito - o si getta via un’esperienza – quella di quasi 250 studi che coinvolgono 4 milioni di contribuenti - che ha mostrato, negli anni, la capacità di agire costruttivamente ai fini del rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuenti.
Perseguendo, nei fatti, una sorta di “catastizzazione” del reddito, che cozza clamorosamente con i principi costituzionali e dello Statuto del contribuente in materia di verifica della attualità ed effettività della capacità contributiva, ma che – intanto – dovrebbe assicurare, nel solo 2005, maggiori entrate per 3,8 miliardi di euro.
Per queste ragioni, abbiamo apprezzato la disponibilità manifestata dal Ministro Siniscalco a riesaminare l’architettura dell’intervento prospettato per gli studi di settore, con particolare riferimento all’ipotesi dell’intervento ISTAT. E’ un buon punto di partenza per riaprire un confronto reale, cioè senza pregiudiziali, con le categorie economiche.
Del “contratto” con gli italiani, sottoscritto dalle forze politiche che compongono l’attuale maggioranza parlamentare, il cardine era e resta la riduzione della pressione fiscale. Nulla dice, al riguardo, questo disegno di legge finanziaria, rinviando ai futuri provvedimenti in materia di fiscalità e di competitività.
Ma, intanto, questo disegno di legge finanziaria dice a chiarissime lettere alle piccole imprese, al mondo del lavoro autonomo, al popolo delle partite IVA che a loro tocca l’onere fondamentale di assicurare allo Stato, attraverso la “manutenzione” della base imponibile, entrate per circa 7, 5 miliardi di euro e che, al contempo, dovranno fare i “conti” con il fisco delle Regioni e degli enti locali e con una drastica riduzione del sistema degli incentivi.
La riduzione dell’indebitamento pubblico dell’1,7 per cento del PIL – con minori spese nell’ordine dello 0,7 e maggiori entrate nell’ordine dello 0,6 del PIL – si ripercuoterà inevitabilmente sulla domanda, su un mercato interno profondamente segnato dalla prolungata crisi dei consumi.
In questo contesto, diviene francamente poco efficace la stessa azione di “moral suasion” dei protocolli di concertazione territoriale, che avrebbero dovuto contribuire al rafforzamento del potere d’acquisto, coinvolgendo impegni e responsabilità dei settori economici che intervengono nella filiera che va dalla produzione alla distribuzione finale ai consumatori, ma anche impegni e responsabilità di Stato, Regioni ed enti locali in materia di andamento della pressione fiscale e di politiche tariffarie anti-inflazionistiche.
La fiducia nelle scelte per la riduzione della pressione fiscale e per la competitività non si è ancora esaurita, ma certo essa sta rapidamente scemando di fronte ad un disegno di legge finanziaria che non manca di intervenire anche sulla tassazione dei tabacchi, sulle ritenute sulle vincite del Lotto e prospettando un’ipotesi di pedaggio che “potrebbe riguardare in prospettiva circa 1.500 Km di strade statali tra quelle in esercizio e quelle in costruzione”.
Faccia presto il Governo, faccia la sua parte il Parlamento. Perché – invece - di fiducia, di certezze le imprese, le famiglie, il mercato hanno oggi più che mai bisogno.